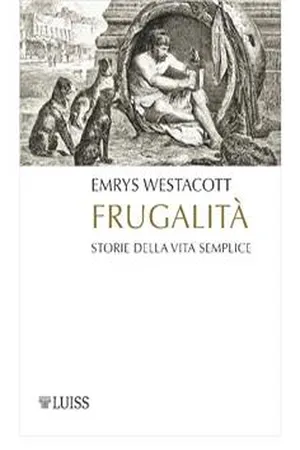![]()
CAPITOLO TERZO
Perché si pensa che la vita semplice ci renda più felici
Come già osservato, la distinzione tra ragioni morali e prudenziali per esaltare la vita semplice non è né netta, né decisiva. Molti dei filosofi fautori di uno stile di vita semplice appartengono alla tradizione dell’etica della virtù; nella loro ottica, le qualità e le abitudini che ci rendono persone migliori e quelle che ci rendono più felici (da intendersi come autorealizzazione in senso lato) generalmente coincidono. Tuttavia, la filosofia moderna su questo punto è solita fare un distinguo e noi l’abbiamo utilizzato per aiutare a discernere e chiarire l’esatta natura degli argomenti a favore della vita semplice che stiamo prendendo in considerazione.
Gli argomenti prudenziali che prenderemo in esame in questo capitolo, così come gli argomenti morali discussi nel capitolo precedente, sono tutt’altro che nuovi. Nella filosofia occidentale la maggior parte di essi furono messi in campo già oltre duemila anni fa, in particolare dai pensatori epicurei e stoici; in seguito sono stati sistematicamente avallati da un folto gruppo di scrittori medievali e moderni, e continuano a essere proposti in una gran quantità di manuali che propugnano la semplicità frugale.
Una premessa fondamentale di tutti questi argomenti è che la felicità è un bene che in teoria ogni essere umano desidera per sé stesso. Questa è la visione difesa da Aristotele, John Stuart Mill e da innumerevoli altri filosofi, sia antichi che moderni. Qua e là ci si imbatte in voci dissenzienti, come ad esempio Nietzsche o Dostoevskij, ma ciò che essi sostengono riguarda solo una sparuta minoranza, oppure confonde il “desiderare la felicità” con il “desiderare esclusivamente la felicità”, o ancora con il “desiderare la felicità sopra ogni altra cosa”. La maggior parte delle persone accetta senza riserve il presupposto che la felicità sia apprezzabile. Ciò che ci interessa in questa sede sono le varie ragioni che i filosofi hanno addotto a sostegno dell’idea che vivere in semplicità aumenti la probabilità di essere felici.
la vita semplice favorisce la virtù, che a sua volta favorisce la felicità
Nel capitolo precedente abbiamo passato in rassegna diverse ragioni per credere che vivere in semplicità porti dei benefici morali. Questa concezione costituisce la prima premessa di questo argomento. La seconda premessa, che le persone moralmente buone saranno più felici per effetto della loro virtù, è stata a sua volta discussa all’inizio dello stesso capitolo. Alcuni l’hanno supportata invocando un concetto di giustizia universale: la legge del karma o la dispensazione divina di ricompense e punizioni, in questa o nella prossima vita. Altri hanno affermato che la virtù morale porta naturalmente in sé i germi della felicità. Platone, per esempio, sostiene che l’integrità morale dell’individuo virtuoso instaura una sorta di armonia interiore che lui contrappone alla disarmonia manifestata dal malvagio. Dal momento che una persona non può esimersi dallo sperimentare questa condizione interiore a un qualche livello, il virtuoso sarà fondamentalmente felice, mentre chi non è virtuoso sarà inevitabilmente insoddisfatto. La conclusione di Platone è stata supportata dalla maggior parte dei pensatori classici venuti dopo di lui. In particolare, gli stoici rimarcano con insistenza l’importanza suprema della virtù morale sopra ogni altro bene. Così Marco Aurelio, facendo eco a Socrate, sottolinea che l’unico danno che si può subire è il danno al proprio carattere, mentre Seneca sostiene che “soltanto la virtù procura una gioia stabile e sicura”.
I cinici più irriducibili possono pensare che sia facile ridurre tutto questo a una sorta di pia illusione. Ma di fatto questa visione – che le persone buone dovrebbero quasi sempre essere considerate più felici di quelle che difettano di virtù morali – è molto plausibile. Confrontate due persone: Jill, che si rallegra di cuore di un successo di un collega, e Jane, che prova un piacere intenso di fronte al fallimento di un collega. Chi preferireste essere? La maggior parte di noi, ovviamente, sceglierebbe di essere Jill. Una ragione ovvia alla base di questa scelta è che la consideriamo la persona migliore. Ma se mettessimo da parte le considerazioni morali? Ammettiamo pure che Jill sia la persona più ammirabile, ma chi riteniamo sia più piacevole essere? Il pensiero di Platone suggerisce che la condizione di Jill è anche la più invidiabile. Una ragione ovvia è che, essendo una persona migliore, è probabile che Jill abbia più amici, amici migliori, che sia più sicura del loro affetto e che viva relazioni non macchiate dal risentimento. Ma una ragione più sottile, non così facile da formulare, è che il piacere benevolo che Jill prova per la fortuna di un’altra persona è superiore – e non solo in termini morali – al godimento malevolo derivato dal fallimento di un collega. Ovviamente non è così facile astrarre questo senso di superiorità non-morale dai suoi orpelli morali. Non è una questione di intensità o durata del piacere, ma forse il concetto è reso piuttosto bene dalla metafora dell’armonia interiore di Platone, una metafora che va al di là di un particolare momento di piacere, per abbracciare l’esperienza totale di una persona. Gli individui egocentrici, crudeli e malevoli non sono mai a proprio agio – in armonia – con sé stessi o il mondo, motivo per cui non riescono mai a raggiungere una soddisfazione durevole. Nelle persone benevole, al contrario, c’è meno conflittualità tra ciò che sentono effettivamente e ciò che perlomeno una parte di loro pensa che dovrebbero sentire. Inoltre, c’è meno discrepanza tra ciò che vivono come loro realtà interiore e il modo in cui si mostrano al mondo.
la vita semplice permette di lavorare meno e di avere più tempo libero
Quanto più si vive in maniera frugale, tanto meno si ha bisogno di denaro e tanto più è probabile che si risparmi. In ogni caso una vita frugale ridurrà il bisogno di lavorare, aumentando il tempo libero e di conseguenza la felicità. Il ragionamento è lineare. Tuttavia è interessante considerare i vari modi in cui il lavoro, il tempo libero e il loro rapporto con la felicità siano stati concepiti all’interno della tradizione filosofica che stiamo esaminando, e vale la pena chiedersi fino a che punto l’atteggiamento critico nei confronti del lavoro all’interno della suddetta tradizione sia valido ancora oggi.
Il concetto di tempo libero ha più di un significato o di un’associazione. Una vita svincolata da impegni potrebbe essere concepita come essenzialmente indolente: ci si alza tardi e si trascorre il pomeriggio ammollo in piscina, sorseggiando Margarita. O può suggerire forme di ricreazione più attive: “attività del tempo libero” come lo sport, il gioco, il giardinaggio, attività artistiche, trekking sulle Ande e così via. Ciò che queste attività hanno in comune è la libertà dal lavoro, in particolare dal lavoro che si fa per procurarsi più di quanto sia necessario per sbarcare il lunario. Per non sbagliarci, mettiamo in contrapposizione il tempo libero e il lavoro anche quando una persona dispone di mezzi sufficienti per vivere senza lavorare, o quando il lavoro coincide con ciò che la persona sceglierebbe comunque di fare. In questi casi consideriamo il tempo libero come tempo ricreativo. Ma il significato basilare del tempo libero, un concetto che risale all’antica Grecia, è quello di un tempo in cui si è liberi di scegliere cosa fare, liberi dal dover svolgere un lavoro noioso, un semplice mezzo per un fine. Per Aristotele, il tempo libero così inteso è un prerequisito della buona vita, perché è ovvio che attività scelte liberamente e intraprese per il gusto di farle – ad esempio lo studio, lo sport o la conversazione – siano più gradevoli e appaganti rispetto al lavoro che svolgiamo per necessità o semplicemente per assicurarci qualcos’altro, come ad esempio uno stipendio.
Mentre il tempo libero è visto quasi universalmente in maniera positiva, l’atteggiamento nei confronti del lavoro è variato di molto nel corso del tempo e a seconda delle culture. Nella maggior parte delle società, le classi elevate l’hanno generalmente guardato dall’alto in basso. Non dover lavorare per vivere era ciò che tradizionalmente le distingueva dal resto della società; così consideravano una sventura l’essere costretti a lavorare e vergognosa la maggior parte dei lavori manuali, nel senso che avrebbero provato vergogna se avessero dovuto ridursi a farli. Questa è la visione condivisa, per esempio, dalle classi sociali elevate dell’antica Grecia, della Cina prerivoluzionaria e dell’Europa del Diciannovesimo secolo. Ma è tutt’altro che universale. Il giudaismo, l’islamismo e il cristianesimo ufficialmente rispettano e incoraggiano il lavoro, in quanto mezzo per evitare la miseria, dato che come dice la Bibbia, “chi lavora la sua terra avrà pane in abbondanza”. Anche i membri delle classi agiate possono arrivare in qualche misura ad abbracciare un’etica del lavoro e trovarsi qualcosa da fare – supervisionare le proprietà, mettersi al servizio del bene comune, impegnarsi nella beneficienza, praticare delle arti e delle attività artigianali – dato che “l’ozio è il padre di tutti i vizi”.
Oggi siamo bombardati da entrambi i messaggi in maniera confusa e continuativa. Tutte le scuole prospettano il duro lavoro come la chiave del successo, i supermercati eleggono “l’impiegato della settimana”, e tra i lavoratori di tutti i livelli sociali e professionali è molto più frequente sentire persone che si vantano del loro duro lavoro, che persone che si vantano della quantità del loro tempo libero. Eppure, dall’altro lato, la nostra società continua a sventolare davanti ai nostri occhi quale premio finale il sogno di diventare uno dei pochi privilegiati che, grazie alla fortuna, all’azzardo, all’intelligenza o al lavoro, non avrà più bisogno di lavorare e potrà rilassarsi e svagarsi. Ovviamente entrambi i messaggi possono essere asserviti al sistema economico. I proprietari di capitali che impiegano altri per produrre merci e servizi venduti a scopo di lucro traggono beneficio dal fatto che le persone credono che un lavoratore indefesso sia una buona persona e che la buona vita implichi innanzitutto guadagnare e spendere soldi.
In genere i fautori della semplicità frugale apprezzano molto il tempo libero. Tuttavia ce ne sono alcuni che lo guardano con sospetto. L’antico poeta greco Esiodo, contrapponendosi al disprezzo per il lavoro da parte delle classi elevate, dichiara che è l’ozio e non il lavoro a essere vergognoso. La regola di San Benedetto recita che dal momento che “l’ozio è nemico dell’anima”, i confratelli dovrebbero tenersi occupati con lavori manuali e letture devote. Ben Franklin, che considera il tempo trascorso in maniera improduttiva come tempo sprecato, avverte che “la pigrizia rende tutto difficile, e l’industria tutto facile”.
All’altro estremo si trovano coloro che esaltano l’assoluta inattività.
Che vita è mai questa se, pieni d’impegni,
non abbiamo tempo di soffermarci a guardare?
si chiede il poeta vagabondo William Henry Davies. Wordsworth difende lo starsene seduti da soli su una pietra a sognare per mezza giornata affermando
che possiamo nutrire questa nostra mente
in una saggia passività.
E Thoreau, in un passaggio citato in precedenza, si vanta di non fare nulla tutto il giorno, se non starsene seduto al sole a fissare il suo laghetto. In realtà, però, la maggior parte dei sostenitori dell’ozio tende a considerarlo positivo per qualche aspetto. Perfino Wordsworth, quando se ne sta seduto su una pietra, sta “nutrendo” la sua mente. L’inattività ricarica le batterie; rende possibile apprezzare il momento presente; aiuta a essere ricettivi nei confronti di tutto ciò che c’è d’interessante, bello o istruttivo intorno a noi. I filosofi, ovviamente, elogiano l’inattività in quanto facilita la riflessione. Seneca, ad esempio, critica ferocemente l’“esistenza da formiche” dei più, le cui vite di “irrequieta indolenza” non lasciano spazio alla riflessione. “Le sole persone veramente libere” sostiene “sono quelle che si prendono tempo per la filosofia”.
Nei tempi moderni l’etica del lavoro è stata oggetto di numerose critiche; esiste un’illustre tradizione di scritti orientati in tal senso, molti dei quali volti a mostrare la follia del lavoro eccessivo e a ribadire il valore del tempo libero. Paul Lafargue, scrittore del tardo Novecento, criticò il modo in cui gli slogan del movimento operaio, pur con le migliori intenzioni, con il loro inneggiare al “diritto al lavoro” e alla “dignità del lavoro” predicavano valori che in definitiva servivano gli interessi della borghesia, più che quelli della classe operaia. Il lavoro, afferma nel Diritto alla pigrizia, non dovrebbe essere altro che “un piacevole condimento della pigrizia”. Bertrand Russell condivide questo modo di vedere. “L’etica del lavoro è l’etica degli schiavi” scrive “e il mondo moderno non ha bisogno di schiavi”. L’etica del lavoro è antiquata, afferma Russel, perché la tecnologia che sopperisce al lavoro dovrebbe garantirci la possibilità di soddisfare tutti i nostri bisogni, riducendo notevolmente le ore trascorse a svol...