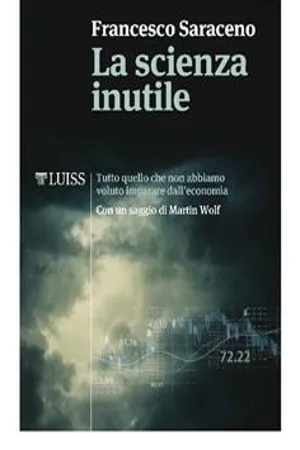![]()
Capitolo 1
Equilibrio ed efficienza: la scuola neoclassica
“Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même”
(attribuito a Vincent de Gournay, circa 1758)
La teoria neoclassica nasce nella seconda metà del Diciannovesimo secolo in reazione alla scuola classica di Smith, Ricardo e Marx. Obiettivo principale degli economisti classici era di spiegare il processo di riproduzione e di crescita del sistema capitalista, le cui potenzialità erano diventate evidenti durante la rivoluzione industriale. Indipendentemente dalle differenze di classe sociale e di opinione politica, gli economisti classici avevano la stessa visione sulle leggi fondamentali che governano l’economia, e tentarono per la prima volta nella storia del pensiero economico di creare un ‘modello’ coerente e generalizzato della crescita, della determinazione dei prezzi e della distribuzione del reddito.
La distribuzione del reddito in particolare è spiegata, nel modello classico, dal contesto sociale. Le classi sociali sono definite dalla proprietà dei mezzi di produzione (la terra per i proprietari fondiari, il lavoro per i lavoratori, e il capitale per i capitalisti) e sono in lotta tra loro per appropriarsi del ‘surplus’, ossia di quello che resta della produzione totale una volta che siano stati assicurati il rimborso del capitale utilizzato per la produzione e la sussistenza dei lavoratori. È importante notare che per gli economisti classici la nozione di sussistenza non è biologica, ma storica e culturale, e dipende tra le altre cose dal potere di negoziazione dei lavoratori. Il livello dei salari, e la distribuzione in genere, sono dunque determinati dal conflitto tra classi sociali per l’appropriazione del surplus.
Due elementi spiegano la crisi della scuola classica: in primo luogo, alcune difficoltà interne di ordine teorico concernenti principalmente la determinazione del reddito di sussistenza e più generalmente del valore dei beni. Queste difficoltà saranno risolte solo con i lavori di Piero Sraffa (1960) quasi un secolo dopo. In secondo luogo, ai problemi teorici si aggiunsero evoluzioni politiche che erano in contraddizione con l’impianto concettuale proprio degli economisti classici. Le tensioni sociali che avevano iniziato a scuotere l’Europa dalla fine delle guerre napoleoniche suffragavano l’idea che la lotta di classe fosse inerente a qualunque processo economico. Il movimento socialista degli anni Quaranta dell’Ottocento traeva la sua legittimità dai lavori di Ricardo, e ovviamente di Marx, che vedevano nel conflitto di classe la modalità normale di funzionamento della società capitalistica. Il processo di normalizzazione, iniziato nel 1848 dopo la ‘primavera dei popoli’, aveva bisogno di un quadro di riferimento teorico alternativo e meno conflittuale. L’abbandono del concetto di classe sociale, in favore di una nuova teoria incentrata su individui mossi dal loro personale interesse rispondeva a questo bisogno. Questo, insieme all’impetuoso sviluppo delle scoperte scientifiche del Diciannovesimo secolo, costituisce il contesto in cui emergerà la teoria neoclassica. È interessante notare che l’abbandono del paradigma classico non segue in senso stretto i canoni kuhniani, non essendoci un’accumulazione di anomalie empiriche, ma piuttosto una pressione sociale in favore di una teoria meno destabilizzante (Signorino, 2005) che si aggiunge alle difficoltà teoriche del paradigma. Questo dimostra che nelle scienze sociali i fattori esterni alla teoria possono giocare un ruolo importante quanto quelli interni, nel determinare le fortune di un paradigma.
1.1. i pilastri: metodo scientifico e individualismo metodologico
Se la teoria classica aveva come programma di ricerca la determinazione della ‘ricchezza delle nazioni’ e della sua distribuzione tra le classi sociali, la teoria neoclassica ha un programma radicalmente diverso: la determinazione, da un lato, delle leggi che governano il comportamento degli individui e, dall’altro, delle determinanti dei prezzi di equilibrio dei beni. Fin dall’origine, con Jevons (1871), Menger (1871), Walras (1874) e Edgeworth (1881), la teoria neoclassica si fonda su due pilastri metodologici che possono essere considerati, viste le forme diverse che la dottrina ha preso successivamente, come la base comune a tutti gli esponenti di questa scuola: il primo è l’individualismo metodologico; il secondo è il metodo scientifico, radicato nel positivismo e nella sua fiducia nel progresso tecnico e scientifico come motore principale dello sviluppo sociale.
Il concetto d’individualismo metodologico è stato oggetto di numerose controversie tra i filosofi, gli economisti e i sociologi. Qui basterà ricordarne la definizione più semplice: l’agente razionale (homo œconomicus) costituisce il fondamento dell’analisi del comportamento delle società, le quali esistono soltanto in virtù degli individui che le compongono. Le scienze sociali dunque possono, e devono, studiare i comportamenti aggregati come semplice somma di decisioni e di azioni individuali di agenti detti ‘rappresentativi’, senza tener conto di quelle che sono chiamate le proprietà emergenti, ossia le dinamiche sociali generate dall’interazione tra individui.
Il metodo scientifico, nella sua definizione più semplice, è un processo in tre tappe in virtù del quale: (1) si costruisce una teoria partendo da postulati fondamentali; (2) si traggono da essa con processo deduttivo conclusioni normative e positive; (3) se ne sottopongono le conclusioni a un processo di confutazione (o falsificazione empirica) dove i fatti sono messi a confronto con la teoria che si ritiene debba spiegarli. Il metodo scientifico è un pilastro delle scienze naturali come la fisica e la chimica, che nella seconda metà del Diciannovesimo secolo conoscono uno sviluppo impetuoso, proprio quando la dottrina neoclassica muove i primi passi. Esso appare quindi adatto allo scopo di quegli economisti preoccupati di spogliare la loro disciplina da ogni connotazione sociale per edificarla su leggi della natura, non assoggettate a condizioni storiche e sociali potenzialmente eversive:
Alla fine del secolo scorso, gli economisti riponevano grandi speranze nel tentativo di trasformare infine l’economia in una ‘scienza esatta’. Secondo eminenti teorici, lo sviluppo della dottrina dell’utilità e del valore aveva consentito di fondare l’economia scientifica su concetti esatti, e presto sarebbe stato possibile erigere su queste nuove fondamenta, una solida struttura di elementi interconnessi, la cui precisione ed efficacia avrebbero evocato la severa bellezza delle scienze matematico-fisiche (Moore, 1914, pp. 84-85).
Dalla nozione di utilità gli economisti neoclassici derivano leggi comportamentali individuali (offerta e domanda), applicabili a tutti gli agenti razionali. A partire dai fondamentali quali le preferenze (o utilità) per i consumatori o la tecnologia per le imprese, l’homo œconomicus massimizza la propria utilità uguagliando al margine i costi e i benefici di una qualsiasi azione.
Nel quadro del modello neoclassico gli agenti prendono le loro decisioni su mercati di concorrenza pura e perfetta; ossia mercati nei quali ogni agente è troppo piccolo per avere un impatto sul sistema economico nel suo insieme, e può quindi prendere le proprie decisioni senza tener conto degli altri agenti.
Gli agenti rappresentativi, siano essi imprese o consumatori, massimizzano la propria utilità sotto certi vincoli (ad esempio il valore degli acquisti dei consumatori non può essere superiore al loro reddito). La teoria parte dal principio che i beni possono essere intercambiabili nel paniere dei consumatori e, allo stesso modo, la produzione può essere ottenuta attraverso differenti combinazioni di fattori di produzione (in genere, lavoro e capitale). Così, in funzione dei prezzi osservati e delle dotazioni (di beni e di fattori di produzione) di cui dispongono prima dello scambio, consumatori e imprese comporranno i panieri desiderati di beni che massimizzano la loro utilità o il loro profitto. Questa massimizzazione genera offerte e domande per ogni individuo e per ogni impresa (di beni, di lavoro, di capitale…). Per ogni bene o fattore di produzione, l’offerta e la domanda della società nel suo complesso risultano semplicemente dall’aggregazione delle scelte di singoli agenti.
La teoria ricorre poi a un agente fittizio, il ‘banditore’; questi è un ‘meta-agente’ che ha la funzione d’imitare il funzionamento di mercati che operano allo scopo di assorbire gli squilibri tra domanda e offerta desiderate. Per ogni bene, un eccesso di domanda o di offerta comporterà un aggiustamento del prezzo al rialzo o al ribasso da parte del banditore (il primo a schematizzare il funzionamento dei mercati come se fossero mercati d’asta è Walras, 1874). Questo processo di aggiustamento graduale (Walras utilizza il termine tâtonnement) si conclude quando il banditore annuncia l’insieme (il vettore) di prezzi per il quale esiste un equilibrio tra domanda e offerta su tutti i mercati; solo allora le transazioni possono essere effettuate, lo scambio non avvenendo mai a prezzi non di equilibrio.
1.2. efficienza del mercato e piena occupazione
La teoria neoclassica si caratterizza per due risultati teorici principali, che hanno influenzato gran parte della ricerca in economia fino ai giorni nostri: l’esistenza dell’equilibrio, e la sua ottimalità.
L’esistenza dell’equilibrio è dimostrata per la prima volta da Walras (1874). Si può dimostrare che, imponendo delle restrizioni ragionevoli sulla forma delle funzioni di utilità che descrivono le preferenze dei consumatori, esiste un vettore di prezzi tale che in tutti i mercati offerta e domanda siano in equilibrio. In altri termini, il processo di tâtonnement descritto sopra condurrà il banditore ad annunciare un insieme di prezzi di equilibrio, per cui cioè, in ogni mercato, la somma delle domande individuali sarà uguale alla somma delle offerte individuali.
L’economista Vilfredo Pareto nel 1896 enunciò i cosiddetti ‘teoremi fondamentali del benessere’, che presi insieme provano l’ottimalità dell’equilibrio walrasiano. Il primo teorema dimostra che, una volta verificate una serie d’ipotesi sul funzionamento dei mercati, l’equilibrio walrasiano è ottimale in senso paretiano (si usa anche chiamarlo ‘efficiente’): nessun attore economico può vedere aumentare la propria utilità senza che l’utilità di un altro sia ridotta. Raggiungere l’efficienza paretiana richiede tre condizioni: l’assenza di rendite, l’assenza di frizioni (o rigidità) e l’assenza di esternalità. Un esempio tipico di rendite è quello associato al potere di mercato. Le imprese che operano in situazione di monopolio (o di oligopolio) possono approfittarne per aumentare i prezzi ed estrarre così delle rendite dallo scambio con i consumatori, allontanandosi di fatto dall’ottimo di Pareto. Allo stesso...