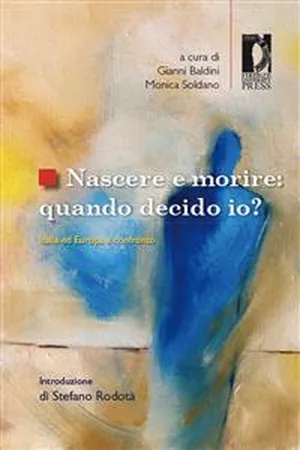L’aborto farmacologico in Italia, venti anni dopo le prime esperienze europee – Carlo Flamigni e Corrado Melega
1. Il mifepristone e l’aborto farmacologico
Poiché l’impianto dell’uovo e tutte le prime fasi della gravidanza dipendono soprattutto dal progesterone, l’ormone steroideo che è prodotto dal corpo luteo gravidico e poiché l’azione di quest’ormone è mediata dal suo legame con un recettore specifico, presente soprattutto sulle cellule della mucosa e della muscolatura dell’utero, è possibile impedire l’impianto e interferire con l’annidamento e lo sviluppo dell’embrione somministrando un progestinico, che esercita effetti di inibizione nei confronti dell’ormone naturale, essendo in grado di competere con lui per i suoi recettori, senza esercitare successivamente alcuna azione progestazionale. Sono stati studiati, sperimentalmente, un grande numero di steroidi antiprogesteronici e uno di essi, il mifepristone o RU486, si è dimostrato molto efficace nell’interruzione delle gravidanze iniziali ed è utilizzato oggi, in molti paesi, a questo specifico scopo.
Il mifepristone fu indicato, nelle prime esperienze, con la sigla RU38486, poi abbreviata in RU486 dall’azienda produttrice: è utilizzato nei primi 56 giorni di amenorrea, comunemente in associazione con le prostaglandine, che servono per l’espulsione del prodotto del concepimento, dopo che la gravidanza è stata interrotta. In questo modo è possibile ottenere l’aborto in un’elevata percentuale di casi senza poi dover eseguire interventi chirurgici complementari. Dalla scoperta del mifepristone sono state sperimentate molte centinaia di molecole simili, che possono esercitare attività agoniste (PAs), antagoniste (SPRMs) o modulatrici (sia agoniste che antagoniste) nei confronti del progesterone, tutte capaci di modificare la conformazione del recettore. Possiedono una struttura molecolare abbastanza simile a quella del mifepristone, l’onapristone e l’asoprisnil, due composti ancora in fase sperimentale. Esistono anche antagonisti recettoriali non steroidei, non ancora presi in esame dal punto di vista dell’efficienza clinica.
2. RU486, storia di un farmaco
Il mifepristone è stato sintetizzato dai ricercatori francesi della Roussel Uclaf nel 1980, nel corso di studi sugli antagonisti dei recettori per i glucocorticoidi. I test clinici relativi alle sue proprietà abortive sono cominciati nel 1982 e nel 1988 il Ministero della Sanità francese ne approvò l’uso, in combinazione per una prostaglandina, con il nome di Mifegyne. Ottenuta la licenza, ma prima che il farmaco fosse messo in vendita, la Roussel Uclaf ne annunciò il ritiro, motivandolo con le forti pressioni subite da parte dei movimenti pro-vita che minacciavano di boicottare tutti i farmaci prodotti dall’industria. Due giorni dopo, il governo francese, comproprietario della Roussel Uclaf, intervenne in favore della ripresa della produzione e della distribuzione del farmaco. Il ministro della salute Claude Evin, un socialista, in quella occasione, dichiarò: «Non posso permettere che il dibattito sull’aborto privi le donne di un prodotto che rappresenta un progresso della medicina. Dal momento in cui il Governo francese ne ha approvato l’impiego, l’RU486 è diventato di proprietà morale delle donne».
Nel 1990 un gruppo di ricercatori dell’ospedale Necker di Parigi, dopo aver controllato i risultati riguardanti l’uso del farmaco in 30.000 donne, chiese al governo francese di ritirarlo urgentemente perché l’incidenza degli effetti collaterali sfavorevoli era molto elevata: questa richiesta indusse il Ministero della salute a stilare nuove linee guida che ridussero notevolmente l’incidenza delle complicazioni.
L’Italia non è mai stata considerata un mercato attraente per la pillola abortiva, secondo esplicite dichiarazioni dell’Exelgyn, la casa farmaceutica che lo produce, che ha sempre lamentato una sin troppo palese ostilità del Vaticano. Etienne Baulieu, il ricercatore al quale si deve la sintesi del mifepristone, ha dichiarato in un recente convegno medico: «Quindici anni or sono ho cominciato a parlare della pillola col Vaticano e con l’allora cardinale Ratzinger. I contatti sono continuati, ma il dialogo non ha fatto passi avanti perché dalla Santa Sede ci è sempre stato detto che la vita va salvaguardata fin dal primo istante. Noi abbiamo cercato di far capire che questo era un modo di far soffrire meno le donne».
Il mifepristone è stato approvato negli Stati Uniti dalla FDA, nella seconda parte della sottosezione H, che riguarda i farmaci per i quali non solo esistono restrizioni nell’uso per ragioni di sicurezza, ma per i quali è anche richiesta una sorveglianza dopo la messa in commercio per verificare che i risultati ottenuti nelle sperimentazioni cliniche siano confermati da quelli riguardanti l’impiego generalizzato per l’induzione dell’aborto farmacologico. L’impiego è limitato ai primi 49 giorni di gravidanza.
Nel 2004, più del 9% degli aborti eseguiti negli Stati Uniti, sono stati praticati utilizzando il mifepristone.
Nel 2005 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito l’RU486 nella lista dei farmaci efficaci, con raccomandazione 1 e con evidenza A: la raccomandazione 1 è una raccomandazione definita ‘forte’ che garantisce che i benefici sono superiori ai rischi e che il farmaco si adatta praticamente a tutte le pazienti; l’evidenza A suggerisce l’esistenza di prove inconfutabili che dimostrano o confermano le grandi qualità del farmaco.
In Europa solo Irlanda e Polonia hanno vietato l’uso del farmaco. Se si fa riferimento agli aborti eseguiti entro le prime 9 settimane di gravidanza, risulta evidente come l’uso del mifepristone sia particolarmente diffuso: più del 42% in Francia, 42% in Inghilterra e nel Galles, 77,8% in Scozia, 60,6% in Svezia, più del 60% in Danimarca.
Nelle altre parti del mondo l’approvazione dell’uso del mifepristone è relativamente recente, mentre in alcuni altri paesi l’approvazione è ritardata da ostacoli giuridici e per molti di essi mancano ancora riferimenti clinici relativi alla frequenza dell’impiego e ai risultati ottenuti.
3. L’aborto farmacologico
Dal punto di vista chimico il mifepristone ha una struttura abbastanza simile a quella del progesterone e dei glucocorticoidi ed è derivato da un 19-nor-steroide, il noretisterone o noretindrone. Queste molecole, che prendono il nome dal fatto di essere prive del gruppo metilico in posizione 19, sono un elemento di passaggio nella trasformazione degli androgeni, gli ormoni steroidei maschili, in estrogeni, una trasformazione che ha luogo soprattutto nell’ovaio: come conseguenza è rintracciabile, tra i loro effetti biologici, qualche residua attività androginica che, ai dosaggi più elevati, si esprime con la comparsa di un po’ di acne e di seborrea.
La biodisponibilità del mifepristone è pari al 30-56%: somministrato per via orale, si lega all’albumina e a una glicoproteina, e le sue concentrazioni plasmatiche raggiungono i massimi livelli dopo circa un’ora, se le dosi somministrate non superano gli 800 mg. La vita media del farmaco varia da 24 a 25 ore e la escrezione è prevalentemente fecale.
L’RU486 (o RU38486) si lega ai recettori per il progesterone con un’affinità 5 volte superiore a quella dell’ormone naturale. Una volta legato il recettore adotta una conformazione inattiva e tende a interagire con i co-repressori inducendo la perdita della capacità di trascrizione. Il mifepristone determina dunque una down-regulation dei geni progesterone-dipendenti con necrosi della decidua, cioè di quel particolare tessuto in cui si trasforma l’endometrio per accogliere l’uovo fecondato, determinando così il distacco del prodotto del concepimento; oltre a ciò, agisce sui vasi endometriali, diminuendo l’irrorazione del tessuto, aumenta l’eccitabilità della muscolatura miometriale e causa dilatazione del canale cervicale.
Tra le azioni biologiche esercitate dal mifepristone, le principali riguardano la riduzione dei flussi mestruali, che possono scomparire per tutto il periodo della somministrazione. Questo effetto è determinato dall’azione antiproliferativa del farmaco, il cui meccanismo di azione non è stato completamente chiarito, e dall’inibizione dell’ovulazione. In particolari circostanze e soprattutto nei trattamenti di lunga durata, il mifepristone ha dimostrato anche di poter esercitare un effetto proliferativo sull’endometrio, senza peraltro indurre forme d’iperplasia ghiandolare.
Il tessuto più responsivo all’azione del mifepristone è dunque l’endometrio: una singola somministrazione di 2,5 mg è sufficiente a ritardare la maturazione della mucosa e la comparsa dei marcatori progesterone-dipendenti; con 50 mg si ottiene lo sfaldamento dell’endometrio e la comparsa di un flusso mestruale; con 200 mg si può interrompere una gravidanza, mentre per ottenere un effetto anti-glucocorticoide, bisogna somministrare dosaggi molto più elevati.
Il mifepristone non è solo una sostanza abortiva, ma ha altri possibili impieghi, ginecologici e non ginecologici, per i quali può essere utilizzato in dose unica o per somministrazione prolungata. In gravidanza può essere impiegato per dilatare il canale cervicale, nella cosiddetta ‘regolazione mestruale’ (se il ritardo mestruale è inferiore ai 2 giorni), negli aborti interni, nelle gravidanze anembrioniche (comunque destinate ad interrompersi), negli aborti interni incompleti e nelle morti endouterine del feto. Sono state pubblicate numerose memorie scientifiche relative alla possibilità di utilizzare questa molecola nelle gravidanze a termine e oltre il termine con feto vivo e vitale, per indurre il travaglio di parto, anche se esistono perplessità dovute ai numerosi effetti collaterali registrati (aumento eccessivo della frequenza delle contrazioni uterine, anomalie del battito cardiaco fetale). Lo stesso mifepristone si è rivelato utile nei programmi di procreazione medicalmente assistita, sia per ritardare il picco dell’LH, sia per modificare la finestra di impianto embrionale, consentendo una miglior sincronizzazione dell’incontro tra blastocisti e endometrio.
Il mifepristone è stato utilizzato con successo nella contraccezione di emergenza: nel più recente UpToDate (settembre 2009) sono riportate numerose pubblicazioni che ne attestano l’efficacia intorno al 99%, il che colloca questa molecola in cima a tutte quelle utilizzate per questo stesso scopo, compreso il levonorgestrel. Il dosaggio ottimale non è stato ancora determinato (le sperimentazioni hanno utilizzato tra i 5 e i 600 mg in dose unica), ma dovrebbe trovarsi intorno ai 10-25 mg. La maggior efficacia di questa molecola è probabilmente dovuta al suo effetto d’inibizione sull’impianto dell’embrione (documentata anche da una sperimentazione in vitro eseguita nel 2007 presso il Karolinska Institutet di Stoccolma) che si sovrappone alla capacità di ritardare il momento dell’ovulazione. Esistono anche studi sperimentali che hanno messo a confronto altri inibitori recettoriali con il levonorgestrel, senza poter rilevare significative differenze.
Ma il potenziale contraccettivo del mifepristone si esprime anche attraverso il blocco del picco dell’LH, l’azione antiproliferativa sull’endometrio, l’induzione di un flusso pseudo mestruale (se la somministrazione viene fatta in fase luteale), il ritardo della fecondazione dell’uovo e il rallentato transito di entrambi i gameti nelle tube. La somministrazione quotidiana di 2-10 mg di mifepristone inibisce lo sviluppo follicolare e non consente il picco dell’LH, impedendo l’ovulazione. L’anovulatorietà ripetuta può divenire causa di un eccessivo effetto di stimolo estrogenico sull’endometrio, un rischio solo in parte mitigato dall’attività antiestrogenica della molecola che è di tipo non competitivo. In ogni caso, con 2 mg al giorno si inibisce l’ovulazione in oltre il 90% dei cicli e si ottiene un effetto contraccettivo assoluto; la dose unica di 25 mg alla settimana non ottiene sempre un effetto antiovulatorio, ma previene le gravidanze nella totalità dei casi.
4. La contraccezione d’emergenza
È particolarmente interessante, ai fini della cosiddetta contraccezione di emergenza, la possibilità di ricorrere al mifepristone quando sono già trascorsi molti giorni dal rapporto a rischio e non si può più far affidamento sull’assunzione dei farmaci normalmente assunti. Somministrato in fase luteale tardiva, il farmaco induce una pseudo mestruazione che comporta l’eliminazione di prodotti del concepimento eventualmente impiantati.
La somministrazione continua di mifepristone può anche risolvere i problemi di spotting determinati dall’assunzione di progestinici a scopo contraccettivo (la cosiddetta minipillola), ma esistono preoccupazioni su questo impiego del farmaco che determinerebbe una diminuzione della sicurezza anticoncezionale. Altri impieghi dei PAs riguardano il trattamento farmacologico dei leiomiomi e dell’endometriosi, nei quali sono stati registrati successi non indifferenti.
In dosi elevate il mifepristone, si rivela un potente antagonista dei glucocorticoidi ed è stato utilizzato in varie forme di sindrome di Cushing, come il carcinoma surrenalico e vari tipi di tumore ectopico ACTH secernente. Questo effetto antagonista sui mineralcorticoidi è stato anche utilizzato nel trattamento delle ustioni, delle ipertensioni glucocorticoido-dipendenti, di alcune forme di artrite, del glaucoma, di alcune corio-retinopatie, e persino di malattie virali tra le quali figura anche l’AIDS. È allo studio l’effetto del farmaco sulla diminuzione delle capacità cognitive indotta dal cortisolo, su alcune psicosi depressive severe e sui disturbi bipolari. È anche stata scoperta una possibile utilità terapeutica nei confronti di molti tumori che contengono recettori per gli steroidi (meningiomi, gliomi, leiomiosarcomi, carcinomi dell’ovaio, del seno e della prostata).
Una ricerca eseguita recentemente negli Stati Uniti presso la Mount Sinai School of Medicine di New York e alla quale ha collaborato una ricercatrice italiana, la dottoressa Cristina Alberini, ha dimostrato che il mifepristone blocca i meccanismi di memoria traumatica e li rimuove non consentendo la loro rievocazione: è attualmente in corso negli Stati Uniti una sperimentazione sui militari reduci dall’Iraq che presentano gravi turbe psichiche legate alle esperienze maturate durante la guerra ed esistono numerose prove sperimentali di questa efficacia.
5. RU486. Il percorso ad ostacoli verso la legalizzazione
In attesa che le procedure di mutuo riconoscimento fossero completate, molte regioni italiane hanno deciso di consentire l’importazione dell’RU486 per impieghi mirati, un escamotage che consente di importare un farmaco non ancora registrato per utilizzarlo in casi specifici, richiesta che può essere ripetuta senza limiti ma sempre sotto la diretta responsabilità di un medico. Intanto, nel febbraio del 2008 l’RU486 ha ricevuto il primo via libera alla commercializzazione nel nostro paese. La commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha dato parere favorevole alla richiesta di autorizzazione al commercio, attraverso la procedura di mutuo riconoscimento (che coinvolge anche altri Paesi europei che sono rimasti ultimi a farne richiesta, è cioè Portogal...