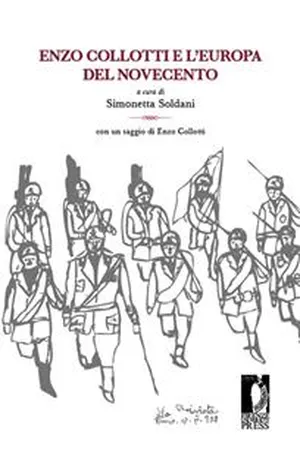1. La questione del «carattere autoritario»
«Che cosa ci insegna la storia sul carattere e sul comportamento della popolazione di lingua tedesca in Europa? Esistono caratteri nazionali duraturi? I tedeschi sono cambiati negli ultimi 40 (o 80 o 150) anni?» Queste domande non avevano un carattere accademico; si trattava infatti della griglia di lavoro proposta ad un gruppo di esperti riuniti dal premier britannico Margaret Thatcher nel marzo 1990 per discutere della questione tedesca dopo la caduta del muro e prima della riunificazione.
Dal 1945 e per molti decenni la risposta a queste domande è sembrata essere scontata. «Diederich Hessling era un bambino sensibile; più di ogni altra cosa gli piaceva fantasticare, aveva paura di tutto e soffriva spesso di mal d’orecchi»: inizia così il romanzo di Heinrich Mann Der Untertan, Il suddito, proponendo un’incisiva immagine psicologica del tedesco formatosi in epoca guglielmina, quasi contento della condizione autoritaria e della continua punizione paterna. Si tratta di un romanzo emblematico, che è stato utilizzato spesso nel secondo dopoguerra per spiegare il Sonderweg tedesco, vale a dire quel percorso storico ‘errato’ che – a causa di una sorta di inclinazione psicologica all’ossequio per l’autorità – avrebbe portato al nazismo, in una strada a senso unico «da Bismarck a Hitler» (così suona il titolo di un noto libro di Sebastian Haffner sulla storia tedesca), un popolo di succubi e sadomasochisti inclini alla tirannia.
Nel suo saggio La psicologia di massa del fascismo (1932) Wilhelm Reich forniva la prima, classica interpretazione psicoanalitica e critica del fascismo e del nazismo. Egli vedeva una relazione di fondo tra ideologia fascista e repressione autoritaria degli istinti. Reich individuava nel fascismo «l’espressione politicamente organizzata della struttura caratteriale umana media» in quanto costituisce «l’atteggiamento fondamentale dell’uomo autoritariamente represso dalla civiltà delle macchine». La famiglia patriarcale in quanto nucleo dello Stato avrebbe creato le strutture caratteriali adatte per la loro sottomissione all’ordine sociale repressivo. L’idea del carattere autoritario venne poi ripresa più tardi anche da autori come Erich Fromm.
Esiste ancora questa dimensione del problema tedesco? Dalle elezioni del 26 settembre 2009 è emerso un quadro consolidato della politica tedesca, un quadro ormai noto. In parlamento non esiste un partito di estrema destra; non ci sono rappresentanti del neonazismo, e – al Bundestag – non c’è nemmeno un partito dell’estrema sinistra. Il conflitto intestino che distrusse la prima Repubblica tedesca, quella di Weimar, è scomparso nella Germania post-unificata. L’arco costituzionale della Germania federale si è conservato dopo il 1990. Anche sulla sinistra c’è un quadro ormai consolidato: per trovare più consensi al centro, la socialdemocrazia ha lasciato spazio per la nascita di un nuovo partito di sinistra (Die Linke), ben sapendo che quel partito non può fare a meno di trovare un accordo con la socialdemocrazia. L’aumento dei voti per Die Linke è solo apparentemente a danno della Spd, perché a medio termine la nuova forza politica si inserirà nell’arco dei partiti ritenuti idonei a partecipare ad una coalizione di governo. Nel 2009 Die Linke, percepita come partito di protesta, è cresciuta molto più ad Esta che ad Ovest, a conferma delle persistenti differenze tra le due parti della Germania anche 20 anni dopo la caduta del muro. Quel che Enzo Collotti ha scritto saggiamente nel febbraio del 1991 (che sarebbe stato lungo e difficile amalgamare le due parti del paese), è un problema ancora aperto.
Ma le coordinate del «problema tedesco» si sono spostate notevolmente. La Germania non è cambiata solo geograficamente e politicamente; nel corso del tempo, è cambiata anche la sua composizione biologica e antropologica, attraverso un ricambio generazionale nonché attraverso le varie ondate di immigrazione. A modificare in profondità i caratteri della società tedesca, in effetti, hanno contribuito non poco i 15 milioni di persone immigrate (lo «sfondamento migratorio», come si suol dire a Berlino), più di 8 dei quali possiedono oggi il passaporto della Repubblica federale tedesca. La maggior parte di loro proviene dall’Europa dell’est, circa tre milioni dalla Turchia (tra cui un numero cospicuo di curdi), il 7% dalla ex-Jugoslavia e circa il 5% dal Medio Oriente. Già tra un lustro, in buona parte delle grandi città della Germania la metà dei bambini che popoleranno le scuole elementari sarà di origini non-tedesche. Di fronte a queste prospettive possiamo già oggi prevedere che la futura Germania sarà costituita da una molteplicità di minoranze, e che l’‘etnia’ tedesca sarà a lungo termine soltanto la più grande tra queste minoranze.
Sappiamo però che la composizione multi-etnica non è di per sé un antidoto contro i nazionalismi. La società dell’Impero guglielmino era caratterizzata da una forte immigrazione dall’est (prevalentemente lavoratori per l’industria siderurgica, come nel bacino industriale della Ruhr), ma questo il clima da melting pot non impedì di per sé la crescita di un clima fortemente nazionalistico. In Parlamento, nel 1914, la socialdemocrazia tedesca votò a favore dei crediti di guerra – aggravando divergenze e diffidenze preesistenti tra il partito tedesco e quello italiano dominato dai massimalisti che si sarebbero ripercosse sulla percezione del problema tedesco da parte dei socialisti e di cui si avvertono i riflessi anche in alcuni scritti di Enzo Collotti.
Bisogna però sottolineare un altro importante elemento del cambiamento. Quel che si è sicuramente trasformato – in un processo decennale di dimensioni inaspettate – sono i valori fondamentali della società occidentale tedesca; e con essi sono cambiati la forma e il contenuto dell’educazione infantile e giovanile, che non contribuisce più alla formazione di un carattere autoritario, come accadeva ai tempi della società guglielmina e nella prima metà del Novecento. I concetti di autorità paterna, l’idea che fosse normale usare la violenza fisica nei confronti dei giovani, lo scetticismo nei confronti degli effetti delle punizioni corporali, hanno preparato il terreno per lo sviluppo di altre concezioni educative.
Quel cambiamento si ricollega a processi presenti in varie società postbelliche e postindustriali.
Quando alla fine degli anni Settanta il sociologo Ronald Inglehart condusse una ricerca tra giovani americani ed europei (dell’Est e dell’Ovest), registrava una omogenea ed estesa presenza dei cosiddetti «valori post-materialistici», capaci di avviare quella «rivoluzione silenziosa» che aveva dato vita ai movimenti pacifisti ed ambientalisti: movimenti che, inizialmente elitari, negli anni Ottanta e Novanta si sarebbero anche strutturati in movimenti e partiti politici con l’obiettivo di permeare di quei valori l’intera società organizzata. Nella sua analisi delle cause di questo «cambiamento di valori» Inglehart combina la presenza o meno di elementi di vita materiale (penuria/benessere) con una teoria della socializzazione secondo cui i valori interiorizzati nell’età giovanile sono più stabili di quelli appresi da adulti. Perciò viene alla conclusione che le coorti di persone (classi anagrafiche) cresciute in tempi di penuria tendono, vita natural durante, a raggiungere valori materialistici; chi invece si è formato in tempi di benessere tende a realizzare dei valori post-materiali. Questa interpretazione è stata raffinata da sociologi come Helmut Klages. Secondo Klages non c’è stato un passaggio lineare da una aggregazione di valori all’altra, ma un processo caratterizzato dall’inclusione dei valori post-materialistici nell’insieme dei valori delle società occidentali: un meccanismo che avrebbe portato ad una sintesi tra valori vecchi e nuovi. Il nuovo panorama dei valori potrebbe perciò essere caratterizzato da termini come pluralizzazione, de-normativizzazione e individualizzazione. Bisogna allora prendere atto che le nostre società si sviluppano, cambiano, e influenzano anche lo storico che cerca di interpretarle. In questo senso bisogna riflettere anche sui condizionamenti politici della storiografia, che non è una scienza asettica, ma è fortemente infuenzata dal ruolo (soggetto a cambiamenti) dello storico e dal contesto in cui egli si muove.
Detto ciò, e ribadendo con questi prolegomena che il nostro soggetto di analisi è in continuo mutamento, va sottolineato che il problema tedesco nel XX secolo è l’argomento a cui Collotti ha dedicato una parte importante della sua vita di studioso. In questa sede non è nemmeno possibile accennare ai tanti filoni e cambiamenti dei paradigmi interpretativi esistenti sul problema tedesco in lingua tedesca e in generale nella storiografia internazionale. Se ci limitiamo a quel che è stato scritto in italiano, spicca la produzione storiografica di Enzo Collotti che è senza dubbio il massimo interprete in Italia della Germania nel XX secolo. Tralascio qui gli altri maggiori temi storiografici dello studioso che è ben più di uno specialista di storia tedesca, e lascio in particolare ad altri di occuparsi dell’interpretazione di Collotti sui temi del fascismo e dei fascismi, dell’antisemitismo e della Seconda guerra mondiale.
Non possiamo però isolare il problema tedesco nel XX secolo dal suo contesto europeo e mondiale. Enzo Collotti sarebbe il primo a ricordarcelo. E in questo senso vorrei sottolineare che a mio avviso il problema tedesco del XX secolo è – per Collotti – intrinsecamente legato al problema del fascismo italiano e a quel modello di fascismo che ha avuto, purtroppo, tanta fortuna nell’Europa tra le due guerre, fino a raggiungere una radicalizzazione estrema nel fascismo tedesco di stampo nazionalsocialista. L’escalation politica e militare dei due maggiori fascismi europei alleati tra loro ha segnato a fondo anche l’impostazione storiografica postbellica (certo molto meno quella italiana, per ovvi motivi di autogiustificazione o rimozione della colpa). Gli scritti di Collotti hanno perciò sempre anche la funzione di illuminare criticamente la società italiana e di non far cadere nel dimenticatoio gli errori del passato.
Con la sua etica anti-nazionalconciliatoria, così diversa da altri filoni storiografici italiani, Collotti si colloca a mio avviso vicino alla storiografia tedesco-occidentale sviluppatasi negli anni Sessanta. In quegli anni si diffuse un nuovo ideale scientifico: «l’esplicita presa di posizione politica senza rinunciare però agli ideali di obiettività scientifica» (Wolfgang Schieder). Metodologicamente si arrivò ad alcune innovazioni; ad esempio con l’approccio centrato sulla storia della società (Gesellschaftsgeschichte) e sulla storia della terminologia politica (Begriffsgeschichte). Così la vecchia visione della storia, da contemplare come specchio e arricchimento personale, fu sostituita da una visione critico-illuministica dello storico che doveva spiegare i defic...