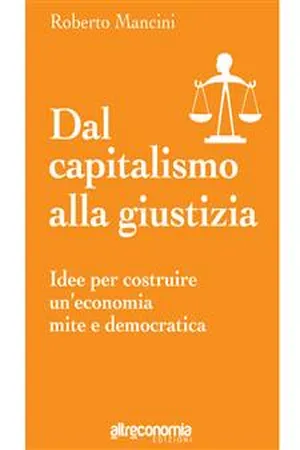
Dal capitalismo alla giustizia
Idee per costruire un'economia mite e democratica
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
About this book
L'altra economia è "un risveglio etico, che include la sensibilità, il pensiero, il coraggio, la fiducia nel potenziale del cambiamento, la speranza che consente di vedere il bene possibile".
La giustizia è il fondamento: significa mettere al primo posto, a partire
dal luogo in cui si vive e si opera, le condizioni di vita delle persone e dei popoli e l'armonia con la natura, considerando il denaro, il mercato e il sistema economico come meri strumenti.
Roberto Mancini condensa in trenta scritti, brevi e incisivi, idee e proposte per licenziare il mito insensato del capitalismo e costruire - uniti in un movimento della dignità - una "vita buona comune" e una nuova economia, mite e democratica. Roberto Mancini insegna Filosofia teoretica all'Università di Macerata. È editorialista per il mensile "Altreconomia" ed è autore di numerosi articoli e saggi. Tra i suoi ultimi libri: Le logiche del male (Rosenberg & Sellier, 2012), La logica del dono (Edizioni Messaggero, 2011) e Idee eretiche (Altreconomia, 2010)
Frequently asked questions
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Information
1. Se una società decide di cambiare
Sembra mancare persino una parola per indicarlo. Nel cristianesimo c’è la nozione di conversione. Ma è rimasta riferita al cambiamento del singolo, non all’istituzione ecclesiale, ritenuta perfetta in sé. Le recenti dichiarazioni del cardinale Bertone sul fatto che la democrazia nella Chiesa offuscherebbe la sua natura divina sono indicative di questa visione distorta. La conversione collettiva della Chiesa alla prassi della corresponsabilità evangelica viene giudicata pericolosa. Tanto più, allora, sembra fuori luogo parlare di una conversione della società. Non solo perché ci sono fedi e idee differenti, ma perché si crede che le collettività non possano vivere qualcosa come una conversione nello stile di vita.
Nel linguaggio politico, d’altra parte, tutti invocano le riforme. Ma quelle in cantiere sono autentiche aggressioni alla democrazia.
Nel pensiero organizzativo si insiste poi su termini come razionalizzazione, modernizzazione e innovazione. Ma sono solo tagli ai bilanci, al personale, alle condizioni della sicurezza.
Il cambiamento vero è stato bloccato finora dal predominio dell’ideologia della competizione.
Finché si crede che nell’economia e nella vita sia necessario competere e vincere, o almeno sopravvivere senza curarsi della sorte degli altri, qualsiasi svolta di giustizia e di pace resta inconcepibile. La società della competizione costruisce un disordine complessivo che, come una metastasi, si dispiega ogni giorno di più. Per questo viene compromessa la regolarità nella produzione e nella distribuzione di beni e servizi, con frodi e soprusi di ogni tipo. Per questo sono neutralizzate la funzionalità e la sicurezza nella produzione (dall’agricoltura all’edilizia), nei servizi (dalla sanità alla scuola, dagli uffici pubblici al sistema dei trasporti), nell’approvvigionamento energetico (basta pensare alla clamorosa stupidità del ritorno al nucleare), nella manutenzione di strutture e mezzi. Per questo si accelerano i ritmi di lavoro e si riduce ovunque il personale. Aumenta così l’immenso carico della sofferenza umana.
L’ideologia che dà apparenza di normalità a questo disordine globale ripete le sue parole d’ordine: competizione, flessibilità, crescita. E si dà persino una veste “etica” parlando di merito e di meritocrazia: categorie utili a giustificare la prassi di premiare chi in qualunque modo emerge nella competizione, abbandonando tutti gli altri, fannulloni per definizione, a se stessi. Questa retorica, familiare alla destra come al centrosinistra, liquida il riferimento a doveri e diritti umani. E oscura la categoria fondativa della convivenza, quella di responsabilità, che è l’unico criterio capace di ricomprendere quei concetti di competenza, di dovere e di iniziativa personale che la retorica del merito travisa proprio mentre pretende di riassumerli. Il lato progressista di tale retorica, quello che parla di “pari opportunità”, non è meno insidioso: si vuole che ci siano pari opportunità ai nastri di partenza nella competizione, dopo di che ognuno deve farsi largo, lasciando gli altri indietro.
Non si deve equivocare il senso del mio discorso: certo che egoismo, irresponsabilità, incompetenza e mediocrità vanno scoraggiati e condannati. Chi disattende il suo dovere sul posto di lavoro va richiamato, sanzionato e, nei casi più gravi, licenziato. La critica all’ideologia del merito, che è solo un versante dell’ideologia della competizione, non si risolve affatto in un incoraggiamento a non lavorare. L’etica della responsabilità da assumere per primi e in prima persona è l’unica logica davvero rigorosa. Bisogna capire che la società non può reggersi sul successo degli individui più ingegnosi o spregiudicati anziché sulla solidarietà, sulla riuscita di alcuni anziché sulla giustizia per tutti, sull’interesse privato anziché sul dovere di ognuno verso gli altri, sulla competizione anziché sulla cooperazione, sull’ambizione anziché sulla responsabilità.
Il cambiamento vero e praticabile ha un nome nitido. Si chiama liberazione. Il risveglio, la rigenerazione e l’umanizzazione della società richiedono il diffondersi di percorsi di liberazione delle persone non solo dalla sofferenza in cui sono imprigionate, ma già dalla logica che la origina. Si tratta allora di verificare se esistono soggetti appassionati, lucidi, attivi e coordinati che oggi possano sviluppare questi percorsi di liberazione sino a far nascere un ordine di convivenza nel quale la sofferenza degli altri non sia più un buon affare per nessuno.
2. Un’anestesia pericolosa
Niente emozioni, sentimenti, passioni. Restano solo paura e avidità, che sono i moventi psichici graditi alla razionalità dominante. Per questo è urgente approfondire la considerazione della sofferenza economica e anche quella dei meccanismi difensivi inconsci che ce la rendono tollerabile.
Nell’illuminante libro "Souffrance en France" - tradotto dalle edizioni il Saggiatore con il titolo" L’ingranaggio siamo noi. La sofferenza economica nella vita di ogni giorno" - lo psichiatra Christophe Dejours vede nell’economicismo un capillare processo di banalizzazione del male, per cui ciò che è inaccettabile viene reso ovvio e normale. Si attua così quella familiarizzazione della società con l’infelicità che impedisce di riconoscerla come frutto dell’ingiustizia. La sua causa è invece attribuita al “destino” e alla “sventura”. Dejours constata che in tal modo si è ristretto il mondo della prossimità - quello delle relazioni con le persone importanti per noi - e si è esteso a dismisura il mondo della distanza, nel quale non ci interessa quello che accade agli altri. Egli insiste su quello che ritiene il fattore negativo centrale della docilità di massa al sistema di iniquità: molti sono paralizzati politicamente e nel contempo collaborano con il sistema dominante per paura della sofferenza a cui, secondo loro, si esporrebbero se agissero in modo diverso. Perciò mettono in atto sistemi di difesa che implicano l’indifferenza, la percezione alterata della realtà sociale, la credulità verso il sistema mediatico di manipolazione delle informazioni e del consenso.
Chi sopravvive con questa strategia difensiva vive perennemente in stato di scissione interiore: persona “normale” con i pochi esseri umani che sono nella sua sfera affettiva e familiare, persona “normopatica” (cioè eccessivamente conformista, al punto che la sua normalità è patologica) nei confronti di tutti gli altri e della realtà, a partire dalla realtà lavorativa quotidiana. Come uscirne?
Dejours ricorda che “le azioni e le manifestazioni degli oppositori, per quanto appropriate possano essere, hanno scarsa portata finché non sono legate a un progetto politico alternativo strutturato e credibile” (p. 179). L’importante è che alla lotta contro l’ingiustizia e alla promozione di questo progetto alternativo si affianchi un’intelligente lotta contro la banalizzazione del male. Finché l’ingiustizia non viene percepita come tale e sentita come intollerabile, nessuno muove un dito. D’altra parte la paura della sofferenza e la scissione interiore sono già di per sé una sofferenza. Continuare a sostenere questo stato interiore ci impegna in modo tale che sono bruciate in partenza le energie necessarie ad agire politicamente per cambiare le cose.
Da questa analisi degli effetti interiori prodotti dal delirio ideologico dell’economia vigente - rispetto al quale lo sguardo di uno psichiatra risulta giustamente il più lucido - viene a mio avviso l’indicazione di quattro direzioni essenziali di impegno per chi crede nell’altra economia.
La prima riguarda il compito di dare esempi concreti del fatto che si può uscire dalla paura costruendo ovunque situazioni economiche (relative a produzione, distribuzione, consumo) capaci di dare sicurezza psicologica e vitale alle persone. In tale impegno è compresa la lotta per il reddito di cittadinanza e per tutte le misure utili alla sicurezza economica.
La seconda direzione indica il compito di diffondere l’informazione sulla realtà effettiva dell’economia, rendendo percepibile il carico di sofferenze che il sistema di iniquità infligge ai singoli, alle famiglie, all’intera società.
La terza direzione mostra il compito di superare, nel mondo vitale di ogni comunità locale, l’astrazione dei comportamenti automatici, sostituendola con la concretezza delle relazioni tra persone e con il ritorno alla percezione del dovere di assicurare a tutti le condizioni di una vita umana.
La quarta direzione è infine quella della delineazione di un progetto di alternativa capace di attrarre tutti coloro che desiderano un altro tipo di società, sino a renderli concordi nel lavoro di traduzione politica del progetto stesso.
In Italia saremo capaci di dare vita a un movimento così intelligente ed efficace?
3. La saggezza di coordinarsi
È la svolta indispensabile per generare l’alternativa a tutta l’iniquità che ci assedia. Il nostro Paese oggi vive non solo una crisi della democrazia, ma più radicalmente una crisi di civiltà. E una delle cause di inefficacia degli sforzi per costruire un’alternativa credibile sta nella dispersione. Anche i più generosi sono sempre troppo legati alla Babele delle microidentità, delle particolarità e dei personalismi. È per questo che non si è ancora riusciti a dare tutta la sua fisionomia e la sua energia al movimento del risveglio. Che è poi il movimento della dignità, termine che riassume bene il valore delle persone, il senso della giustizia intera, i doveri, i diritti, il metodo per agire.
È noto che i centri di potere antidemocratico interagiscono facilmente e godono del vantaggio di sintonie quasi automatiche. Invece quanti anelano a un’Italia liberata, civile, giusta e ospitale devono sprecare quasi tutte le loro energie per dare vita, nel migliore dei casi, a esili ed effimeri coordinamenti. In questo interminabile periodo di doglie, mentre i soprusi diventano legge e masse di individui manipolati danno voto e consenso a chi fa loro del male, bisogna pervenire alla visione di un unico movimento in cui confluiscano le esperienze, le idee, le energie per una società tornata civile. Non mi riferisco a un’associazione in più, né tanto meno a un nuovo partito. Mi riferisco a un processo complessivo di cambiamento, alimentato sia da una tensione spirituale comune che dalla confluenza operativa delle energie di tutte le forme di soggettività impegnate a costruire un’altra Italia. A partire da questo articolo cercherò di chiarire alcuni tratti di fondo di tale processo che si qualifica come movimento proprio per la coralità e per l’inedita efficacia che lo devono contraddistinguere.
I coprotagonisti del movimento della dignità non solo già esistono, ma agiscono in modi e con finalità che, di fatto, tendono a una confluenza organica.
Sono quanti agiscono secondo la giustizia restitutiva, che riattribuisce i diritti a chi ne è stato privato e i doveri a chi li elude. Rientrano in questi convergenti percorsi di servizio verso il bene comune molte esperienze in atto: l’impegno per l’occupazione e per la dignità del lavoro; la ricerca di vie sane per i comportamenti economici; la lotta contro le mafie; la cura per i diritti di tutti i gruppi umani esposti all’esclusione, alla persecuzione e alla violenza; la difesa della natura; l’azione educativa sistematica e appassionata; la costruzione delle condizioni per la cooperazione internazionale. Le radici del movimento della dignità sono profonde, risalgono almeno a quelli che durante il fascismo hanno creduto in una Repubblica democratica, equa e mite.
E poi ai molti esempi di servitori del bene comune che seppero vedere come la fondazione nonviolenta di una società giusta si compie attraverso la liberazione delle persone. Nell’educazione: Maria Montessori, Lorenzo Milani, Mario Lodi, Gianni Rodari; nella cura della salute a partire dai rifiutati: Franco Basaglia e Franca Ongaro; nel dare respiro alla vita delle comunità locali: Giorgio La Pira, Danilo Dolci, Mario Tommasini; nella difesa della legalità: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; nella visione dell’alternativa tra verità e violenza, Aldo Capitini. Sono solo pochi esempi tra moltissimi altri, ma bastano a indicare che il movimento è più radicato, esteso e vivo di quanto non si immagini.
Il movimento della dignità non improvvisa gesti mediatici, ma segue un metodo che dà corso a processi di liberazione. Come è accaduto storicamente con la politica della nonviolenza. L’esperienza di Gandhi in Sud-Africa e in India e altre esperienze analoghe sono il riferimento più presente, contemporaneo e carico di futuro che deve illuminarci. Non si tratta di importare da noi modelli sperimentati altrove, ma di assumere in modo originale e creativo la visione, l’energia e il metodo della nonviolenza.
È necessario arrivare a capire quali forme di sintonia tra soggettività diverse, quali dinamiche di confluenza delle energie e quali percorsi progettuali sono necessari perché il movimento della dignità riesca a dare una risposta adeguata alla nostra crisi di civiltà.
Intanto però in Italia cresce sempre più la consapevolezza del fatto che solo grazie a questo risveglio corale potremo costruire le condizioni per una società dove tutti possono vivere con piena dignità.
4. Non servono partiti nuovi ma un movimento per l’altrapolitica
Quelli che sarebbero rimasti individui isolati potranno allora agire come persone e come cittadini che non si limitano a chiedere provvedimenti ai “politici”. Prendono forma così percorsi di autoaiuto sociale che hanno non il senso di surrogare il vuoto lasciato dalla politica istituzionale, ma quello di generare una socialità di respiro comunitario e una cittadinanza attiva. Una rete di pratiche di autoaiuto sociale sul territorio di un’intera nazione serve ad aggregare le persone, a sviluppare una cultura etico-civile condivisa, a creare il potenziale di un consenso qualitativo e intelligente, interessato alla validità democratica non solo delle risposte a bisogni e diritti, ma anche al modo di costruirle. Un movimento di altrapolitica che abbia queste basi può attuare una pressione consistente nei confronti di chi detiene un potere verticale. Al contrario, proporsi alle elezioni - come coalizioni di micropartiti, o con liste locali improvvisate, o puntando su singoli candidati - senza aver radicato l’azione sul terreno della rete dell’autoaiuto sociale significa votarsi a irrilevanza e frustrazione.
Per cogliere la differenza tra la solita politica e l’altrapolitica basta fare il raffronto tra le rispettive sequenze che collegano bisogni, diritti e processi decisionali. Nella solita politica del potere per il potere, le istanze della società vengono verbalmente raccolte in programmi e promesse elettorali, poi gli eletti assumono le loro cariche amministrando e governando per lo più -anche se non sempre- secondo disegni oligarchici e secondo il loro interesse di politici professionali, dopo di che i cittadini restano in attesa di risposte che non arriveranno.
Nella dinamica dell’altrapolitica, invece, i cittadini si organizzano per concorrere a dare le risposte giuste a bisogni e diritti, imparano a orientare il loro consenso elettorale e possono interagire con maggiore forza con partiti e istituzioni; quindi, gli eletti che andranno ad amministrare e a governare dovranno farlo in presenza di un controllo democratico da parte di ampie zone della società civile. Così sarà meno facile per il potere verticale (come invece tuttora accade in molti casi) sfuggire alla dialettica con il potere orizzontale dei cittadini organizzati, al dialogo, all’attenzione dell’opinione pubblica, ...
Table of contents
- Copertina
- Dal capitalismo alla giustizia
- Indice dei contenuti
- Introduzione
- 1. Se una società decide di cambiare
- 2. Un’anestesia pericolosa
- 3. La saggezza di coordinarsi
- 4. Non servono partiti nuovi ma un movimento per l’altrapolitica
- 5. La visione che unisce
- 6. Un orizzonte per i passi di ogni giorno
- 7. Dalla paura alla lucidità
- 8. Incipit vita nova
- 9. Il principio di cooperazione
- 10. L’inganno delle “riforme”
- 11. La condizione operaia
- 12. Un appuntamento per l’altreconomia
- 13. Il ritorno alla ragione
- 14. Il disprezzo per chi lavora
- 15. Imparare dall’emozione
- 16. Un seme di buon futuro
- 17. Il valore del lavoro
- 18. La cultura della ricostruzione
- 19. Non c’è cambiamento senza nonviolenza
- 20. Risanare la vita democratica
- 21. L’equità come fondamento
- 22. Le false risposte
- 23. Il capitalismo vive al di sopra delle sue possibilità
- 24. Conoscenza e formazione, condizioni vitali per l’altreconomia
- 25. Alla radice del capitalismo
- 26. L’incubo della plutonomia
- 27. Con lo sguardo delle generazioni nuove
- 28. A chi dobbiamo questo disastro
- 29. Elevare la democrazia
- 30. Cambiare la politica per cambiare le regole dell’economia
- Conclusione
- La casa editrice