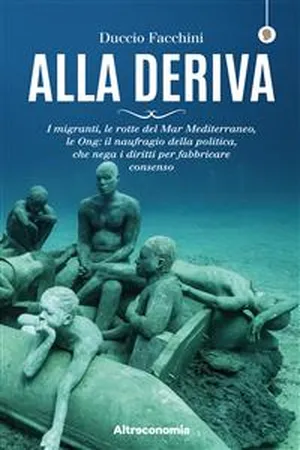Per le Nazioni Unite, colui che cambia il proprio Paese di residenza abituale, indipendentemente dal motivo o dal suo status giuridico, è un “migrante internazionale”. E “sebbene non esista una definizione giuridica formale”, chiarisce il servizio statistico dell’Onu nelle sue Recommendations on Statistics of International Migration, si distingue per prassi tra migrazione di breve durata o temporanea - che copre i movimenti di durata compresa tra i tre e i dodici mesi - e migrazione di lunga durata o permanente - che si riferisce a un cambiamento del Paese di residenza di durata pari o superiore a un anno -.
Quanti sono i migranti
I “migranti” sono una piccola parte degli abitanti del Pianeta. Nel 2017, dati Nazioni Unite alla mano, hanno raggiunto quota 3,4% della popolazione mondiale (www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf). E cioè 257,7 milioni di persone su 7,5 miliardi. Sono triplicati rispetto al 1970 (84,5 milioni), ma restano una gigantesca briciola.
L’origine dei “migranti internazionali” censiti al 2017 è determinata dal luogo di nascita. La parte più consistente si muove dall’Asia (105,7 milioni). Seguono l’Europa (61,1 milioni), l’America Latina e Caraibi (37,7 milioni) e l’Africa (36,2 milioni). Il continente culla dell’“esodo biblico” (Matteo Salvini), quindi, vale poco più del 14% dell’intero flusso globale (Fig. 1). Due terzi di tutti i migranti internazionali oggi risiedono in 20 Paesi. Nove sono asiatici, sette europei, due nordamericani, uno in Africa e uno in Oceania. Avanti a tutti ci sono gli Stati Uniti d’America (con 50 milioni). Arabia Saudita, Germania e Russia ne ospitano circa 12 milioni a testa. Il Regno Unito 8,8, gli Emirati Arabi Uniti 8,3, la Francia 7,9. Solo più indietro c’è l’Italia, con 5,9 milioni di persone. La contrapposizione “indigeni-invasori” non regge alla prova dei numeri. La stragrande maggioranza dei percorsi migratori inizia e finisce nella stessa “area” del Pianeta - come spiega il Dipartimento degli affari economici e sociali (UNDESA), che ogni anno pubblica l’ International Migration Report - fatto salvo per America Latina, Caraibi e Nord America. Lo scorso anno, in Europa, il 67% dei migranti era infatti di origine europea. In Africa il 53%, in Asia il 60%, proprio come in Oceania. Scenari apocalittici di spostamenti continentali, dunque, sono infondati. Lo dimostra ancora una volta il caso africano: al 2017, dati UNCTAD, oltre la metà delle persone che hanno lasciato il proprio Stato d’origine è rimasta nel continente (circa 19,4 milioni), “a casa loro” direbbe qualcuno. E tra questi, 8 su 10 si sono spostati in un Paese della stessa regione. Dal Burkina Faso alla Costa d’Avorio, dal Mozambico al Sudafrica, per citare alcuni esempi.
Dove vanno gli “spiazzati”
È in questa necessaria cornice introduttiva che va letto il fenomeno dei migranti forzati ( displaced). E cioè di coloro che abbandonano la propria casa, terra e comunità a seguito di persecuzioni, conflitti o violenze generalizzate. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ne ha contati 68,5 milioni a fine 2017, un record drammatico dopo dieci anni di continua crescita e un salto di 2,9 milioni di persone in un solo anno rispetto al 2016. Di questi, gli sfollati interni sono 40 milioni, i richiedenti asilo 3,1 milioni e i rifugiati 25,4 milioni, inclusi quelli della Palestina affidati all’agenzia UNRWA (Fig. 2). Quando ci si riferisce a quest’ultima fattispecie - quella dei rifugiati - vale la definizione della Convenzione di Ginevra del 1951: “Rifugiato è colui che nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”.
Oggi, due terzi dei rifugiati del Pianeta giungono da cinque Paesi straziati. Ovvero Siria (6,3 milioni), Afghanistan (2,6), Sud Sudan (2,4), Myanmar (1,2) e Somalia (986mila persone). In termini di accoglienza, l’Europa è alla stregua di una spettatrice: l’85% dei rifugiati affidati al mandato dell’UNHCR, infatti, si trova in Paesi “in via di sviluppo”.
O comunque ai margini o lontani dalla Fortezza Europa.
Il primo è la Turchia (3,5 milioni), seguito da Pakistan e Uganda (entrambi intorno a 1,4 milioni), Libano (circa 1 milione), Iran (979mila), Germania (970mila), Bangladesh (932mila) e Sudan (906mila) (Fig. 3). Il Libano è il Paese con il più alto tasso di rifugiati rispetto alla popolazione residente, contandone uno ogni sei abitanti (1 su 14 in Giordania e 1 su 23 in Turchia). Ma è ancora una volta la Turchia il Paese che nel 2017 ha fatto da principale “ricettore” di profughi dalla Siria, accogliendo (o trattenendo) 681mila dei 745mila che hanno abbandonato il Paese stremato dal conflitto iniziato nel 2011. Uganda e Sudan sono stati invece il punto d’approdo momentaneo del dramma del Sud Sudan, dividendosi circa 460mila persone ciascuno - l’Etiopia è più indietro (75,4mila) -. I rifugiati del Myanmar, invece, sono finiti quasi interamente in Bangladesh (oltre 655mila persone). La dinamica regionale delle migrazioni, anche forzate, si conferma prevalente.
Un terzo dei rifugiati censiti da UNHCR - 6,3 milioni di persone - oggi è accolto in Africa (escluso il Nord del continente). Mentre l’Europa, cieca, con pochi nervi e senza numeri, non arriva alla metà: 2,6 milioni di persone a fine 2017. Il tutto dopo aver investito nel periodo 2007-2013 quasi 2,35 miliardi di euro in progetti di costruzione, sorveglianza, pattugliamento e controllo di barriere all’ingresso dei confini. Contro i 700 milioni di euro posti nello stesso periodo sul capitolo dell’accoglienza dei rifugiati.
Il Vecchio Continente si chiude, nonostante 70 anni fa, appena dopo il Secondo conflitto mondiale, abbia conosciuto sul proprio territorio il dramma di 40 milioni di profughi. Una urgente “goccia” umanitaria viene presentata come “emergenza”; ad agevolare il clamore è la strutturale e predeterminata impreparazione di un continente a far fronte a una parte (inferiore al 50%) delle 1,7 milioni di domande di asilo presentate nel mondo nel 2017, specie in Germania, poco più di 198mila, Italia, circa 130mila, e Turchia, 126mila (http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180320-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fasylum-and-managed-migration%2Fpublications).
I rifugiati che accedono a procedure di reinsediamento ( resettlement) sono una minoranza. Nel 2017 - dati UNHCR - sarebbero stati 102.800 i rifugiati ammessi alle procedure di reinsediamento durante l’anno (33.400 negli Stati Uniti, 26.600 in Canada, 15.100 in Australia, 6.200 nel Regno Unito e 3.400 in Svezia), con o senza l’assistenza dell’Alto commissariato.
Gli sfollati interni
Ma gli “spiazzati” dei nostri giorni non sono solo i rifugiati, come ricordano i rapporti annuali dell’ Internal displacement monitoring centre (IDMC), realizzati in collaborazione con il Norwegian Refugee Council. L’ultimo, pubblicato nel maggio 2018, ha messo in fila i fatti salienti di una partita già persa: “I conflitti in Afghanistan, nella Repubblica centrafricana, nella Repubblica democratica del Congo, in Iraq, in Nigeria, in Sud Sudan, in Siria e nello Yemen hanno continuato a costringere un numero drammatico di persone a fuggire dalle loro case. I cicloni, le violente tempeste e le inondazioni hanno colpito anche i Caraibi e l’Asia meridionale, distruggendo infrastrutture vitali e lasciando milioni di persone senza tetto”. Risultato? “Nel 2017 sono stati registrati 30,6 milioni di nuovi sfollati interni a causa di conflitti e catastrofi in 143 tra Paesi e territori”.
Tra i più colpiti, Cina, Filippine, Siria, Repubblica democratica del Congo, Cuba, Stati Uniti, India, Iraq, Somalia, Etiopia. Le guerre hanno stravolto l’Africa Sub-sahariana e il Medio Oriente. I disastri ambientali (inondazioni, siccità, uragani) dovuti al cambiamento climatico hanno colpito duro l’Asia orientale, il Pacifico, le Americhe.
Misurare gli sfollati è difficile. Ma sempre secondo IDMC, la lista dei primi dieci Paesi al mondo per numero di “displaced” alla fine del 2017 era composta da Siria (6,7 milioni), Colombia (6,5), Repubblica democratica del Congo (4,4), Iraq (2,6), Sudan (2), Yemen (2), Sud Sudan (1,8), Nigeria (1,7), Afghanistan (1,2) e Turchia (1,1). Sono questi i luoghi sofferenti del Pianeta.
Le crisi taciute
Eppure è l’Europa a rubare la scena e i titoli sui media. I curatori del report di IDMC lo sottolineano amaramente nell’introduzione del loro rapporto annuale.
“Il primo gennaio 2017, più di 1.000 persone che cercavano di entrare in Europa dall’Africa settentrionale hanno fatto notizia. Hanno cercato di evitare la strada sempre più pericolosa attraverso il Mediterraneo scalando una recinzione di confine in filo spinato nell’enclave spagnola di Ceuta, in Marocco. [...] Le ragioni del loro disperato e fallimentare tentativo erano diverse quanto i loro Paesi d’origine, ma avevano almeno una cosa in comune. Venendo da Afghanistan, Nigeria, Senegal e Siria, avevano intrapreso lunghi e difficili viaggi per raggiungere la recinzione di confine. Coloro che lo fanno, tuttavia, sono solo una frazione delle persone che fuggono dall’instabilità, dalla violenza e dalla povertà in tutto il mondo”.
In quello stesso Capodanno, infatti, erano scoppiati i combattimenti a Wadi Barada, alla periferia di Damasco, che in un solo giorno hanno causato oltre 1.000 sfollati. Ma l’immagine ha colpito molto meno rispetto all’“invasione” di Ceuta. “Sono stati i primi dei 2,9 milioni di nuovi sfollati in Siria nel 2017”. E ancora. “Le gravi inondazioni sulla costa orientale della Malesia hanno causato 15.000 sfollati nei primi tre giorni del 2017. Le inondazioni e le frane provocheranno più di 80.000 nuovi sfollati nel Paese, ma queste valgono meno dell’1% degli 8,6 milioni di sfollati a causa dei disastri improvvisi che hanno colpito l’Asia orientale e il Pacifico nel corso dell’anno”.
Nella città irachena di Mosul, nella prima settimana del 2017, più di 13.000 persone sono fuggite dai combattimenti. Circa 4.000 gli sfollati solo il 2 gennaio. I “precursori” di 1,3 milioni di nuovi sfollati legati al conflitto in Iraq nel 2017, a 15 anni dall’inizio della Seconda guerra del Golfo.
Guerra che in Yemen - combattuta a partire del marzo 2015 dalle fazioni del gruppo armato Huthi e quella governativa di Hadi, anche con gli armamenti forniti dall’Italia e altri Paesi alla coalizione a guida saudita - è costata la vita a 6.000 civili e contribuito, nel 2017, allo sfollamento di oltre 160mila persone.
Le guerre
Il mondo è in guerra ed è ben armato, anche se tendiamo a rimuoverlo. Lo chiarisce il quadro tratteggiato dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, sipri.org) - l’istituto internazionale, nato nel 1966 e con sede a Stoccolma, impegnato in ricerche su conflitti, armamenti e disarmo - nel suo rapporto annuale 2018. “Nei primi 11 mesi del 2017, si legge, almeno 15.399 civili sono stati uccisi da armi esplosive, la stragrande maggioranza nelle città, con un aumento del 42% rispetto al 2016”. Quello del SIPRI è uno sguardo indipendente sulla spesa militare e sul commercio di armi. Nel 2017, questa ha superato quota 1.739 miliardi di dollari. Si tratta del 2,2% del Prodotto interno lordo mondiale: 230 dollari pro capite. Il più alto livello dalla fine della guerra fredda. Dal 1999 al 2011 si sono susseguiti 13 anni di crescita, tra 2012 e 2016 anni “piatti” di spesa, fino al +1,1% del 2017.
Nella classifica dei primi cinque acquirenti al mondo ci sono Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Russia e India. Da soli rappresentano il 60% della spesa complessiva. Se gli USA risultano stabili - 610 miliardi di dollari nel 2017 -, la Cina (228 miliardi di dollari secondo le stime) ha fatto registrare un incremento della spesa del 5,6%, l’Arabia Saudita (69,4 miliardi) del 9,2% e l’India (63,9 miliardi) del 5,5%. La Russia, invece, ha drasticamente tirato il freno: -20%, attestandosi su 66,3 miliardi. Spostando il fuoco sull’Europa ci si accorge infatti che i principali Paesi per spesa militare sono la Francia (57,8 miliardi di dollari, -1,9%), Gran Bretagna (47,2 miliardi, +0,5%), Germania (44,3 miliardi, +3,5%) e Italia. Stando alle valutazioni del Sipri, anche il nostro Paese avrebbe fatto registrare una spesa militare in rialzo (+2,1%), stimata intorno ai 29 miliardi di dollari (pari all’1,5% del PIL). A chiudere la classifica dei primi 15 Paesi al mondo per spesa militare - che da soli coprono l’80% del mercato - è la Turchia, con 18,2 miliardi investiti nel 2017 e una crescita del 46% rispetto a dieci anni fa. Un andamento in linea con quello della regione del Medio Oriente, che tra 2016 e 2017 ha aumentato la spesa di oltre 6 punti. Si tratta di un dato parziale visto che sono stati esclusi dal conteggio Paesi chiave come Siria e Yemen oltre che di storici “spenditori” militari come Qatar ed Emirati Arabi.
Il commercio di armi contribuisce ad aggravare situazioni di conflitto, instabilità e crisi - fotografati dall’ International institute for strategic studies di Londra o dall’ Uppsala Conflict Data Program dell’ateneo svedese - e inchioda le responsabilità dell’Occidente. “Produrre e vendere armi è un affare molto redditizio che uccide le persone, mentre l’acquisto di armi sottrae denaro da obiettivi positivi centrati sulle esigenze umane”, è la denuncia della Campagna globale sulle spese militari (GCOMS, demilitarize.org), rimasta però inascoltata e “rimossa”.
Povertà e discriminazioni
Lo stesso meccanismo che fa dimenticare quel che c’è oltre la Fortezza.
Al di sotto della soglia di povertà internazionale fissata convenzionalmente a 1,90 dollari al giorno, al 2013, vivevano quasi 800 milioni di persone. Oltre un abitante del Pianeta su dieci, specialmente in Asia meridionale e nell’Africa Sub-Sahariana. Solo il 45% della popolazione mondiale può contare inoltre su una forma di protezione sociale, mentre nel 2016 erano 32 su 100 i ritirati dal lavoro sprovvisti di una benché minima pensione (in Africa Sub-Sahariana la percepisce appena il 22% dei potenziali beneficiari). E come ricordano le Nazioni Unite nei report affiancati ai 17 Sustainable Development Goals, SDGs, dell’Agenda 2030, “Le perdite economiche dovute ai disastri naturali raggiungono attualmente una media di 250-300 miliardi di dollari all’anno. E i Paesi più piccoli e vulnerabili, in particolare i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, avranno un impatto sproporzionato rispetto alle dimensioni delle loro economie”.
Nel triennio 2014-2016 erano ancora 793 milioni gli individui in stato di denutrizione. E da stime del 2016 risultavano intorno ai 155 milioni i minori sotto i cinque anni la cui crescita sarebbe stata bloccata per cause legate alla malnutrizione; 52 milioni i bambini sotto peso per la loro altezza (“ wasting”) e 41 milioni quelli in condizioni opposte (“ overweight”). L’Africa subsahariana continua ad avere il più alto tasso di mortalità tra i bambini al di sotto dei 5 anni, con 84 decessi ogni 1.000 nati vivi nel 2015 - circa il doppio della media mondiale. E due miliardi di individui nel mondo versano in una condizione di “stress idrico”, mentre 892 milioni di esseri umani nel 2015 defecavano ancora all’aria aperta.
A proposito di diritti, è bene ricordare che 72 Paesi al mondo nel 2017 criminalizzano le relazioni tra individui dello stesso sesso, e in otto di questi - spiega l’ International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA, https://ilga.org) - è prevista la pena di morte.
Il terrore globale
Non si può prescindere da questi elementi di contesto per affrontare l’inesistente esodo che interessa l’Europa. Che si è chiusa ancor di più dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, come racconta la professoressa Chiara Favilli nel capitolo 4. Ma i dannati del terrore, ancora una volta, sono soprattutto fuori dalle mura. “Il 94% di tutte le morti terroristiche avviene in Medio Oriente e Nord Africa, nell’Africa sub-sahariana e nell’Asia meridionale”. La fonte è il rapporto “Global Terrorism Index” (GTI), curato dall’ Inst...