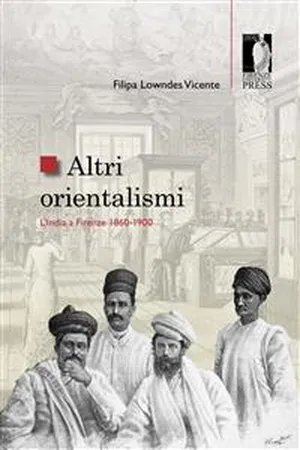![]()
Firenze come centro di studi orientali
1. L’unificazione italiana e il ruolo di Angelo De Gubernatis
Quale fu il contesto più ampio entro il quale fiorirono a Firenze gli studi orientalistici, culminati nel IV Congresso Internazionale degli Orientalisti del 1878? Tra le altre cose, possiamo notare la concomitanza di due fattori. Da una parte la scelta di Firenze, capitale della nazione italiana tra il 1864-65 e il 1871; dall’altra, il concentrarsi nella stessa città, a partire da quest’epoca, di un nutrito gruppo di eruditi italiani appartenenti alle più svariate discipline. Questi due fattori furono senza dubbio inscindibili. Sebbene il progetto di una Firenze capitale fosse stato ben presto accantonato a favore di Roma, proposito realizzato nel 1871, questo breve arco di tempo fu sufficiente a provocare ampie conseguenze. Di fatto, l’investitura di Firenze a capitale d’Italia, dopo Torino, rappresentò un investimento materiale che rese possibile la creazione di numerose organizzazioni e istituzioni accademiche, e la conseguente attrazione delle personalità più idonee a occupare le cariche di nuova istituzione.
L’eterogeneo gruppo di persone che andò radunandosi a Firenze, incluso il torinese Angelo De Gubernatis, si trovò al centro di una prima fase dell’unità italiana nella quale la costruzione di un’identità comune passava anche attraverso la ricerca di contatti con l’Europa intellettuale, rispetto alla quale l’Italia si sentiva emarginata. L’impegno di De Gubernatis nel rafforzare i legami con i centri culturali europei andò in una duplice direzione: mentre da una parte egli tentò di esportare un’idea di Firenze quale locus di studi letterari e orientali, che in fondo costituivano i suoi principali interessi di ricerca, dall’altra si impegnò a importare ciò che si faceva e si scriveva in Europa. Non solo in Francia e in Inghilterra, come spesso accadeva, ma riferendosi a un’idea più ampia di Europa, che andava dal Portogallo alla Russia. Attraverso la sua instancabile opera, i suoi studi e le sue pubblicazioni, De Gubernatis si sforzava di far conoscere l’Italia in Europa e viceversa. Lo sviluppo dell’orientalismo italiano, diffuso in varie città della giovane nazione ma specialmente a Firenze, fu perciò indissociabile dal contesto postunitario nel quale l’Italia ricercava una propria collocazione intellettuale in Europa.
Negli anni che avevano preceduto il Congresso Internazionale degli Orientalisti, che ebbe luogo a Firenze nel 1878, la città fu teatro di una intensa attività nell’ambito degli studi orientali. Al contrario di ciò che era avvenuto in paesi come la Germania, l’Inghilterra e la Francia, si era trattato di un orientalismo tardivo che poté fiorire soltanto dopo che l’Italia ebbe risolto i suoi conflitti politici e sociali più urgenti, ma che, quando si costituì come disciplina, aveva rivelato l’ambizione di essere riconosciuto da coloro che lo praticavano da più tempo. La prima cattedra universitaria di sanscrito era stata creata a Torino, nel 1852, da Gaspare Gorresio. Prima di allora, qualsiasi cittadino italiano che coltivasse l’interesse per una lingua orientale avrebbe dovuto recarsi in una città del Nord Europa per poter proseguire gli studi presso uno dei vari illustri specialisti che accoglievano studenti stranieri. Questi centri di studi, a Berlino, Vienna, Parigi e Londra, legati a università o a società scientifiche che avevano già istituito gli insegnamenti delle discipline denominate orientali, attraevano aspiranti orientalisti provenienti un po’ da tutta Europa, molti dei quali sarebbero divenuti a loro volta pionieri, nei loro paesi d’origine, nell’ambito della propria specialità.
Nel 1859, per decreto del ministro Ricasoli varato durante il Governo Provvisorio Toscano, venne fondato a Firenze il Regio Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento, prima istituzione universitaria in una città in cui la cultura non possedeva una tradizione accademica. Fra le idee che presiedettero alla creazione dell’istituzione, che guardava al modello del Collège de France, v’era quella di fornire una formazione più approfondita a quegli studenti che avessero già compiuto studi universitari. A tenere i nuovi corsi giunsero docenti da tutta Italia, molti dei quali attivi in politica e di animo progressista, che ad alcuni era costato perfino l’esilio e la prigione. Garin fa notare come l’esperienza rivoluzionaria nazionale di molti professori di questa nuova università, né fiorentini né tantomeno toscani, facilitò loro il contatto con l’Europa intellettuale, che finì per riflettersi sull’identità dell’Istituto di Studi Superiori di Firenze.
Lo spirito di collaborazione e interscambio con altri centri di cultura europei, che doveva costituire una delle vocazioni dell’Istituto, era presente anche nella sua sezione orientale. La Germania, con il suo modello di studi storico-filologici orientali, costituiva un punto di riferimento obbligato. La sezione orientalistica dell’Istituto occupò fin dall’inizio uno spazio privilegiato tra le discipline canoniche e attrasse un gruppo di studiosi provenienti da altre regioni italiane che vi andarono a insegnare. Carlo Puini, per esempio, fu professore di Storia e Geografia dell’Asia Orientale all’Istituto di Storia e Geografia dell’Asia Orientale tra il 1877 e il 1921, dedicandosi agli studi sulla Cina, sulle religioni orientali e sull’arte religiosa. Egli fu inoltre un collezionista di bronzi e libri antichi cinesi. Altri nomi che entrarono a far parte di questo nucleo di orientalisti italiani riuniti a Firenze furono: Antelmo Severini, responsabile degli studi giapponesi; Fausto Lasinio, professore di Arabo e Lingue Semitiche Comparate; Ernesto Schiaparelli, egittologo; Italo Pizzi, specialista della Persia, e Bruto Teloni, docente di Assiriologia. La quantità di corsi differenti e di docenti in grado di tenerli indusse De Gubernatis ad affermare, già nel 1876, che non c’era in Italia un luogo migliore di Firenze per studiare le lingue orientali.
Sebbene l’Oriente studiato a Firenze avesse altri protagonisti e altri ambiti geografici, Angelo De Gubernatis e l’India si trasformarono nei suoi protagonisti. Originario di Torino, De Gubernatis aveva ottenuto una borsa di studio per l’estero, come altri italiani della sua generazione, che gli aveva permesso di studiare a Berlino con Albrecht Weber e di frequentare personalità come Franz Bopp. Il successo dei suoi studi e l’esiguità di specialisti in lingue orientali ne avrebbero poi favorito l’ammissione al corpo docente dell’Istituto di Studi Superiori di Firenze, quando aveva appena 23 anni. Il suo nuovo incarico di professore di sanscrito e di mitologia comparata, esercitato tra il 1863 e il 1890, beneficiò della raccomandazione dell’orientalista Michele Amari, il quale, all’epoca, era ministro dell’Istruzione pubblica. Fu così che, cominciando da Firenze, De Gubernatis consolidò la sua carriera di accademico, di intellettuale e di scrittore, approfondendo i suoi studi sull’India e, nel contempo, partecipando attivamente alla costruzione della nuova Italia unita. Curiosamente, fu lui il primo laureato in Lettere del nuovo regno. Personaggio dai numerosi interessi, dal profondo impegno civico e dalla prolifica produzione scientifica, si distinse ben presto in due diversi ambiti – gli studi letterari e gli studi indiani. Anche la componente letteraria e linguistica assunse un ruolo centrale nei suoi studi sull’India, ma fu la cultura religiosa indiana a rappresentare il suo principale interesse, come egli stesso ebbe modo di ricordare in svariate occasioni. La notorietà in questi campi del sapere pare non sia stata sempre sinonimo di prestigio e rispetto tra i suoi colleghi, alquanto scettici sull’ampio credito goduto da chi scriveva tanto e su tutto. Secondo alcuni, la diversità dei percorsi di ricerca lo aveva allontanato dalla specializzazione o dall’approfondimento: «Chi mi accusa dunque di far troppe cose, mi dica, intanto, se io le faccia con freddezza. È vero, è proprio scandalosamente vero; io ho avuto nella mia vita molti amori diversi: la scena, la scuola, la biografia, la letteratura, la mitologia, il folklore, Manzoni, Dante, l’Oriente, l’India, e, sopra ogni cosa, l’Italia». Lui stesso era consapevole di quanto il suo proselitismo turbasse i «beati sonni accademici» dei suoi critici, e nelle pagine delle sue memorie poté liberamente risponder loro: chi ha fatto di più e meglio scagli la prima pietra.
L’India di De Gubernatis adottò metodi e discipline diverse, che comprendevano la linguistica, l’archeologia, la storia delle religioni, la drammaturgia e la letteratura. Iniziò focalizzandosi sui Veda, traducendoli e analizzandoli dal punto di vista storico e letterario, per poi passare ad altri temi: il buddismo, i viaggiatori italiani in India, la letteratura indiana. Fin dall’inizio, inoltre, De Gubernatis si era dedicato alla storia dell’orientalismo, tanto di quello italiano quanto a livello internazionale, non limitandosi al passato ma dando ampio spazio alla contemporaneità. Nel comporre i Cenni sopra alcuni indianisti viventi, opera pubblicata già nel 1872 e dedicata ad Albrecht Weber, che era stato suo maestro a Berlino, De Gubernatis scriveva anche la sua autobiografia di orientalista. Parlando degli altri parlava naturalmente anche di se stesso, collocandosi al centro di quell’orientalismo italiano che egli desiderava fosse anche internazionale.
Nel tracciare una definizione contemporanea dell’orientalista, egli aveva richiamato, all’inizio del lavoro, l’immagine del passato «con cui i nostri nonni si rappresentavano l’orientalista», immagine che egli volle sovvertire. Anticamente, un orientalista era
Un uomo che sapeva tutto quello che era inutile a sapersi e di tutto ciò ch’era utile si serbava ignorantissimo, una specie di mago Merlino che vedeva ogni cosa dal fondo della sua grotta tenebrosa, e che, portato alla luce del sole, non vedeva più nulla, un poliglotta che vi parl...