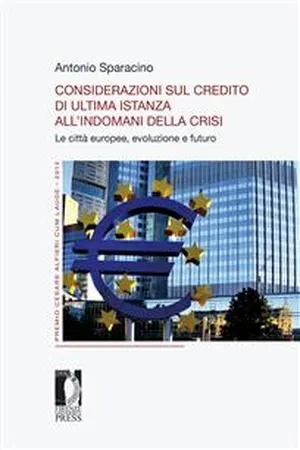![]()
Capitolo II
Il prestito di ultima istanza
Il prestito di ultima istanza costituisce uno dei pilastri della regolamentazione prudenziale (Bagliano e Marotta 1999); lo scopo del suo utilizzo è quello di evitare che situazioni di illiquidità, cui possono essere soggette le banche (che per qualsivoglia motivo non riescano a finanziarsi a condizioni contrattuali normali), finiscano per degenerare in crisi sistemiche. I turbamenti che talora investono i mercati finanziari, quali che siano le loro cause, minano la fiducia degli investitori in determinate istituzioni o in un certo tipo di assets. È il caso di ricordare quanto il sistema finanziario sia intrinsecamente sensibile agli shock cui sono sottoposte anche solo alcune delle sue componenti, dato il grado di interconnessione tra istituzioni e mercati; non è inverosimile che un’ondata di panico, seppure innescata da eventi circoscritti, si propaghi per tutto il sistema. Per tale motivo, e sulla scia di quanto evidenziato da Fischer (1999), il ruolo del prestatore di ultima istanza è quello di assicurare la concessione del credito, a determinate condizioni, impedendo che il panico finanziario si diffonda. L’autore al quale si deve la formulazione più nota del rimedio in questione, come la stessa terminologia in uso ancora oggi, è Walter Bagehot che in Lombard Street (1873) ne definì limiti e presupposti. Humphrey (1975) ci ricorda però che l’idea sottesa al credito di ultima istanza è antecedente e si ritrova in un’ampia letteratura incentrata sui problemi della Bank of England nel periodo 1797-1844, con riguardo, in particolare, alle prescrizioni rivolte alla banca centrale in ordine alle azioni da compiere per prevenire situazioni di panico. Da ultimo, non certo per importanza, va ricordato l’altro principale ‘architetto’ della dottrina classica del prestatore di ultima istanza, così come definito dallo stesso Humprey (1975), vale a dire Henry Thornton, i cui scritti risalgono agli inizi del diciannovesimo secolo (tra gli altri, Thornton 1802).
1. Chi è il prestatore di ultima istanza
La prima questione sulla quale è bene interrogarsi attiene al soggetto che debba assurgere al ruolo in esame. Sembrerebbe scontato ritenere che la banca centrale, in qualità di produttore monopolistico di moneta legale ed esente dal rischio di fallimento, sia deputata naturalmente allo svolgimento del compito. In realtà tale corrispondenza non è sempre necessaria: basti pensare al fatto che un provvedimento teso a fronteggiare situazioni di illiquidità, in cui versino determinate istituzioni, può assumere una forma alternativa alla mera creazione di moneta. Così, per esempio, può tradursi nella promozione di un intervento da parte di altri soggetti privati, affinché concedano credito, dunque un’azione di moral suasion condotta da un’istituzione che goda di ampia reputazione (Bagliano e Marotta 1999). Fischer (1999) precisa quali siano le declinazioni attraverso cui si esplica, in genere, l’azione del prestatore di ultima istanza: oltre a quella che risponde al tenore letterale della definizione, di crisis lender, vi è quella di crisis manager, cioè di coordinamento, di gestione della crisi.
Pur ammettendo che l’onere di svolgere entrambi questi compiti sia toccato, in genere, alle banche centrali, l’autore non ritiene tale condizione strettamente necessaria, né per l’assolvimento del primo né per quello del secondo; a sostegno di tale affermazione porta l’esempio americano, citando una serie di soggetti diversi dalla banca centrale, sui quali, di volta in volta, è ricaduta l’incombenza, tra cui il Tesoro americano, le clearing houses, o un banchiere privato come J.P. Morgan nell’ormai celebre episodio del 1907 (si veda Kindlebergerer 1996). Detto ciò, non si può dubitare del fatto che la possibilità di creare moneta si riveli utile per un prestatore di ultima istanza, specie quando si trovi a fronteggiare classici bank runs, in cui i depositanti vogliono ritirare il proprio ammontare di valuta detenuto presso una banca percepita a rischio. In certi casi, d’altro canto, avviene un semplice slittamento di liquidità dalle istituzioni in crisi verso quelle che appaiono più solide e mettere in circolo nuova moneta non è necessario. Vi è però una condizione perché ciò accada: che gli attori in gioco siano ancora in grado di distinguere tra illiquidità e insolvenza, fatto che durante una crisi generalizzata diventa arduo. Quest’ultimo è un nodo cruciale, come segnalato da Fischer (1999); vi torneremo in seguito per un approfondimento.
La questione circa la capacità di emettere moneta come presupposto dell’azione del prestatore di ultima istanza rimane dunque controversa e, come logica conseguenza, rimane aperto il dibattito sulla opportunità o meno che tale ruolo sia appannaggio esclusivo delle banche centrali.
2. Uno sguardo alla ‘dottrina classica’
Torniamo a Bagehot e al celebre principio enunciato dall’autore, secondo cui: «in a crisis, the lender of last resort should lend freely, at a penalty rate, on the basis of collateral that is marketable in the ordinary course of business when there is no panic» (Bagehot 1873).
Il prestatore di ultima istanza deve esser pronto a concedere credito in abbondanza, qualora ve ne fosse il bisogno. Tale assunto non implica che l’elargizione sia priva di limiti; essa è piuttosto condizionata da una duplice previsione: la necessità di fornire in contropartita buone garanzie, collateral, che siano valutati a prezzi normali (quindi antecedenti alla crisi) e che il prestito venga effettuato a un tasso penalizzante.
Il primo vincolo consente di operare una distinzione tra quelle istituzioni che si trovino in difficoltà per via del panico finanziario da quelle che risulterebbero insolventi fuori da un contesto di crisi (poiché le assets di queste ultime sarebbero oggetto di una pessima valutazione anche in tempi normali). Inoltre, esso costituisce un incentivo affinché le istituzioni riducano il rischio insito nei loro portafogli, inducendole a detenere assets che possano essere accettate in garanzia (Fisher 1999). Del resto è evidente come lo scopo stesso dell’intervento in questione, vale a dire tornare a un equilibrio normale, comporti di per sé il riferimento a valori pre-crisi. È quasi superfluo aggiungere che, in una situazione di panico diffuso, eventuali datori privati difficilmente opererebbero una corretta valutazione dei collateral, sia per incapacità o per motivi di free riding, e in definitiva anche le istituzioni in possesso di buone garanzie da offrire sarebbero penalizzate. Infine, è bene precisare che un prestatore di ultima istanza si può avvalere della facoltà di adottare criteri più flessibili per stabilire il novero delle ‘buone garanzie’ da accettare, qualora risulti indispensabile per salvaguardare la tenuta del sistema (Bagliano e Marotta 1999).
La seconda condizione alla quale è sottoposta la concessione di c...