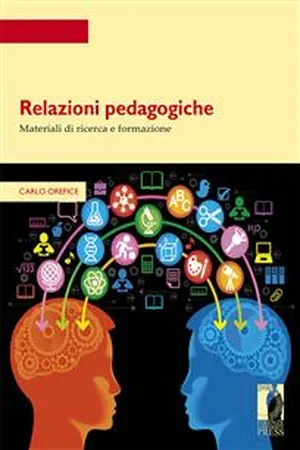![]()
Relazioni pedagogiche
Materiali di ricerca e formazione
![]()
Ricerca ed esperienza in educazione
1.1 La relazione ricercatore-operatore in pedagogia
Per impostare il discorso teorico sulla ricerca educativa la prima domanda che bisogna porsi è la seguente: cosa si intende per ‘ricerca educativa’? Pervenire alla definizione completa di tale espressione significa prima di tutto definirne il sostantivo, ricerca, e l’aggettivo, educativa.
Se si parte però dalla definizione del termine ‘ricerca’, questa chiarificazione rischia di essere troppo generica, oppure di portare molto oltre quanto prefissato nel presente lavoro. Per capire dunque di cosa stiamo parlando, è necessario soffermarsi in primo luogo sul secondo termine indicato: ‘educativa’.
La questione che qui preme sottolineare non riguarda tanto il riconoscimento dei livelli diversi di coerenza scientifica nel lavoro di ricerca, ma piuttosto l’interrogarsi su come sia possibile definire, e in che misura, un rapporto tra la ricerca in senso lato (che potremmo chiamare ‘atteggiamento di ricerca’) e la ricerca in senso stretto (chiamata ‘ricerca scientifica’).
Se infatti l’attenzione viene centrata solo sul metodo di analisi che si intende adottare, tralasciando invece i problemi che si considera prioritari trattare attraverso tale metodo, il rischio (che appare molto comune) diventa quello di giustificare ricerche prive di ogni rilevanza, ovvero pure esercitazioni formali spesso cariche di retorica. E perché succede questo? Perché si ha la presunzione (o il poco coraggio) di escludere dal dominio dell’analisi scientifica tutti quei problemi che, benché portatori di novità, non hanno ancora raggiunto un ‘sufficiente’ livello di coerenza formale.
Questo problema, che potremmo chiamare della gerarchizzazione della ricerca, ha un limite enorme: rafforza quella ‘frontiera’, ancora oggi a volte strenuamente difesa, tra ‘ricercatori di professione’ e ‘operatori sul campo’.
Se si esplorano tali problematiche attraverso la lente del discorso pedagogico, possiamo vedere che, storicamente, la separazione tra ricerca scientifica e ricerca non-scientifica ha comportato due ‘fatti’ significativi per la cultura occidentale, tra loro collegati.
Nel momento infatti in cui tale separazione ha coinciso con una pura distinzione logica tra gradi diversi di coerenza metodologica dell’analisi conoscitiva e delle sue scoperte (producendo le antinomie soggetto-oggetto, conoscente-conosciuto, uomo-natura, ecc.), ha contemporaneamente discriminato aprioristicamente le possibilità intellettive e creative di tutti gli individui che non rientravano in tale ‘logica’ (Foucault 1996; Kuhn 2009). Procedendo in tal senso, il discorso scientifico ha così elevato alcuni al rango di ‘scopritori’ della conoscenza assoluta e altri al ruolo subalterno di gregari di fronte alla medesima. L’organizzazione della società basata sulla divisione del lavoro non ha fatto altro poi che codificare tale stato di cose (facendolo passare per ‘naturale’), promuovendo così professionisti – e professioni – che si reggevano, e tuttora si reggono, su tale fallace distinzione.
In tempi recenti abbiamo assistito a un ribaltamento di tali divisioni, grazie sia alla condivisione di un concetto, quello di ‘democrazia’, diventato valido per tutti gli individui, sia grazie allo sviluppo delle diverse tecnologie che hanno permesso di riformulare l’organizzazione sociale del sapere e la sua acquisizione (Authier, Lévy 2000; Cambi, Toschi 2006; Lévy 1996).
Tutto questo ha portato a due acquisizioni fondamentali, profondamente integrate tra loro: la ri-formulazione della cosiddetta ‘conoscenza oggettiva’ da un lato e dall’altro la diversa articolazione delle modalità sociali di sviluppo della medesima.
Nel primo caso, è bene sottolinearlo da subito, non si tratta di svalutare – nella teoria come nella prassi – le procedure conoscitive della ricerca, banalizzandola e privandola del suo potenziale creativo in nome di una diffusione della conoscenza che apparirebbe così solo ‘ingessata’. Annullare infatti il confine tra ricerca ‘in senso lato’ e ricerca ‘in senso stretto’, per riprendere le due definizioni appena sopra riportate, non vuol dire doverle confondere sul piano del minore o maggiore controllo delle operazioni di analisi e di verifica, perché resta comunque sempre presente il minore o maggiore grado di inferenza scientifica dovuta alla coerenza delle procedure (teoriche, metodologiche, tecniche) impiegate.
Quello che però cambia, rispetto a un metodo ‘statico’ di concepire la ricerca, è invece il processo di scambio che si viene a determinare tra questo sistema di ricerca ‘in senso lato’ (che nasce come atteggiamento di ricerca) e quello ‘in senso stretto’ (che si esprime come ricerca scientifica). Tale processo investe innanzitutto le operazioni logiche da stabilire a fondamento dell’investigazione: è infatti il ricercatore ‘di professione’, quello inizialmente chiuso nella sua ‘torre d’avorio’, che misura le sue metodologie, le sue procedure di lavoro, il suo linguaggio con chi fa ricerca ‘nella quotidianità’, ovvero con chi – dotandosi di pochi o nulli strumenti e metodi – è sicuramente più immerso nella concretezza dei problemi del vivere sociale e nella loro urgenza (Morin 2005).
Questo rapporto dunque, che vede dialogare tra loro il ‘tradizionale’ addetto al lavoro di ricerca e il ‘tradizionale’ operatore sul campo, come anticipato, produce e costituisce un momento di arricchimento per entrambi. Attraverso tale scambio, infatti, il primo può ‘aggiustare il tiro’ del suo lavoro teorico in termini di obiettivi, metodi, tecniche e mezzi d’indagine, mentre il secondo può invece dotarsi di maggiore rigore, sistematicità e coerenza critica nel lavoro che porta avanti quotidianamente.
Nel fare ciò, inoltre, come vedremo a breve, si palesa in tutta la sua evidenza la necessità che tale dialogo, nei termini fecondi che qui si stanno discutendo, diventi possibile e concreto anche sul piano istituzionale.
1. 2 La ricerca disciplinare multipla tra teorie ed esperienze in pedagogia
Precisato, solo in termini introduttivi, in che senso viene qui utilizzato il termine ricerca riferita all’educazione, ora bisogna chiarire, anche se ovviamente soltanto come impostazione generale del discorso, cosa s’intende per ‘educazione’. Anche in questo caso occorre partire dall’esplicitazione di un concetto che è ‘a monte’, ovvero da quello di ‘pedagogia’.
Tutta la letteratura pedagogica contemporanea, esplicitamente o implicitamente, è attraversata da un grosso problema (che poi è comune, anche se in modalità diverse, a molte altre discipline), che può essere definito in questi termini: qual è lo statuto disciplinare della pedagogia, dal momento che la si è sottratta dalla tutela – unica e assoluta – della filosofia? (Cambi 2008; Mariani 2008; Pinto Minerva 2006).
Questa riflessione sicuramente si fa più complessa nel momento in cui si sottolinea che non si tratta di escludere la filosofia dall’orizzonte pedagogico, ma di separarsi da un modo che intende quest’ultima come un sistema chiuso, fatto cioè di una conoscenza assolutizzante che ‘esclude’, come abbiano precedentemente evidenziato, tutte le altre possibilità esplorative dell’intelligenza umana (Lévy 1996; Morin 2001, 2005; Orefice 2010).
Il ‘ripudio’ di questa ‘paternità’ filosofica genera però una preoccupazione, e cioè che la pedagogia si lasci assorbire, e annullare, da altri ambiti disciplinari di più recente costituzione storica, come la psicologia o l’antropologia culturale e sociale (Callari Galli 1993). Permettere che questo accada significa distruggere la riflessione pedagogica – costruita con centinaia d’anni di esperienze e di ricerche – rendendola di volta in volta solo metodologia psicologica, oppure metodologia antropologica culturale e sociale (per riprendere i due ambiti appena citati): fatto questo, la prospettiva formativa che le è propria rischia irrimediabilmente di scomparire.
Per tentare allora di ‘risolvere’ questo problema, nel dibattito scientifico contemporaneo sono state suggerite varie proposte al riguardo, indicando diverse vie metodologiche di approccio specifico alla pedagogia che dimostrano come questa, in quanto supporto disciplinare della ricerca educativa, è attraversata da tempo da una crisi di identità (Santoni Rugiu 1968) ma anche da fecondi e diversificati orientamenti recenti (Cambi, Frauenfelder 1994; Federighi 2006; Mariani 2008).
Tutto questo, come appare comprensibile, rende complesso lo sviluppo dell’indagine sull’educazione, proprio perché i fondamenti teorici della ricerca risultano essi stessi in uno stato di revisione e di continuo approfondimento.
Ci sembra dunque necessario, proprio per far fronte a questa ‘instabilità’, di dover indagare la ricerca educativa facendo nostra un’attenzione critica e privilegiando nello stesso tempo l’analisi epistemologica: quest’ultima, infatti, nel momento in cui ‘monitora’ la teoria e la pratica della ricerca educativa, è a sua volta illuminata dalle verifiche teorico-pratiche, permettendo così in maniera più agevole e coerente di individuare l’assetto strutturale della pedagogia stessa.
Queste prime considerazioni portano a considerare l’indagine sull’educazione come un sistema teorico aperto di analisi scientifica in continua ridefinizione, ovvero basato su ipotesi teoriche che sono assunte (anche se con diverso potenziale d’inferenza scientifica) come i primi oggetti del ricercare. Questa condizione teorica di lavoro è oggi universalmente accettata dalla riflessione pedagogica più avanzata sul piano scientifico, riconoscendo che la pedagogia si definisce essa stessa come ricerca educativa per antonomasia.
Partendo da questa veloce sintesi, incompleta e con tutti i limiti che ogni schematizzazione inevitabilmente comporta, è necessario allora esplicitare quale è la metodologia di approccio dell’analisi pedagogica a cui ci si rifà. Riconoscere infatti, come si è appena fatto, la necessità di collocare l’indagine in un sistema teorico di riferimento aperto e non rigido comporta l’individuare la prospettiva metodologica di analisi all’interno della quale poter collocare, per intrepretarle criticamente, le singole teorie della pedagogia.
Come anticipato, la risposta a tale problema è data dallo stesso dibattito sulla pedagogia, a cui si deve fare riferimento. Nonostante infatti la diversità di posizione riscontrate, ad eccezione di quelle poche che ancora sono rimaste vincolate alla unilateralità di una certa tradizione filosofica, tutte concordano nell’instaurare una riflessione sui processi educativi che non si limiti soltanto alle valenze filosofiche del discorso, ma abbia il coraggio (e la voglia) di allargarsi al più vasto campo delle scienze psico-biologiche, socio-culturali e politico-economiche (Contini 2006; Frauenfelder, Santoianni, Striano 2004; Mortari, Saiani 2013). Fare questo, dunque, significa predisporre un’apertura metodologica capace di comprendere quell’ampio ventaglio di discipline che si occupano, a vario titolo, dell’educazione e che rientrano nelle cosiddette scienze dell’educazione. Insomma, che si tratti di comporre nell’ambito della riflessione pedagogica materiali di origine diversa, di integrare tra loro diversi apporti disciplinari in una valenza specificamente pedagogica, o di collocare la pedagogia all’interno di nuove forme tecnologiche di sperimentazione didattica (de Mennato, Formiconi, Orefice, Ferro Allodola 2013; Gallelli, Annacontini 2012; Rivoltella 2012), tutti questi autori concordano nel recuperare la valenza interdisciplinare come presupposto fondamentale della pedagogia.
Chiarito dunque il problema, non certo nella sua complessità e articolazione, in termini d’impostazione strutturale del discorso pedagogico, ora è necessario definire altre questioni.
La prima riguarda la chiarificazione dei termini teorici e delle metodologie di analisi necessarie per instaurare il rapporto pedagogia/altre discipline a più livelli (multidisciplinare, pluridisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare).
Se la dimensione disciplinare dell’approccio al problema della ricerca educativa, infatti, partendo e muovendosi all’interno del discorso pedagogico, coinvolge come abbiamo detto altri ambiti disciplinari, è necessario che anche una ‘tipologia’ teorica della stessa ricerca conservi tale matrice; inoltre, gli stessi ‘livelli’ teorici di analisi vanno individuati rispettando tale conformità, e tenendo presente anche i possibili spessori di articolazione della ricerca (come già anticipato nelle pagine precedenti).
La tipologia cui si fa riferimento in questo caso è necessariamente per rapporti disciplinari, dato che la pedagogia, per ricercare un suo ruolo e una sua identità disciplinare, si colloca essa stessa in tale dimensione. Si raggiunge così, sul piano pedagogico, una ricerca educativa che diventa bio-pedagogica, antropo-pedagogica, psico-pedagogica ecc.
Tenendo inoltre presente che tale tipologia è solo un modello formale di lavoro, appare chiaro non solo che una stessa ricerca educativa possa esprimere uno o più tipi di ricerca (ad esempio antropo-culturale e storico-filosofica), ma soprattutto che tale schema costituisce un punto di riferimento per il lavoro di analisi e di sistemazione teorica dei dati d’indagine, e non rappresenta un criterio di riferimento concreto nell’organizzazione di tale indagine. Questa, infatti, proprio perché deve confrontarsi con la realtà educativa nel suo divenire (che non si sviluppa per ambiti disciplinari, ma per problemi relativi all’organizzazione del lavoro educativo) ha bisogno di un altro genere di tipologia, costruito a partire non con il criterio della coerenza formale del discorso pedagogico, ma con quello della strutturazione effettiva degli interventi nel settore dell’educazione.
Si tratta insomma, rispetto a quanto qui si sta discutendo, di una tipologia costruita sul piano empirico che non ha nessuna pretesa di ‘coerenza razionale’ se non quella derivante dall’analisi dell’attuale organizzazione sociale dei fatti educativi.
Da quanto detto, si può ritenere che le due tipologie di ricerca evidenziate (per ambiti disciplinari e per problemi empirici), anche se hanno finalità e criteri diversi, costituiscono due versanti non staccati ma integrati di un unico discorso: è cioè possibile risalire dai tipi della prima tipologia a quelli della seconda, e viceversa, nel senso che il luogo di verifica della tipologia teorica è individuabile all’interno della seconda, così come i supporti empirici della credibilità delle teorie stesse sono riscontrabili attraverso questa seconda tipologia di ordine pratico. Esiste cioè una linea continua, sul piano metodologico dell’analisi della ricerca educativa, che unisce in un movimento di andata e ritorno la teoria e la pratica, i modelli e la empiria.
Ed eccoci dunque giunti alla seconda questione da definire. Essa chiama direttamente in causa i contributi che la stessa ricerca educativa condotta da vari operatori, sia in sede teorica che di lavoro sul campo, ha potuto offrire per ridefinire la stessa pedagogia come ricerca educativa di tipo interdisciplinare.
Se si riprende quanto anticipato nel paragrafo precedente, si può ora arrivare alla conclusione che la relazione ricercatore-operatore è pienamente giustificata e si realizza, nella...