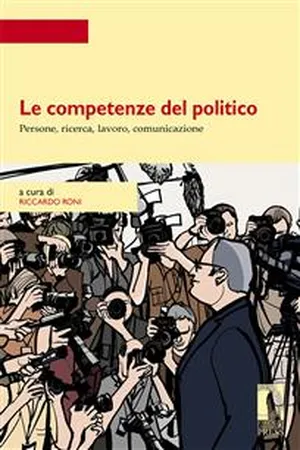![]()
La formazione nella società divisa. Scomposizioni filosofiche e politiche
Antonio De Simone
Premessa
Intendo in questa occasione soffermarmi con voi su alcuni dei tratti problematici del nostro presente caratterizzato dalla dimensione globale e universale della modernità contemporanea, dalle metamorfosi della democrazia (tra derive autoritarie e populismi), dalla ‘finanziarizzazione’ dell’economia e dal capitalismo cognitivo entro un quadro generale di profonde disuguaglianze che ne solcano la ‘soglia biopolitica’. A fronte della crisi dell’individuo e della Bildung (formazione) che lascia spazio alla frammentaria, dimezzata e difettiva diffusione della Halbbildung (semicultura, formazione dimezzata), espressione dell’onnipresenza dello spirito estraniato e forma dominante della coscienza contemporanea imprigionante tutta la dialettica dell’umano nelle maglie di una ‘de-umanizzata socializzazione’, la lezione dei ‘classici’ continua ancora a incidere nel nostro orizzonte concettuale, aprendo appunto dei ‘varchi’ con effetti anche performativi nel complesso rapporto che si instaura, per noi ‘contemporanei’, nel circolo ermeneutico tra vita, storia e politica e dei suoi effetti sulla morfologia del potere, ma soprattutto tra formazione, cultura ed educazione. Nelle ‘scomposizioni’ filosofiche e politiche che seguono tratterrò alcuni aspetti della problématique relativa alla questione della Bildung, cioè alla formazione umana dell’uomo muovendomi attraverso la riflessione di Gadamer e Adorno e oltre.
1. Filosofie della Bildung tra Hegel e Gadamer
Relativamente al concetto di Bildung, la cui traduzione in cultura non restituisce comunque la complessità e ricchezza semantica che invece conserva il termine nella sua lingua originaria, occorre rilevare che Hans-Georg Gadamer non solo riconosce a tale humanistischer Leitbegriff l’aver svolto un ruolo centrale nel processo di costituzione storica delle Geisteswissenschaften, ma egli stesso organizza prevalentemente importanti sezioni analitico-ricostruttive della prima parte di Verità e metodo proprio intorno al termine-chiave Bildung e a quelli a esso linguisticamente affini come Bild (immagine), Nachbild (riproduzione), Vorbild (modello), Gebilde (forma), Urbild (originale), Abbild (copia), Einbildungskraft (immaginazione).
Ricordando come l’affermarsi della parola Bildung affondi le sue radici nella tradizione mistica medievale, «per la quale l’uomo porta nella propria anima l’immagine (Bild) di Dio, secondo la quale è creato, e deve svilupparla in sé», Gadamer osserva che è soprattutto con il progressivo affermarsi, in un’ottica totalmente secolarizzata, del fondamentale significato herderiano di cultura come «innalzamento all’umanità» che si compie, nel periodo che separa Kant da Hegel, la trasformazione storico-semantica moderna del concetto di Bildung. Cultura ora è «un autentico concetto storico» e come tale è alla base delle Geisteswissenschaften. La cultura non conosce fini al di fuori di se stessa. Perciò, il suo stesso concetto trascende quello di «una pura coltivazione di disposizioni preesistenti»: cioè, «la coltivazione di una disposizione è lo sviluppo di qualcosa di dato, sicché l’esercizio e la cura di essa non è altro che semplice mezzo in vista del fine». Nella cultura autentica, invece, «ciò in cui e mediante cui ci si forma viene, come tale, fatto interamente proprio. In questo senso, ciò che entra nella cultura scompare in essa risolvendovisi, ma non come un semplice mezzo che ha perduto la sua funzione. Anzi, nell’acquisizione di una cultura nulla scompare, ma tutto viene conservato».
Nella storia moderna della parola Bildung, secondo Gadamer, è stato Hegel che, lungo il proprio itinerario filosofico, ha elaborato con il massimo rigore il suo concetto.
Ciò che Hegel chiama l’essenza formale della cultura consiste nella sua universalità. Proprio in base a questo concetto di innalzamento all’universalità Hegel poté abbracciare in un unico concetto quello che la sua epoca intendeva per cultura. Innalzamento all’universalità non è limitato alla cultura teorica e non significa in generale solo un comportamento teoretico in opposizione al comportamento pratico, ma designa la determinazione essenziale della razionalità umana nel suo insieme. È essenza generale di tutta la cultura umana quella di costituirsi come essenza spirituale universale. Chi si abbandona alla particolarità non è colto.
Così, ad esempio, come sottolinea Hegel nel § 41 della Philosophische Propädeutik, non ha cultura l’uomo che
si lascia andare alla sua ira e agisce ciecamente secondo questa passione, poiché in ciò egli considera un danno o un’offesa del danneggiatore o con altri oggetti senza misura e scopo. Non ha cultura – continua Hegel – chi afferma un interesse che non lo riguarda o in cui egli non può influire con la sua attività; poiché razionalmente si può fare interesse proprio soltanto ciò in cui con la propria attività si viene a capo di qualcosa. Inoltre – conclude Hegel – quando l’uomo diventa impaziente di fronte agli eventi del destino, egli fa del proprio particolare interesse un affare supremamente importante, come qualcosa secondo cui gli uomini e le circostanze avrebbero dovuto regolarsi.
Hegel, commenta Gadamer, «mostra che una persona simile, in fondo, manca di capacità di astrazione: non riesce a prescindere da se stesso e porsi da un punto di vista universale dal quale potrebbe determinare il suo particolare secondo misura e giusta proporzione». Intesa hegelianamente, dunque, la cultura (Bildung), in quanto «innalzamento all’universalità», è un compito peculiare dell’uomo, che come tale «esige il sacrificio della particolarità all’universale». Là dove, però, «sacrificare la particolarità significa, negativamente, controllare gli appetiti sensibili, conquistando la libertà dal loro oggetto e quindi la libertà per l’oggettività dell’oggetto stesso».
Ripercorrendo i transiti principali del concetto hegeliano di Bildung, Gadamer osserva che, nella Phänomenologie des Geistes, Hegel, come è noto, associa tale concetto a quello di lavoro, là dove, appunto, attribuisce al cammino della coscienza e al processo di autocostituzione dello spirito il segno distintivo di un lavoro. Infatti, caratterizzando fenomenologicamente, nella dialettica signoria-virtù e nella lotta per il riconoscimento, il significato della «figura» del lavoro anche come attività della coscienza, Hegel afferma che (dal punto di vista della coscienza servile) il lavoro è
appetito tenuto a freno, è un dileguare trattenuto, ovvero: il lavoro forma (bildet). Il rapporto negativo verso l’oggetto diventa forma dell’oggetto stesso, diventa ...