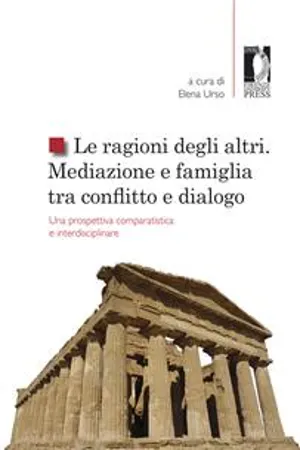1. Premessa
Negli ultimi trent’anni la mediazione è stata interpretata in modi diversi a seconda del grado di integrazione raggiunto con i differenti ordinamenti giuridici. In Italia è stata dapprima definita come un fenomeno nuovo e ‘rivoluzionario’, per i valori di cui si faceva portatrice rispetto al processo (Castelli 1996: 32); in seguito è stata considerata come un utile strumento per risolvere i conflitti familiari e sociali che poteva svilupparsi in parallelo al sistema giurisdizionale senza interagire con esso (cfr. le osservazioni di Scatolero 2006); infine, in quest’ultimo decennio, la mediazione civile e commerciale è stata regolata come un istituto giuridico, del tutto assimilato all’ordinamento e compatibile con i valori e i principi in esso affermati (Luiso 2005; Buonfrate, Leogrande 1999; Comoglio 2000; Chiarloni 1996). È da qui che vorrei cominciare la mia breve analisi, con una definizione che intende la mediazione come una ‘pratica giuridica’ di gestione dei conflitti, per considerare alcune aporie nel processo di adeguamento tra sistema giuridico e mediazione. La mia tesi è che, nonostante il processo di assimilazione operato dal legislatore e dalla scienza giuridica italiana, la mediazione sia veicolo di significati e principi che si pongono come incoerenti rispetto alla giurisdizione e che questa incoerenza sia un elemento di fecondità e una grande risorsa nel processo di ridefinizione degli strumenti giuridici di gestione dei conflitti.
2. Mediazione: uno strumento alternativo
La mediazione può essere definita come
un procedimento in cui le parti e i loro avvocati si incontrano con un mediatore neutrale, che ha il compito di assisterle nella ricerca di una soluzione della controversia. Il mediatore migliora la comunicazione tra le parti, le aiuta a manifestare più chiaramente i propri interessi e a capire quelli dell’altra parte; saggia i punti di forza e quelli di debolezza delle rispettive posizioni giuridiche, identifica aree di possibile accordo e aiuta le parti a formulare ipotesi di soluzione su cui ambedue possano concordare (Chase 2009: 116).
La mediazione è uno strumento di risoluzione dei conflitti che fa parte di una grande famiglia di metodi definiti come Alternative Dispute Resolutions. L’espressione fu coniata da Frank Sander, professore di diritto all’Università di Harvard, che illustrò la sua teoria durante la celebre Pound Conference del 1976 dedicata all’analisi delle «cause dell’insoddisfazione popolare nei confronti dell’amministrazione della giustizia» (cfr. Levin, Wheeler 1979). Considerando che ogni disputa è differente e pertanto anche i metodi di risoluzione delle dispute debbono esserlo, Sander propose di alleggerire il carico delle Corti ricorrendo a sistemi alternativi al processo ordinario, come la mediazione o l’arbitrato1. L’espressione Alternative Dispute Resolutions (così come il corrispondente acronimo ADR) fu universalmente accolta, tanto da essere ufficialmente adottata dall’Unione Europea nel Libro Verde del 20022.
Da oltre vent’anni, praticamente da quando Frank Sander la pronunciò, la dottrina ha lavorato sulla parola Alternative, per sostenere che la mediazione non deve essere considerata uno strumento alternativo al processo, che si pone in contraddizione con i suoi principi, ma come un metodo ‘appropriato’ (Menkel-Meadow 2001)3, adeguato a gestire determinate tipologie di controversie che si integra con gli altri strumenti giuridici, formando un sistema armonioso4 e complesso di gestione delle dispute. Coerente con la tesi dell’integrazione, è stata l’azione del nostro legislatore, che ha regolato la mediazione inserendola nel corpo del diritto processuale5. Lo stesso ha fatto il legislatore francese, paese a noi molto vicino per tradizione giuridica, struttura e principi dell’ordinamento, che ha introdotto la mediazione civile nel 1995, due anni dopo aver regolato la mediazione in ambito penale6. Nonostante gli ormai riusciti tentativi di assimilazione giuridica, la mediazione ha sempre incontrato notevoli resistenze da parte del ceto dei giuristi e dello stesso legislatore, almeno fino alla Direttiva Europea 2008/52, che ha introdotto il ricorso alla mediazione per le controversie transfrontaliere, incoraggiando gli Stati a prevederla anche per le controversie interne (cfr. Vaccà 2008; Biavati 2005; Ghirga 2006). Queste critiche spesso sono state minimizzate col riferimento alla tutela di interessi corporativi del ceto forense e alla rivendicazione di un monopolio professionale (Sitzia 2010). Tuttavia, a un’analisi meno superficiale del fenomeno, le resistenze dei giuristi alla mediazione rivelano il rifiuto di un modello di composizione delle controversie che solo in parte può essere ricondotto nelle categorie consolidate del sistema giuridico. Ciò che viene respinto riguarda proprio quell’alternatività che rappresenta il certificato di nascita della mediazione e che esprime un profondo cambiamento in atto nel sistema dell’amministrazione della giustizia e nelle stesse categorie giuridiche.
In effetti, il termine alternative con cui Sander presentò la mediation7 racchiudeva una profonda ambiguità, rivelata dai differenti contesti culturali e politici in cui negli Stati Uniti si era sviluppato il fenomeno dell’informal justice (Abel 1982). Alle sue origini si possono individuare almeno due grandi forze che congiurarono per la nascita di pratiche extragiurisdizionali di risoluzione dei conflitti (Menkel-Meadow 2005). L’una, esterna al sistema giuridico e politico istituzionale, presentava un progetto culturale radicalmente nuovo della società e dei suoi equilibri, proponendo la sperimentazione di nuove forme di giustizia, il ricorso a forme consensuali e non autoritative di composizione dei conflitti e di riconoscimento delle pretese individuali (Adler 1993:67; Auerbach 1983). L’altra, nata all’interno delle istituzioni giuridiche più importanti, come le corti giudiziarie, gli organi accademici e legislativi, voleva conservare l’efficienza del sistema giuridico, la sua adeguatezza ai nuovi equilibri sociali e alle pretese del mercato economico, migliorando, snellendo e riformando la giurisdizione.
Mentre la prima voleva modificare il sistema di gestione della conflittualità sociale, rifiutandone i meccanismi tradizionali e i valori di fondo, espressi attraverso i riti del processo, la seconda voleva modificare il sistema per conservarne la struttura portante e per riaffermarne i valori giuridici dominanti (Roberts, Palmer 2005: 66-67). Ancora oggi, nelle analisi e nei commenti che hanno accompagnato l’introduzione della mediazione nell’ordinamento giuridico italiano (Canale 2010; Cicero 2011; Russo 2010), possiamo cogliere differenti interpretazioni che, se da un lato mostrano uno strumento flessibile, coerente con i principi dell’autonomia negoziale, dall’altro rivelano un modello di gestione delle dispute basato sulla volontarietà e riservatezza che mal si adatta al sistema sanzionatorio, formale e burocratizzato introdotto dal legislatore. Accanto a un uso tecnico e strategico della mediazione, governato dalla ricerca dei risultati, ne possiamo cogliere uno etico, governato dalla ricerca di nuovi equilibri sociali e politici. Il primo riguarda l’obiettivo di limitare i costi e i tempi della giustizia, affiancando al processo ordinario una serie di metodi che consentano ai cittadini di risolvere le loro controversie raggiungendo accordi soddisfacenti ed evitando il ricorso al processo ordinario (cfr. Cappelletti, Garth 1978). In esso ricorre un aspetto quantitativo riferibile a una giustizia più o meno accessibile, più o meno costosa, più o meno lunga, più o meno soddisfacente.
Il secondo riguarda la stessa idea di giustizia che con questa pratica si intende realizzare: non si tratta infatti soltanto di migliorare il sistema giurisdizionale, semplificandolo, ma di considerare una nuova modalità nel raggiungimento delle soluzioni delle dispute e degli accordi stessi. In esso ricorre un aspetto qualitativo che riguarda un modo consensuale di gestire i conflitti, che consente alle parti di raggiungere autonomamente una soluzione, senza dover sottostare alla decisione di un giudice. Come dice Taruffo «[…] appare evidente che alla base dell’alternativa tra l’ADR e il processo giudiziario vi sono più profonde e complesse implicazioni culturali, che vanno ben oltre il puro e semplice problema pratico della scelta dello strumento più rapido e meno costoso per risolvere una controversia» (Taruffo 2002: 29).
La relazione tra i sistemi di risoluzione dei conflitti e il sistema culturale entro il quale si sviluppano, a cui allude Taruffo, non è certo una recente scoperta dell’antropologia, tuttavia, offre spunti molto fecondi per una teoria della mediazione. Ogni modo di risoluzione dei conflitti, se da un lato è espressione di significati ed equilibri sociali, dall’altro a sua volta li determina e modella secondo nuove modalità. Chase sostiene l’implicita natura costitutiva dei sistemi di risoluzione delle dispute: così come il processo riflette un particolare sistema di valori, allo stesso modo lo plasma, conservando e spesso modificando l’ordine politico attraverso la gestione delle controversie sociali. La presenza della giuria nel processo civile americano, così come la sua assenza in quello italiano, o la domanda rivolta a un oracolo in quello del popolo degli Azande, hanno la medesima valenza, quella di esprimere in modo del tutto adeguato un sistema culturale, ridefinendone costantemente gli equili...