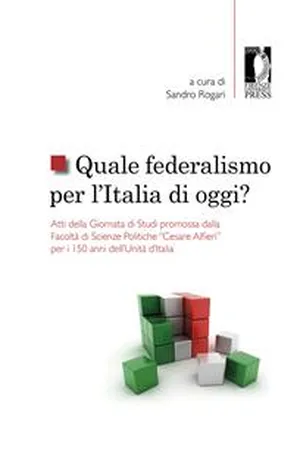![]()
Profili della finanza regionale suscettibili, con la riforma, di un reale cambiamento
Enrico Buglione
La relazione si concentra sul sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e, in particolare, sull’autonomia finanziaria di questo livello di governo e sul connesso sistema dei controlli posti in essere dal governo centrale. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza le innovazioni più importanti che, in materia, a mio avviso potrebbero scaturire dalla riforma delineata nella legge 42/2009 e definita più in dettaglio con il D. Lgs. 68/2011, nonché gli effetti che su tali innovazioni potrebbe produrre l’attuale crisi economica e finanziaria.
Per spiegare il possibile impatto della riforma, un breve quadro storico è indispensabile.
Dal 1970, anno dell’effettiva istituzione delle regioni ordinarie, a oggi, l’autonomia finanziaria delle regioni ha subito profonde trasformazioni, accompagnate da cambiamenti così evidenti sul versante della strategia dei controlli del governo centrale sulla gestione delle loro politiche di bilancio, da permettere di distinguere nettamente due fasi: quella della ‘catena’ e quella del ‘braccialetto elettronico’.
La fase della ‘catena’ è durata dal 1970 fino ai primi anni Novanta. L’autonomia finanziaria delle regioni era gravata da una serie di vincoli molto invasivi, scarsamente efficaci per quanto riguarda il rispetto degli equilibri di bilancio, ma anche molto appariscenti – di qui il riferimento alla ‘catena’ – potendo essere facilmente colti attraverso la semplice lettura dei loro bilanci.
In questo periodo le regioni ordinarie avevano già un ruolo importante nell’economia e nella pubblica amministrazione: le loro spese rappresentavano l’8% del Pil e gestivano circa il 23% del totale della spesa pubblica consolidata. Ciò nonostante esse non avevano:
- • alcuna autonomia tributaria (il gettito dei tributi propri era pari a circa il 2% delle loro entrate);
- • e neppure alcuna autonomia di spesa. I loro interventi in tutte le materie di competenza erano finanziati con trasferimenti vincolati assegnati dallo Stato e il cui importo veniva deciso annualmente in base alle esigenze di spesa del governo centrale. Ciò valeva anche per una delle materie già allora più importanti, cioè l’assistenza ospedaliera prima e, poi, a partire dal 1978, tutta l’assistenza sanitaria.
La totale dipendenza dai trasferimenti, oltre a indebolire l’accountability delle regioni, finiva per rendere lo Stato l’unico responsabile della copertura dei loro disavanzi, non avendo le regioni il potere di aumentare il prelievo tributario sui propri cittadini. Disavanzi, tra l’altro, facilitati dalla scarsa trasparenza dei bilanci regionali, per la redazione dei quali il governo aveva lasciato ampi margini di discrezionalità, probabilmente non ritenendoli documenti di programmazione di particolare importanza.
Nel corso degli anni Novanta, per risolvere questi problemi e per favorire il risanamento della finanza pubblica in vista dell’ingresso dell’Italia nell’Area Euro, attraverso una serie di provvedimenti legislativi il sistema di finanziamento delle regioni ha subito una profonda riforma. Tale riforma ha coinvolto anche le modalità attraverso le quali il governo centrale ha continuato a esercitare, tra l’altro in modo più efficace, la propria influenza sulle politiche di bilancio regionali. I vincoli, da questo momento in poi, solo in parte sono rintracciabili nei bilanci delle regioni, essendo, per così dire, soprattutto nascosti nella legislazione di settore e nelle manovre con le quali, ogni anno, si interviene in tutti i comparti della pubblica amministrazione al fine di garantire il rispetto del Patto europeo di stabilità e crescita.
Dalla fase della catena si è quindi passati a quella del braccialetto elettronico, cioè a un approccio forse più efficace del precedente ma di sicuro più discreto e che presuppone un atteggiamento collaborativo da parte del controllato. Tale approccio, del resto, appare coerente con quanto previsto nel Titolo V della Costituzione, come modificato nel 2001, ed è riproposto nella recente riforma del sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge delega n. 42/2009.
Nella relazione ci si concentra direttamente sulle principali caratteristiche della finanza regionale nella fase del braccialetto elettronico, in quanto è su queste che la riforma del 2009 è destinata a impattare. In particolare, si esaminano tre aspetti di particolare importanza: l’autonomia tributaria; l’autonomia di spesa; le strategie per garantire la coerenza tra risorse messe a disposizione delle regioni e costi delle loro funzioni. Si mettono poi in luce alcuni elementi che potrebbero favorire la nascita di ‘sistemi regionali delle autonomie’ e, quindi, l’efficienza della spesa decentrata. Infine, si tenta una sintesi delle ombre e delle luci del nuovo modello di finanziamento delle regioni e, per queste ultime, si cerca di valutare quali potranno resistere all’impatto della crisi economica e finanziaria.
1. Autonomia tributaria
Attualmente – e quindi prima dell’attuazione della legge 42 – i tributi propri, per effetto delle riforme adottate nel corso degli anni Novanta, hanno una importanza significativa nei bilanci delle regioni. Il loro gettito – derivante per il 74% dall’Irap, per il 15% dall’addizionale Irpef e per il 9% dalla tassa automobilistica, assicura infatti il 45% del totale delle entrate correnti.
Questo è quanto risulta dai bilanci. Se però si considera anche il dato normativo, ci si accorge che, in realtà, l’autonomia tributaria delle regioni è fortemente condizionata. Infatti:
- • tutti gli attuali tributi propri sono istituiti, e in parte disciplinati, dalla normativa statale. Le regioni, con propria legge, possono modificare alcuni aspetti del tributo ma non possono non applicarlo;
- • per l’addizionale Irpef e per l’Irap le aliquote di base previste dallo Stato possono essere aumentate entro un tetto massimo. Per l’addizionale Irpef possono essere anche ridotte fino a un tetto minimo e il range di manovrabilità è simmetrico (+/–1% dell’aliquota di base). Il governo centrale, per tutti gli attuali tributi propri delle regioni, può sempre intervenire con propria legge per sopprimere il tributo o per modificarne la disciplina generale. Per esempio, per l’Irap, è stata ridotta l’aliquota base (dal 4,25% al 3,90%) ed è stata a più riprese modificata la base imponibile (se da tali interventi derivano variazioni di gettito, vengono poste in essere apposite compensazioni);
- • il governo centrale può obbligare le regioni con rilevati deficit nel settore sanitario ad applicare l’addizionale Irpef e l’Irap con le aliquote massime previste. Quando il risanamento del deficit lo richieda, il governo può intervenire direttamente, introducendo aliquote straordinarie superiori alle massime;
- • infine, già da diversi anni il governo con le leggi annuali per il contenimento della spesa pubblica, al fine di impedire incrementi della pressione tributaria nazionale, ha bloccato, per le regioni, la possibilità di maggiorare le aliquote dell’addizionale Irpef e dell’Irap, salvo che in quelle con rilevanti deficit sanitari.
Si può quindi affermare che, per le regioni ordinarie, da una situazione di evidente mancanza di autonomia impositiva durata fino ai primi anni Novanta (fase della catena) si è passati a una nella quale tale autonomia formalmente esiste, ma è sottoposta a una serie di vincoli contenuti nelle leggi che disciplinano i singoli tributi o in altri provvedimenti, come le leggi finanziarie prima e, ora, i decreti legge per il risanamento della finanza pubblica e le leggi di stabilità (fase del braccialetto elettronico).
Con la riforma, la situazione non cambia molto. In primo luogo, la struttura delle imposte regionali resta la stessa e l’Irap e l’addizionale Irpef saranno sempre quelle che forniranno la maggior parte del gettito. In secondo luogo, la manovrabilità delle due imposte principali viene effettivamente ampliata, ma in modo asimmetrico. Per gli aumenti dell’aliquota di base sono previsti specifici tetti: per l’Irap +1%, come attualmente; per l’addizionale Irpef fino al +2,1% ma maggiorazioni pari o superiori all’1,1% potranno essere applicate solo in presenza di certe condizioni. Per le diminuzioni, invece, limiti quantificati non sono previsti: per l’Irap le regioni potranno ridurre l’aliquota di base fino ad azzerare il prelievo; per l’addizionale Irpef, l’aliquota di base potrà essere ridotta fino a ottenere solo il gettito corrispondente all’ammontare dei trasferimenti che, attualmente, ciascuna regione eroga ai propri comuni.
L’ampia riducibilità del prelievo Irap e addizionale Irpef, pur essendo stata una delle innovazioni più pubblicizzate, di fatto sarà molto difficile da mettere in pratica. Infatti le aliquote standard di queste due imposte verranno definite dal governo in modo che il gettito da esse ottenibile – sommato al gettito della nuova compartecipazione Iva prevista dalla riforma e alle assegnazioni del fondo perequativo – corrisponda esattamente al fabbisogno valutato come sufficiente a garantire, in tutto il territorio e in ogni regione, i livelli standard di prestazione previsti in materia sanitaria e in alcuni altri settori considerati prioritari (assistenza sociale, istruzione, trasporto pubblico locale per la parte investimenti).
È invece molto più probabile un incremento generalizzato – e, quindi, di fatto obbligato – delle due imposte, nei margini e alle condizioni consentiti dal decreto, al solo scopo di mantenere a livelli accettabili servizi essenziali come il trasporto pubblico locale, l’assistenza sociale e la stessa sanità, in modo da contrastare la riduzione delle risorse disponibili causata dai tagli decisi dal governo con le ultime manovre.
2. Autonomia di spesa
Se si mettono a confronto i bilanci delle regioni per il 1990, con quelli, per esempio, del 2005, si osserva un radicale cambiamento: nei primi l’80% delle risorse deriva da trasferimenti vincolati, nei secondi l’80% delle risorse deriva da entrate libere, cioè da tributi e da assegnazioni del fondo perequativo. Ciò si deve alle riforme attuate nel corso degli anni Novanta e culminate con il D. Lgs. 56/2000, per effetto delle quali gran parte dei trasferimenti vincolati – e in primo luogo quelli destinati al finanziamento della sanità – sono stati sostituiti, appunto, con entrate a destinazione generica.
Il dato di bilancio, però, relativo alla situazione attuale è uno specchio fedele autonomia di spesa delle regioni? In realtà no. Bisogna infatti ricordare che, contemporaneamente alla liberalizzazione delle entrate sopra descritta, il governo centrale ha adottato nuove strategie attraverso le quali influire in modo più discreto ma non meno efficace sull’esercizio delle funzioni conferite alle regioni e, più in generale, sulla gestione del loro bilancio, al fine di garantire il raggiungimento di alcune esigenze prioritarie.
Tra queste se ne devono richiamare due:
- • quella di rendere la gestione della finanza regionale (e locale) coerente con le politiche di finanza pubblica decise a livello nazionale;
- • quella di assicurare su tutto il territorio livelli essenziali di prestazio...