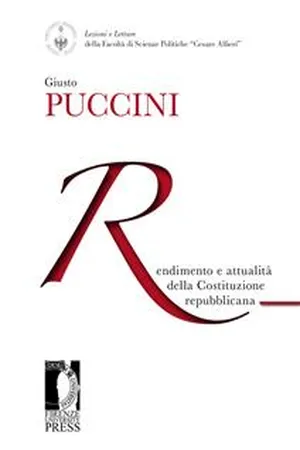![]()
Rendimento e attualità della Costituzione repubblicana
1. Premessa
Un attendibile giudizio complessivo sul rendimento e sull’attualità della nostra vigente Costituzione non può essere di certo utilmente fondato su di un riferimento puntuale a tutte quante le norme costituzionali considerate distintamente e isolatamente l’una dall’altra, e su di una valutazione circa l’attualità e il rendimento di ciascuna di esse.
Ben altra utilità sembra invece presentare, ai nostri fini, un giudizio circa il rendimento e l’attualità, nel loro complesso, di ciascuna delle parti della normativa della Costituzione inerenti ai tre principali profili del disegno costituzionale, ovverosia: a) la forma di Stato intesa come l’insieme delle finalità e dei valori ispiratori dell’azione dei pubblici poteri, e come modo di atteggiarsi dei rapporti intercorrenti fra questi ultimi e la comunità; b) l’organizzazione e il funzionamento dei pubblici poteri statali; c) la forma di Stato intesa come modo di atteggiarsi dei rapporti intercorrenti fra Stato ed enti territoriali decentrati.
Ebbene, tali diversi profili sembrano prestarsi a giudizi fra loro – talvolta anche accentuatamente – differenziati, ora con riguardo al rendimento, ora con riguardo all’attualità, ora, infine, con riguardo ai rapporti fra il primo e la seconda.
2. La normativa costituzionale inerente ai rapporti fra pubblici poteri e comunità: rendimento
Così, sulla parte della normativa costituzionale inerente al profilo sub a), parrebbero potersi esprimere un giudizio considerevolmente positivo circa il rendimento, e un giudizio interamente positivo circa l’attualità.
Si tratta, com’è ben noto, della quasi totalità delle norme relative ai Principi fondamentali, di quelle ricomprese nella Parte prima della Costituzione, concernente i «diritti e doveri dei cittadini», e di quella dettata dall’art. 139 circa l’immutabilità della «forma repubblicana»: dunque, di tutte quelle norme tendenti a disegnare, per il nostro ordinamento, una forma di Stato essenzialmente riconducibile al modello di quello che taluni chiamano Stato democratico-sociale, altri Stato liberal-democratico, altri ancora Stato di democrazia pluralista.
A quest’ultimo proposito, d’altronde, non appare condivisibile l’opinione da ultimo espressa da alcuni studiosi, secondo cui una simile forma di Stato, sul versante della tutela dei diritti sociali, sarebbe stata profondamente intaccata dalla recente introduzione nel testo della nostra Costituzione, con la legge costituzionale n. 1/2012, del principio del pareggio di bilancio: principio che, «if taken seriously», dovrebbe appunto ritenersi «not compatible with the guarantee of fundamental social rights, that qualifies the Italian form of State», e avrebbe quindi inammissibilmente operato «a potential hidden change of the “core provisions” of the Italian Constitution».
Orbene, a siffatta opinione viene piuttosto immediato obbiettare che una modifica costituzionale del genere parrebbe destinata, in realtà, non tanto a compromettere irrimediabilmente la tutela dei diritti sociali, quanto piuttosto a renderla soltanto assai più faticosa e problematica dal punto di vista politico.
Il principio in questione, infatti, implica essenzialmente il divieto per lo Stato, in condizioni di normalità del ciclo economico, di ricorrere all’indebitamento.
Il che, dunque, non esclude affatto la possibilità di provvedere alla copertura delle eventuali maggiori spese ritenute necessarie per la tutela dei diritti sociali attraverso un aumento dell’imposizione fiscale e/o attraverso la riduzione di spese da considerarsi inutili. Ciò posto, per quel che attiene al rendimento delle norme della Parte prima e dei Principi fondamentali ad esse strettamente correlati, occorre immediatamente riconoscere che non mancano di certo casi assai rilevanti e significativi di insoddisfacente applicazione o attuazione.
Fra questi, sul fronte dei diritti civili e politici, individuali e collettivi, spiccano sicuramente quelli – palesemente carichi di riflessi sul versante dell’attuazione del principio democratico sancito dall’art. 1 – relativi all’art. 21 in materia di libertà di manifestazione del pensiero, all’art. 48 in materia di diritto di voto e all’art. 49 in materia di partiti politici.
Per quanto concerne l’art. 21, in effetti, è piuttosto agevole constatare come, nel decisivo settore dell’emittenza radiotelevisiva su scala nazionale, esso non sia riuscito ad arginare, in concreto, l’affermarsi e il progressivo consolidarsi di posizioni monopolistiche o, quanto meno, nettamente dominanti sul versante dell’emittenza privata.
Per quanto concerne l’art. 48, è ben noto come la vigente legge elettorale per la Camera e il Senato (L. n. 270/2005), contemplando un premio di maggioranza abnorme per le elezioni della Camera, un premio di maggioranza a livello regionale per quelle del Senato, e liste di candidati ‘bloccate’, susciti serie e fondate perplessità circa la sua compatibilità con i principi di uguaglianza, libertà e personalità del voto.
Per quanto concerne l’art. 49, non può negarsi che il suo essenziale intento ispiratore di individuare nel partito politico il principale strumento di esercizio della sovranità popolare in chiave partecipativa risulti ormai da tempo, di fatto, alquanto frustrato dal sempre più diffuso manifestarsi, nel sistema politico, di deprecabili fenomeni degenerativi, specie sul terreno della democrazia interna dei partiti e su quello della loro gestione finanziaria, contribuendo in modo decisivo ad un sempre più accentuato scollamento fra ‘politica’ e società civile.
Sul terreno dei diritti inviolabili, inoltre, è noto come l’effettività del diritto di difesa, contemplato dall’art. 24, sia stata in passato e sia tuttora sensibilmente frustrata tanto da un’eccessiva lentezza dei processi quanto da comportamenti della magistratura che non sempre appaiono ispirati a una logica di totale e indiscutibile imparzialità.
A tali casi, infine, non può certamente farsi a meno di aggiungere quello – immediatamente ricollegabile all’adempimento del dovere di solidarietà economica e sociale imposto dall’art. 2 – dell’art. 53, inerente al dovere contributivo di tutti i cittadini: articolo la cui ...