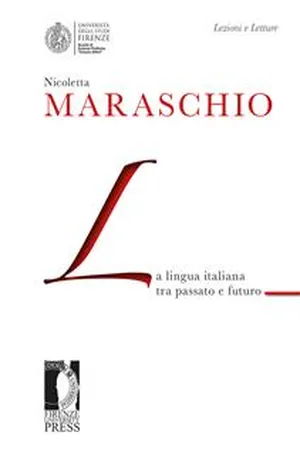
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
La lingua italiana tra passato e futuro
About this book
Il libro disegna un breve profilo della storia linguistica italiana e affronta alcuni problemi attuali legati alla globalizzazione, ai valori del multilinguismo e all'esigenza di rifondare su nuove basi la politica linguistica italiana ed europea. L'italiano contemporaneo è un bene culturale particolarmente stratificato, nel quale si possono cogliere, accanto ai molti elementi nuovi, i segni evidenti e preziosi di un fortissimo legame con il passato. Nel panorama europeo, l'Italia di oggi si distingue, infatti, per l'accentuato multilinguismo e la lunga durata della lingua nazionale. Da una parte, alla straordinaria biodiversità animale e vegetale corrisponde nel nostro Paese una straordinaria diversità culturale e linguistica; dall'altra, tutti noi sentiamo che la lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio ancora ci appartiene, e coincide nei tratti fondamentali con la nostra. Una simile ricchezza, particolarmente apprezzata all'estero (come dimostra la crescente domanda di italiano nel mondo), merita di essere maggiormente conosciuta dalle giovani generazioni, e inoltre tutelata e valorizzata con strumenti adeguati, a cominciare da un deciso ripensamento della politica linguistica nazionale. Nicoletta Maraschio. Ha svolto attività di insegnamento e di ricerca sia all'Università di Firenze, come professoressa ordinaria di Storia della lingua italiana, sia all'Accademia della Crusca, di cui dal 2008 al 2014 è stata presidente. I suoi studi riguardano temi e autori diversi lungo tutto l'arco della storia linguistica italiana: da Boccaccio, Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, i trattati di fonetica cinquecenteschi, Salviati e il Vocabolario della Crusca, fino a Pirandello e Pratolini. Particolare attenzione ha dedicato all'evoluzione del sistema grafico e interpuntivo italiano dal Medioevo al Novecento. Si è molto occupata di politica linguistica e della lingua dei grandi mezzi di comunicazione del Novecento. Dirige insieme ad altri colleghi la collana "L'italiano in pubblico" (editore Cesati). Ha svolto attività di insegnamento all'estero presso università europee e americane. Nel 2011 è stata insignita dal Presidente della Repubblica dell'onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica; nel 2015 è stata nominata professoressa onoraria dell'Ateneo fiorentino. Tra le ultime pubblicazioni: Lingue e diritti. Le parole della discriminazione. Diritto e letteratura, Firenze, Accademia della Crusca, 2014, curato con Domenico De Martino e Giulia Stanchina e Città d'Italia. Dinamiche linguistiche postunitarie, Firenze, Accademia della Crusca, 2014, curato con Emanuele Banfi.
Frequently asked questions
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Information
Table of contents
- Presentazione
- La lingua italiana tra passato e futuro
- Note bibliografiche