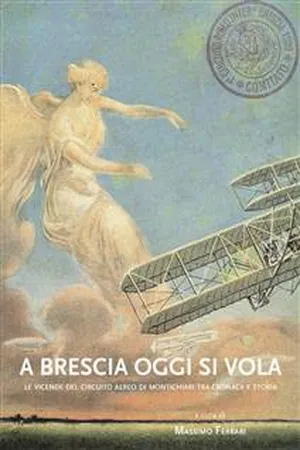![]()
CRONACA DI UN EVENTO
di Franco Ragni
Nei primi anni del XX secolo – particolarmente tra 1904 e 1907 – le gare automobilistiche sul Circuito di Brescia avevano costituito un appuntamento europeo irrinunciabile e la città lombarda era divenuta una delle capitali internazionali degli sport motoristici, acquisendone un prestigio universalmente riconosciuto.
Sennonché l’Automobile Club di Milano, “motore” istituzionale dell’iniziativa grazie all’autorevolezza rappresentativa esercitata nel settore, affidò invece le grandi gare del 1908 a Bologna. La città ospite, ovviamente, era chiamata a contribuire in risorse economiche, mezzi e infrastrutture, acquisendone comunque notorietà, prestigio e afflusso di visitatori, e in quell’anno le intese di questo tipo con Brescia si erano rivelate difficili e apparentemente autolesionistiche da parte delle istituzioni della città lombarda.
Quest’ultima aveva comunque patito l’esclusione come una sconfitta, e c’era una gran voglia di rivincita. Proprio allora, però, la giovanissima industria dell’automobile era entrata per la prima volta in un periodo di grave crisi, senza contare che la Francia, capitale indiscussa della modernità e della motorizzazione, aveva da quell’anno intiepidito molto la propensione a questo tipo di competizioni e, senza una significativa partecipazione francese, si sarebbe corso il rischio di un “non evento”.
Occorreva un’alternativa, e che fosse di gran livello. Infatti lo fu: l’idea – che allora sembrò temeraria – di un grande Circuito aereo.
Di gran livello era anche il “pretesto”: il cinquantenario della Seconda guerra d’indipendenza (1859), la cui battaglia risolutiva (S. Martino e Solferino) si era combattuta in località prossime a Brescia. E non bastava: Giuseppe Zanardelli, il più illustre dei bresciani dell’epoca, grande protagonista della vita politica tra fine Ottocento e primi del Novecento nei ruoli di Ministro della Giustizia, prima, e poi Presidente del Consiglio col nuovo Re Vittorio Emanuele III, era scomparso da pochi anni ed era in esecuzione un grande monumento a lui dedicato.
Dato il suo passato “risorgimentale” tutto combinava: la ricorrenza e l’inaugurazione del monumento; non solo: in sintonia col radicale anticlericalismo del personaggio, quest’ultima si sarebbe tenuta il 20 settembre, anniversario della presa di Roma e data attorno alla quale far ruotare gli appuntamenti delle “grandi feste” organizzate a contorno.
Queste ultime, nello spirito dell’epoca, avrebbero assunto anche il significato di celebrazione di una modernità le cui manifestazioni a cavallo dei due secoli, erano state tali da togliere il fiato: l’elettricità con tutte le sue applicazioni; la telefonia e la radiotelegrafia; il motore a scoppio; l’automobile; il sottomarino; il dirigibile e l’aeroplano; l’acqua corrente, il gas e i servizi igienici in casa; i raggi X; il cinema e molto altro.
Due, così, gli eventi principali: una “Esposizione internazionale sulle applicazioni dell’elettricità” e, appunto, un “Circuito”, inizialmente e tradizionalmente concepito come automobilistico ma quasi subito convertito in aereo; evento che poi finì per sopravanzare di gran lunga – per impatto mediatico sull’opinione pubblica – l’Esposizione e tutte le altre iniziative e manifestazioni.
L’annuncio clamoroso
Fu ai primi di ottobre del 1908 che sugli scarni quotidiani dell’epoca uscì la notizia di un “Circuito aereo” in programma a Brescia per l’anno successivo. L’annuncio destò comprensibilmente vivo interesse presso il pionieristico mondo aeronautico europeo e americano (per non parlare di quello nazionale).
Per dare un’idea della situazione allora corrente: in quell’ottobre del 1908, in tutto il mondo gli aeroplani veramente “volanti” (pochi metri da terra, possibilità di manovrare e almeno qualche minuto di durata) si potevano contare all’incirca sulle dita di due mani, o poco più, quasi tutti in Francia.
Per stare in Italia, si consideri che all’epoca le uniche esperienze di volo a motore con un “più pesante dell’aria” si limitavano alle esibizioni che il francese Lèon Delagrange aveva tenuto tra maggio e luglio dello stesso anno in Roma, Milano e Torino, con un “primo volo” – a Roma – il 24 maggio, ovvero solo quattro mesi prima dell’annuncio del “Circuito” bresciano.
A questo punto appare superfluo precisare che in quel momento in Italia non esisteva alcun aeroplano e tantomeno un pilota.
Sorprendentemente, nel primo ambizioso progetto il percorso del Circuito aereo bresciano consisteva in una sorta di rettangolo di 29 chilometri di perimetro, tra la “base” a Castenedolo e i paesi di Ciliverghe, Calcinato, Montichiari e Ghedi; giro da ripetersi cinque volte per un totale di 145 chilometri!
L’ipotesi era assolutamente irrealistica e, diremmo, “strana” dato che nessuna macchina volante di quell’epoca (autunno 1908) sarebbe stata in grado di “fare l’impresa”.
Parrebbe perciò che, data la rapidità dei progressi che allora si riscontravano da un mese con l’altro nel settore, siano state prese alla lettera possibili previsioni ottimistiche espresse dai Wright e da autorevoli esponenti del mondo aeronautico francese, coi quali aveva preso contatto Arturo Mercanti nel corso della trasferta in Francia che i famosi aviatori americani avevano effettuato nell’estate del 1908.
Va da sé che, nella fase di messa a punto, ci si premurò di ripiegare su un più realistico percorso di 10 chilometri a forma di anello schiacciato, con base nei pressi della località Fascia d’Oro di Montichiari, già famosa come teatro dei circuiti automobilistici bresciani.
Chi era Mercanti? Classe 1875, bresciano di Calcinato ma nato a Milano, era all’epoca Segretario generale del Touring Club Italiano, ma soprattutto era figura già nota a livello internazionale quale “organizzatore sommo” di tutto quanto si muoveva in Italia nel settore degli sport motoristici o comunque moderni (anche gli sport invernali, ad esempio), divenendo così protagonista-ombra di tutte le grandi gare automobilistiche/motociclistiche di inizio secolo che proprio sul “Circuito di Brescia”, erano divenute appuntamenti irrinunciabili per tutti i competitori europei.
Senza, di norma, esporsi a livello mediatico, fu un protagonista della vita pubblica nazionale almeno fino a tutti gli anni Venti.
Ma tornando al Circuito: questo venne adeguatamente propagandato in Francia dove, al Salone dell’automobile del dicembre 1908 a Parigi, lo stand del Touring Club Italiano dedicava spazio alla manifestazione bresciana, presentata con un accattivante richiamo: «100.000 franchi di premi».
Nel frattempo modesti e faticosi meeting aeronautici vennero indetti in Francia, tra giugno e luglio 1909 a Parigi, Douai e Vichy, ma fu Reims, dal 22 al 29 agosto 1909 a conquistare la palma della prima “vera” riunione aerea competitiva della storia.
Brescia non poteva farsi illusioni (e infatti non se ne fece): l’iniziativa era estremamente innovativa, ma “invadeva un campo” – per così dire – in cui dovevan per forza farsi i conti col “centro del mondo”, con la Francia, com’era stato, peraltro, nel caso dei circuiti automobilistici, nei quali comunque si era arrivati a competere alla pari.
La Grande Semaine di Reims “giocava in casa” (quasi tutti gli aviatori dell’epoca erano francesi) e conobbe effettivamente – e comprensibilmente – un successo di partecipazione superiore. Ma il Circuito aereo bresciano ebbe, dalla sua, il prestigio e la credibilità acquisiti negli anni precedenti con le competizioni automobilistiche internazionali; in effetti godette di seria considerazione da parte francese e i transalpini non ebbero perciò problemi a venire a Brescia nell’aprile 1909 allo scopo di stabilire accordi e uniformare regolamenti di gara, procedure, segnaletica e ogni altro aspetto organizzativo d’interesse comune.
Il citato Mercanti, autentico Deus ex machina della complessa e inedita macchina organizzativa, nel novembre 1908 fu mallevadore della trasformazione della “Società di aviazione di Milano” in “Società italiana di aviazione” e non ebbe alcun problema a coinvolgere nell’organizzazione anche l’influente “Società aeronautica italiana” di Roma (che in ambito nazionale rappresentava anche la Fai-Federazione aeronautica internazionale).
Furono così automaticamente cooptati nel comitato organizzatore del Circuito i due Presidenti, rispettivamente il sen. Cesare Mangili e il principe Scipione Borghese, quest’ultimo ancora aureolato dalla vittoria automobilistica del 1904 nel raid competitivo Pechino-Parigi, insieme al giornalista Luigi Barzini e al meccanico Ettore Guizzardi.
Circa il ruolo di Arturo Me...