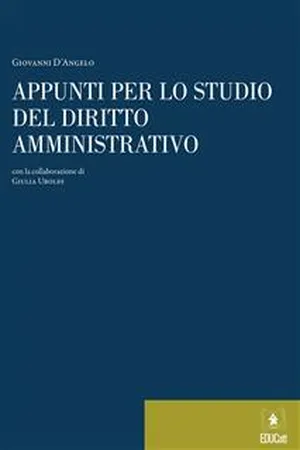![]()
PARTE PRIMA
DIRITTO AMMINISTRATIVO SOSTANZIALE
![]()
I.
Soggetti pubblici e soggetti privati
§ 1. L’ente pubblico
La classificazione di una persona giuridica come ente pubblico comporta conseguenze di ordine sostanziale e processuale.
Dal punto di vista sostanziale ciò implica, ad esempio, l’assoggettamento al controllo della Corte dei conti previsto nella l. 21 marzo 1958, n. 259, la natura amministrativa degli atti di organizzazione interna e l’esclusione dal fallimento. Su quest’ultimo punto, la giurisprudenza più recente è nel senso di sostenere che le società c.d. pubbliche costituite in forma di società di capitali non mutino la propria natura di soggetti privati solo perché un ente pubblico ne possieda, in tutto o in parte, il capitale. Ne consegue che tali società non sono escluse dal fallimento [Cass., sez. I, 27.9.2013, n. 22209]. Ciò a differenza delle società in house providing, che sono ritenute una ‘derivazione’ o una ‘longa manus’ dell’ente pubblico controllante [Corte cost., 20.3.2013, n. 46 e 17.11.2010, n. 325; Cons, Stato, ad. plen., 11.7.2008, n. 1]. Dunque, rispetto a questo modello di società dovrebbe valere la regola dell’esclusione dal fallimento [sulla riconducibilità del patrimonio della società in house all’ente pubblico controllante cfr. Cass., sez. un., 25.11.2013, n. 26283; sul modello in house, v. Parte I, cap. 11, § 2].
Dal punto di vista processuale, invece, la classificazione di una persona giuridica come ente pubblico può comportare la devoluzione delle controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo secondo gli ordinari criteri di riparto.
Nel corso del tempo la giurisprudenza ha proposto diversi criteri per la classificazione di un ente come pubblico. Si ricordano in particolare: a) la teoria c.d. finalistica, per la quale è ente pubblico la persona giuridica istituita per il perseguimento di fini pubblici [Cass., sez. VI, 27.11.2012, n. 49759]; b) la teoria c.d. dei poteri pubblici, per la quale è ente pubblico la persona giuridica dotata dei poteri di supremazia caratteristici dello Stato, come potestà statutaria, disciplinare, certificativa o di autotutela [Cons. Stato, sez. IV, 30.1.2006, n. 306 e, più recentemente, Cons. Stato, sez. IV, 24.5.2013, n. 2829]; c) la teoria c.d. del controllo, invece, che ritiene che sia ente pubblico la persona giuridica la cui attività sia sottoposta ad incisivi controlli da parte dello Stato [Tar Lazio, sez. III, 10.11.2011, n. 8645; Cass., sez. lav. 27.9.2012, n. 16467; Cons. Stato, sez. VI, 08.7.2010, n. 4437].
L’orientamento che sembra prevalere dà rilievo alla disciplina sostanziale dell’ente e ai c.d. indici sintomatici, come, ad esempio, l’assoggettamento a controlli pubblici e l’ingerenza dei pubblici poteri nella nomina e revoca degli amministratori dell’ente [Cons. Stato, sez. VI, 28.11.2012, n. 6014]. Tali indici non hanno carattere tassativo, né devono sussistere congiuntamente; il dubbio in ordine alla sussistenza di alcuni non consente la qualificazione dell’ente come pubblico [Cons. Stato, sez. V, 28.6.2012, n. 3820]. Dunque, l’orientamento consolidato è nel senso che, in mancanza di indici sintomatici che attestino in modo univoco il carattere pubblicistico dell’ente, è determinante il fatto che l’ente pubblico sia costituito e riconosciuto come persona giuridica di diritto privato [Cass., sez. un., 23.11.1985, n. 5812].
Conferma di questa posizione giurisprudenziale si rinviene nella l. 20 marzo 1975, n. 70, c.d. legge del parastato, il cui art. 4 prevede che «nessun ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge». Ciò che si rivela problematica non è l’istituzione di un ente pubblico, ma la successiva attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico ad un ente già esistente. Tra i casi più noti, si ricordi quello delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (c.d. IPAB) [Corte cost., 07.4.1988, n. 396] e, più recentemente, quello delle aziende pubbliche di servizi alla persona (c.d. ASP) [Corte cost., 27.6.2012, n. 161].
Un ultimo aspetto fondamentale è la privatizzazione degli enti pubblici economici. La Corte costituzionale ha ritenuto che la semplice trasformazione di questi soggetti in società per azioni non estingue ex se i controlli tipici che li riguardano. I controlli, infatti, perdono la propria ragion d’essere quando il processo di privatizzazione assume connotati sostanziali tramite l’effettiva dismissione delle quote azionarie in mano pubblica, in modo tale da determinare l’uscita delle società dalla sfera della finanza pubblica [Corte cost., 28.12.1993, n. 466].
In questo senso, è possibile leggere anche l’affermazione della natura pubblicistica dell’Anas S.p.A.: secondo la giurisprudenza, infatti, la sua trasformazione in società per azioni non ne ha modificato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa corrispondente a quella della società azionaria [Cass., sez. un., 09.7.2014, n. 15594; che in ragione di ciò ha affermato la giurisdizione contabile rispetto all’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti dell’Anas].
§ 2. L’organismo di diritto pubblico
La nozione di organismo di diritto pubblico deriva dalla normativa comunitaria sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, e in particolare dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, recepite nel nostro ordinamento con il codice dei contratti pubblici. In questo testo l’organismo di diritto pubblico è definito un organismo dotato di personalità giuridica, la cui l’attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, enti pubblici territoriali o altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, direzione o vigilanza sia costituito da membri di cui più della metà venga designata dallo Stato, enti pubblici territoriali o altri organismi di diritto pubblico (c.d. dominanza pubblica, a riguardo v. Cons. Stato, sez. IV, 03.10.2014, n. 4949). Tale organismo deve inoltre essere costituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale. I requisiti di personalità giuridica, dominanza pubblica e soddisfazione specifica di bisogni di questo tipo devono sussistere congiuntamente [Cons. Stato, sez. VI, 27.11.2011, n. 6835 e, più recentemente, Cons. Stato, sez. III, 26.11.2014, n. 5854]. Tuttavia, quest’ultimo requisito si è rivelato di difficile interpretazione e oggetto di diverse letture.
Una prima interpretazione prevede che i bisogni d’interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale siano quelli destinati a essere soddisfatti da attività svolte in regime di non concorrenza [recentemente, Cons. Stato, V, 30.1.2013, n. 570]. Sembra ispirato a questa logica l’art. 32, comma 1 lett. c), codice contratti. Una seconda tesi sostiene che il carattere industriale e commerciale debba riferirsi non ai bisogni, ma all’organizzazione necessaria alla soddisfazione degli stessi; sono dunque commerciali e industriali i bisogni soddisfatti tramite una attività svolta con un’organizzazione imprenditoriale, e così, dunque, non sono organismi di diritto pubblico le società pubbliche o miste che gestiscono servizi pubblici locali. Una terza interpretazione prevede che non industriali o commerciali debbano essere non i “bisogni” o le organizzazioni, quanto gli “interessi generali” cui i bisogni sono correlati. Sarebbero così organismi di diritto pubblico i soggetti che svolgono un’attività qualificabile come servizio pubblico o servizio economico d’interesse generale (sulle diverse tesi v. Cons. Stato, sez. VI, 28.10.1998, n. 1478).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea delinea a sua volta alcuni criteri d’individuazione dell’organismo di diritto pubblico. Così, ad esempio, sono privi di carattere industriale e commerciale i bisogni soddisfatti in modo diverso dall’offerta di beni e servizi sul mercato [CGE, 10.11.1998, C-360/96; Cass. sez. un., 09.5.2011, n. 10068]; il fatto che l’attività corrisponda ad un interesse generale non è di per sé decisivo per concludere che tale interesse sia privo di carattere industriale e commerciale, rilevando invece che l’attività sia o meno svolta in regime di obiettiva economicità [CGE, 10.5.2001, C-223/99 e C-260/99; sul “metodo non economico” nella giurisprudenza italiana v. Cons. Stato, sez. VI, 11.1.2013, n. 122; Cons. Stato, sez. V, 30.1.2013, n. 570]. Altresì, può rilevare la finalità per cui è stato costituito il soggetto; la costituzione con scopo di lucro, però, può non essere decisiva, se il lucro non risulta essere la finalità principale [CGE, 22.5.2003, C-18/01].
Quanto all’utilizzo della nozione di organismo di diritto pubblico da parte del giudice nazionale, in alcune occasioni, la giurisprudenza, in particolare amministrativa, ritiene che l’organismo di diritto pubblico comporti una rideterminazione dei parametri per l’individuazione della soggettività pubblica, che prescinde dal dato formale relativo alla natura del soggetto.
Dalla qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico discende la giurisdizione del giudice amministrativo, indipendentemente dall’applicazione del codice dei contratti pubblici. Alcuni casi noti si sono registrati nelle ipotesi di gare informali svolte da soggetti qualificabili come organismi di diritto pubblico. Ad esempio, è stato qualificato organismo di diritto pubblico il soggetto che svolge un’attività funzionalizzata all’interesse pubblico, anche se di carattere imprenditoriale; pertanto, nei confronti di questo soggetto, trova applicazione la disciplina del diritto d’accesso prevista dalla l. n. 241/1990 [Cons. Stato, sez. VI, 17.9.2002, n. 4711, c.d. caso Enel].
Inoltre, è stato ritenuto organismo di diritto pubblico il soggetto destinatario di una disciplina derogatoria, la cui maggioranza del capitale sociale è in mani pubbliche e la cui attività principale è qualificabile come servizio pubblico (Poste Italiane S.p.A.). Pertanto, gli atti da esso emanati in una procedura di gara informale, pur non avendo ad oggetto l’attività principale, ma un servizio tipicamente commerciale (c.d. Bancoposta), sono da considerarsi atti amministrativi [Cons. Stato, sez. VI, 02.3.2001, n. 1206, c.d. caso Bancoposta]. Proprio con riferimento alle Poste Italiane S.p.A., di recente la Cassazione [sez. II, 17.7.2014, n. 38614] ha osservato che i servizi finanziari e commerciali forniti dalla società (la gestione del risparmio, delle carte prepagate, etc.) risultano complementari rispetto all’originaria finalità pubblica, tuttora perseguita in via principale, relativa all’espletamento del servizio di spedizione e di recapito della corrispondenza (la pronuncia ha ritenuto, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma 2 n. 1, c.p., che tra gli enti pubblici rientri il soggetto avente le caratteristiche proprie dell’organismo di diritto pubblico).
![]()
II.
Gli accordi pubblici
Negli ultimi anni è emersa la tendenza, sempre più marcata, di riconoscere all’art. 11 l. n. 241/1990 una portata generale.
L’indirizzo della Cassazione nei primi anni novanta del secolo scorso privilegiava letture restrittive dell’art. 11 l. n. 241/1990 e considerava gli accordi ivi previsti come una forma particolare di accordo tra cittadino e amministrazione nel procedimento amministrativo: in quegli anni la giurisprudenza affermava la specialità di questo modello accanto ad altri modelli di accordo. Progressivamente, invece, e in particolare alla fine degli anni novanta, la Cassazione ha valorizzato l’art. 11, assumendolo come modello generale per gli accordi tra amministrazione e cittadini, fino a sostenere che in mancanza di disposizioni derogatorie, le regole poste dall’art. 11 devono valere anche per gli altri accordi. Si pensi, per esempio, alla previsione sul recesso unilaterale dell’amministrazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; alla modifica dell’accordo attraverso la manifestazione di volontà di tutti i soggetti che hanno concorso alla sua formazione; al fatto che ogni controversia relativa alla formazione, conclusione ed esecuzione dell’accordo rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Negli ultimi anni questa tendenza appare rafforzata e costituisce un orientamento consolidato, anche al di fuori dell’ipotesi più nota, quella delle convenzioni urbanistiche [Cass., sez. un., ord., 09.3.2012, n. 3689].
Così, per esempio, sono stati ricondotti agli accordi ex art. 11 l. n. 241/1990 i patti territoriali (cfr. art. 2, comma 203 ss., l. 23 dicembre 1996, n. 662) [Cass., sez. un., ord., 23.3.2009, n. 6960], la convenzione-concessione di costruzione e di esercizio (gestione) di una discarica di rifiuti [Cass., sez. un., 16.9.2008, n. 19494], la convenzione-concessione per la predisposizione dei progetti per la realizzazione di uffici pubblici [Cass., sez. un., ord., 21.5.2002, n. 7447], la convenzione tra enti per la realizzazione di un complesso museale [Cass., sez. un., 02.3.2001, n. 87].
Permangono casi in cui, secondo la Corte di Cassazione, l’accordo non è riconducibile all’art. 11 della l. n. 241/1990 e ha carattere speciale: così, ad esempio, in tema di cessione volontaria [Cass., sez. un., 06.12.2010, n. 24687], rispetto alla quale ha giocato un ruolo importante, in punto di giurisdizione, anche l’art. 34, comma 3 lett. b), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (cfr. ora l’art. 133, comma 1 lett. f), c.p.a.). Proprio nell’ambito degli accordi conclusi in pendenza di una procedura espropriativa, però, si tratta di comprendere appieno se, in presenza di un accordo diverso da quello disciplinato puntualmente dalla legge, vi sia ancora lo spazio per l’applicazione dell’art. 11 come norma generale, come in effetti sembra implicitamente riconosciuto da una parte della giurisprudenza [Cass., sez. un., 30.1.2008, n. 2029]. Problema, peraltro, che si può porre in astratto in tutti i casi in cui si riconosca all’amministrazione la possibilità di derogare al contenuto vincolato dell’accordo determinato dal legislatore.
Uno degli aspetti più discussi negli ultimi anni attiene alle condizioni per la stipula degli accordi e in particolare al loro contenuto. Se da un lato è certo che il contenuto dell’accordo non possa essere contrario alla legge in ragione del principio di legalità (in gioco è comunque l’esercizio di un potere amministrativo, anche se attraverso un “modulo consensuale”), più controverso, invece, è il profilo se l’accordo possa prevedere a carico del privato maggiori oneri rispetto a quelli che l’amministrazione potrebbe imporre attraverso il provvedimento. La questione, dunque, è se il consenso del privato valga a superare gli elementi accidentali e possa integrare l’onere che in alcuni casi la legge prevede in capo al privato per il rilascio del provvedimento. A fronte della tesi favorevole, c.d. tesi contrattualistica, secondo la quale il consenso del privato è elemento idoneo a superare i limiti previsti dalla legge [Cons. Stato, sez. V, 29.9.1999, n. 1209; Tar Lombardia, sez. II, 08.9.2011, n. 2193], si pone una tesi contraria secondo la quale l’accordo dovrebbe muoversi nella stessa logica provvedimentale, e quindi il consenso non potrebbe superare la previsione legislativa [Cons. Stato, sez. V, 06.12.1999, n. 2056; Tar Lombardia, Brescia, 12.10.2010, n. 4026].
In dottrina (Travi) è stato osservato che la risposta dovrebbe essere differente a seconda che si tratti di un’ipotesi in cui la prestazione del privato sia «un riflesso della disponibilità di quella situazione di fatto che il privato s’impegna a mantenere o modificare per rendere giuridicamente o materialmente possibile l’accordo», oppure di un’ipotesi in cui «l’impegno del privato si ponga nella logica della controprestazione».
![]()
III.
I pareri e le valutazioni tecniche
Nella l. n. 241/90 viene affermata la distinzione tra pareri di «organi consultivi» (art. 16) e valutazioni tecniche (art. 17).
In linea generale, il parere consultivo interviene di norma quando sono stati acquisiti i fatti rilevanti e consiste nella proposta di un esito possibile del procedimento (da questo punto di vista, il provvedimento rappresenta l’ipotesi accolta); invece, la valutazione tecnica attiene all’acquisizione degli elementi rilevanti per la decisione, quindi all’istruttoria in senso stretto del procedimento. Dunque, il parere è riferito all’oggetto del procedimento, mentre la valutazione tecnica è riferita a singoli fatti che devono essere conosciuti e apprezzati per l’adozione del provvedimento finale.
Tuttavia, comprendere in quale caso ricorra un parere consultivo anziché una valutazione tecnica non è sempre agevole: spesso un parere ha come elemento centrale un giudizio di ordine tecnico.
La distinzione non è teorica perché la disciplina di acquisizione prevista dalla legge sul procedimento amministrativo è differente.
A questi fini la giurisprudenza amministrativa ha individuato alcuni indici [Cons. Stato, comm. spec. pubblico impiego, parere, 05.11.2001, n. 480/00]: a) il carattere vincolante o meno del parere: gli apporti di carattere discrezionale o i «consigli» non perentori sul futuro contenuto del provvedimento risultano scarsamente conciliabili con il carattere tecnico del parere; b) la composizione dell’organo consultivo: la presenza significativa di soggetti privi di competenze scientifiche particolari (ancorché esperti della materia, intesa, genericamente, come settore dell’ordinamento) indica normalmente che l’attività consultiva non assume carattere tecnico; c) la ratio complessiva dell’intervento consultivo dell’organo: nella varietà degli scopi perseguiti dalla norma, occorre considerare che, talvolta, il parere dell’autorità consultiva mira ad assicurare una certa omogeneità delle decisioni finali affidate ad amministrazioni diverse; d) l’intensità del collegamento con il provvedimento finale e l’ampiezza dell’intervento consultivo: tutte le volte in cui il parere ripercorre l’interezza del procedimento svolto ed esprime una valutazione ad ampio raggio sui contenuti del provvedimento conclusivo, la valutazione assume la fisionomia del parere «puro», disciplinato dall’art. 16, a nulla rilevando che l’istruttoria abbia toccato profili di ordine tecnico e specialistico.
Rispetto alle valutazioni tecniche, inoltre, è rimasto irrisolto un nodo di fondo: individuare le valutazioni tecniche oggetto di una riserva (o di un potere riservato di valutazione) in capo all’amministrazione. Questo aspetto è al centro di un dibattito molto vivace, soprattutto in dottrina.
Dal punto di vista del diritto sostanziale, alcune valutazioni tecniche, pur assegnate ad uno specifico organo in ragione della specializzazione tecnica, sono considerate ‘fungibili’ dal legislatore, se omesse. In questi casi il legislatore non ha dato rilievo determinante né al soggetto che esprime la valutazione né alle specifiche modalità d’esercizio stabilite dalla legge. In proposito è indicativo l’art. 17 l. n. 241/1990. Il legislatore ha ritenuto fungibili alcune categorie di valutazioni tecniche, considerando altre (comma 2), viceversa, insostituibili. La giurisprudenza si è espressa in termini di «surrogabilità soggettiva» [Cons. Stato, parere, n. 480/00 cit.; Cons. Stato, sez. V, 05.3.2001, n. 1247]. In alcuni casi risultano insostituibili alcune valutazioni che coinvolgono interessi primari: in queste ipotesi, però, si deve riconoscere non tanto una riserva di valutazione, quanto una garanzia assoluta di certi interessi. In altri casi risultano insostituibili le valutazioni caratterizzate dal più alto grado di soggettività e di opinabilità dei criteri.
La riflessione sull’art. 17 l. n. 241/90, tutt’altro che condivisa in dottrina, richiede una precisazione. Dall’art. 17 non si ricava una piena fungibilità del giudice – o per lui del consulente tecnico – rispetto all’amministrazione. Dalla norma si ricavano, però, argomenti decisivi per superare la tesi di ...