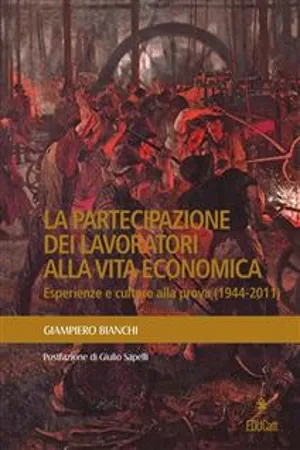![]() Appendice
Appendice![]()
Nota tecnica
L’antologia che segue è composta dai testi citati nella parte monografica: divisi in due grandi gruppi (l’uno di esperienze italiane, l’altro di esperienze estere), collocati in ordine cronologico, sono preceduti ciascuno da brevi note di contesto e di contenuto che ne introducono la lettura; segue poi, ogni volta, una breve bibliografia di approfondimento.
Obiettivo di tale struttura è anzitutto didattico: si vuole mettere il lettore – in genere studente di un corso di laurea economica o manageriale o di un corso di studi socio-politico – di fronte ad un documento originale, ritenuto particolarmente significativo. In questo modo lo si introduce anche al metodo del lavoro storico, spingendolo ad un costante confronto critico tra le interpretazioni e i documenti e facendogliene scoprire l’utilità anche per corsi di studi non storici.
Oggetto al centro della presente opera sono le tante, diverse, esperienze di partecipazione del lavoro, nelle varie epoche e nei vari ambienti, collocate e discusse secondo un filo interpretativo tendenzialmente unitario: quello di un cammino al fondo plurale ma convergente, del lavoro organizzato e quindi del suo libero associarsi sindacale, dall’estraneità al coinvolgimento, dal conflitto alla partecipazione, nell’impresa come nella società nel suo complesso. La partecipazione cioè vista come via associativa e relazionale del lavoro alla sua piena cittadinanza democratica.
L’Antologia è divisa appunto, per comodità di lettura, in due parti distinte: l‘una analizza esperienze e temi di ambienti esteri particolarmente significativi; l’altra si sofferma solo su esperienze di ambiente italiano. Si è scelta tale formula per accentuare una riflessione comparata sui temi analizzati, la migliore, a giudizio di chi scrive, per capire i problemi del lavoro, e in particolare le similitudini ma anche le specificità – più negative che positive – dell’esperienza italiana.
All’inizio di ciascuna parte sono state collocate due “letture introduttive” (o saggi brevi) che, con le loro interpretazioni, cercano di fornire al lettore ulteriori chiavi nella direzione proposta.
Un’ultima precisazione: la storia qui raccontata, non accenna a concludersi: spesso tormentata e complessa, con luci e ombre, sempre in movimento, essa non smette di aggiungere nuovi tasselli a quelli già noti: di qui il carattere per sua natura aperto, perennemente in fieri si potrebbe dire, del presente lavoro.
![]() Parte prima:
Parte prima:
testi e documenti in ambienti esteri ![]()
1.
“I tre piani della partecipazione sindacale”258
(Lettura: Romani 1951)
Come lettura introduttiva al tema della partecipazione del lavoro un brano di Mario Romani, studioso e protagonista della storia sindacale italiana. Si tratta infatti di un paragrafo del piccolo volume “Appunti sull’evoluzione del sindacato” (nelle varie epoche e nei vari ambienti), scritto nel 1951 dall’allora giovane professore della U. Cattolica, responsabile dell’attività di studio e formazione della Cisl. Un testo didattico, ad uso dei futuri leader sindacali, allievi al corso lungo dirigenti del Centro studi Cisl di Firenze: in esso inserisce la “partecipazione del lavoro” nei moderni “rapporti tra sindacato e ambiente economico”, in un paragrafo intitolato “sindacato ed economia mista”.
Romani è favorevole alla partecipazione del lavoro perché vede in essa la via d’uscita dalla tradizionale estraneità del lavoro alla vita economica (aziendale, settoriale e generale) ma, avverte il lettore, con cautela perché dietro la parola si nascondono potenzialità e pericoli, ambiguità e certezze tra loro, spesso, strettamente intrecciate: il lavoro quindi può e deve partecipare alla vita delle imprese come a quella dei settori produttivi, dal piano locale a quello nazionale e internazionale: attenzione però alle soluzioni formali di tipo legislativo e istituzionale che invece, in quegli anni, erano tenute in gran conto dal mondo cattolico vicino alla Cisl.
La posizione del movimento sindacale nell’economia mista sopra delineata, per forza di cose ha posto l’accento su di una nuova nozione del ruolo del lavoratore nel processo produttivo. La cooperazione e la corresponsabilità sindacale nel raggiungimento di determinate mete, comportano l’accettazione infatti del primato del fattore umano nella produzione, cosi come il rigetto della tradizionale assimilazione del lavoratore ad uno qualsiasi degli altri intercambiabili elementi delle combinazioni produttive. Secondo la relazione del Direttore generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro alla 33a sessione (1950) della Conferenza Internazionale del Lavoro, «non basta sapere ciò che deve essere fatto per accrescere la produttività. Non si insiste mai troppo sull’importanza dei fattori psicologici e di ciò che si chiama il clima favorevole. Solo la più completa reciproca comprensione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori del punto di vista che è proprio agli uni ed agli altri, può dare anima alla decisione comune di accrescere la produttività e rendere questa decisione stabile; una tale risoluzione non può dare i suoi pieni effetti che attraverso la più stretta collaborazione delle due parti».
Risulta così quanto mai comprensibile come da qualche tempo si vada realizzando una viva presenza sindacale sul piano delle unità produttive, ossia alla base dell’intero edificio economico, a stretto contatto coi responsabili della gestione aziendale privata o pubblica. È uno degli aspetti attualmente più appariscenti dell’economia mista, che anche gli ultimi difensori dell’assolutismo imprenditoriale ottocentesco, dovranno finire col considerare come l’unica alternativa al modo sovietico di gestione delle aziende.
La presenza in esame, pone parecchi delicati quesiti. Innanzitutto non va concettualmente confusa la tradizionale presenza del sindacato in quanto tutore, anche indiretto, sul piano aziendale, degli interessi dei lavoratori aderenti, con quella mediante la quale il sindacato stesso suscita e segue lo sforzo di cooperazione dei lavoratori a sostegno della responsabilità dei vari aspetti della gestione aziendale. Al limite, si tratta di funzioni di natura diversa (volte l’una al lavoratore concepito come puro cessionario di un fattore della produzione e quindi come soggetto esterno all’impresa, e l’altra al lavoratore concepito come corresponsabile dell’andamento di un’opera comune e quindi come soggetto interno all’impresa) che comportano, per essere espletate, organi e preoccupazioni diverse. Mentre riesce facile configurare per il sindacato la continuità di assolvimento della prima funzione, più complesso si mostra l’assolvimento della seconda ed il convivere delle due.
Ma quest’ultima difficoltà non rappresenta che una delle tante manifestazioni del delicato sistema di umani equilibri su cui riposano il presente e più il futuro dell’economia mista, che per sua natura rifugge dall’insostenibile semplicismo dell’autocrazia imprenditoriale pubblica o privata: si attenuerà col rafforzarsi dello spirito e della pratica della collaborazione. In pieno sviluppo, si trovano invece ad essere già le esperienze intese all’inserimento responsabile del lavoratore nella compagine aziendale. Nella loro grande varietà, è possibile individuarne alcuni tratti comuni: non tendono ad istituire una gestione «sindacale» delle aziende, ma una partecipazione dei lavoratori alle responsabilità di gestione; l’incremento della produttività ed i benefici diretti ed indiretti da questo derivanti, ne rappresentano la meta principale; presuppongono per un minimo, ma al tempo stesso sviluppano, quella atmosfera di distensione sociale interna che sola consente il raggiungimento della meta principale; si svolgono nelle aziende che appartengono sia al settore privato che al settore pubblico della produzione, ponendo scarsa enfasi sul problema della natura del soggetto o dei soggetti titolari del diritto di proprietà sui mezzi di produzione; hanno una base contrattuale, a volte assunta a contenuto di disposizioni normative generali; rispettano il principio dell’unicità direzionale dell’impresa.
Un altro piano al quale il movimento sindacale sviluppa la sua opera di collaborazione, è quello del settore produttivo o del ramo di industria. In certo senso, date le esperienze connesse alla prassi della contrattazione collettiva, è questo il livello al quale più agevole riesce al movimento di recare il suo contributo. In genere si tratta dell’impostazione comune di programmi di rammodernamento e di razionalizzazione per settori produttivi, o di programmi di sviluppo, a seconda del grado di industrializzazione raggiunto dai diversi Paesi. Organismi paritetici su base contrattuale, o prima contrattuale e poi legislativa, tendenzialmente di tipo permanente, assicurano l’effettuazione dell’opera comune. Anche qui, l’esistenza dei settori nazionalizzati (specialmente in quegli ambienti dove il potere politico non è esercitato da gruppi che traggono il mandato dal sostegno dei lavoratori organizzati, come accade attualmente in Gran Bretagna) pone situazioni speciali, più complesse di quelle proprie al settore privato. Sembra però più utile ricordare che la collaborazione sindacale alla soluzione dei problemi di razionalizzazione e di sviluppo economico come a quelli sociali di settore, conforme alla posizione del movimento nella economia mista, non deve essere confusa colle realizzazioni della formale strutturazione corporativa dell’economia, realizzazioni contrarie sia al dinamico contemperamento della programmazione e della libera iniziativa, che all’autonoma assunzione di responsabilità generali da parte dei sindacati, essenziale tanto alla economia mista (che è una economia diretta), quanto alle stesse possibilità di esistenza della democrazia politica occidentale. Le risultanze della detta collaborazione, possono trovare per mutuo accordo applicazione o fornire materia di suggerimenti ai pubblici poteri, senza cadere nella logica che (sotto specie di riconoscimento di una formale partecipazione sindacale al governo del settore produttivo) per la necessaria subordinazione degli interessi di settore a quelli generali, finisce col privare il movimento sindacale dei suoi vari titoli di tutela di interessi sul piano nazionale, affidando la tutela stessa a gruppi di comando che, non essendone espressi, non possono ammettere l’alternativa democratica.
Non è forse qui fuori luogo una testimonianza, quella recente di Bernard Chenot: «Bisogna riconoscere che organismi sindacali che raccolgono su base nazionale i membri dei più diversi settori produttivi, hanno per oggetto stesso i problemi generali che si pone il Governo del Paese e si schierano, per il semplice fatto che esistono, fra i protagonisti delle più profonde lotte politiche. Il Governo di Vichy lo aveva perfettamente capito. Se voleva eliminare il sindacalismo dal piano nazionale, spezzettarlo in categorie professionali e confinarlo nell’impresa, era per allontanarlo dai problemi generali, politici per natura, e orientarlo verso questioni particolari, che conservano, in un ambito ristretto, un carattere tecnico. Ma il sindacalismo operaio perdeva con questa frammentazione l’essenza della sua forza».
Di fatto, in economia mista l’aspetto ultimo e determinante della partecipazione sindacale alla vita economica, è costituito dalla collaborazione sul piano del sistema economico nazionale e dei rapporti tra questo ed i sistemi esterni. Il movimento si associa cosi, coi poteri pubblici e colle organizzazioni dei datori di lavoro, alla preparazione ed alla messa in opera della politica economica e sociale mirante a quegli obiettivi consapevoli (giustizia sociale, pieno impiego, espansione del reddito nazionale in una sua distribuzione atta a non ostacolarla) che, come si è già rilevato, sostanzialmente, coincidono coi suoi. Inoltre, può continuare al livello più alto il colloquio diretto col mondo imprenditoriale, iniziato sul piano dell’unità produttiva.
Il principio dell’associazione delle forze organizzate della produzione e del lavoro, all’opera di orientamento generale del sistema economico, principio come è noto formalmente stabilito dalla «Dichiarazione di Filadelfia», se si può considerare universalmente accettato come tale, trova una notevole varietà di sistemi di applicazione, alcuni riposanti sulla reciproca intesa, altri su dichiarazioni costituzionali e norme legislative ordinarie. Dalla consultazione saltuaria o permanente attraverso «conferenze nazionali» e contatti successivi, alla consultazione sistematica attraverso l’opera di «consigli nazionali» (economici, sociali, del lavoro), alla cooperazione per lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività produttive mediante appositi organismi tripartiti («comitati nazionali della produttività»), alla partecipazione agli organi della programmazione economica («consigli o comitati per il piano economico nazionale»), si snoda una vasta gamma di esperienze, che ha ormai chiaramente segnato di una caratteristica inconfondibile il tipo in esame di organizzazione economica della società.
Si conclude per tale via, l’aspetto del modo di essere del sindacalismo che s’è rilevato costituire l’integrazione e la condizione di svolgimento dell’aspetto contrattuale. Occorre però aggiungere che, sul piano nazionale ed internazionale, il movimento sindacale è presente a salvaguardare le sorti ormai congiunte in modo indissol...