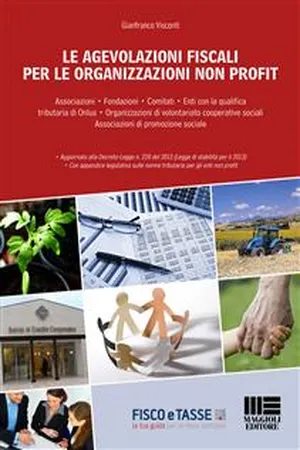![]()
1. La disciplina fiscale delle organizzazioni non profit previste dal codice civile e definite enti non commerciali dal testo unico delle imposte sui redditi
1.1 Le organizzazioni senza scopo di lucro previste dal codice civile: le associazioni non riconosciute e quelle riconosciute, le fondazioni ed i comitati
Le organizzazioni non profit, cioè quelle che non hanno scopo di lucro ma che si prefiggono obbiettivi solidaristici od altruistici, sono disciplinate, dal punto di vista civilistico, dagli articoli da 14 a 42 del codice civile. In particolare, gli articoli da 14 a 35 c.c. disciplinano le persone giuridiche private: le associazioni riconosciute e le fondazioni, vale a dire gli enti con personalità giuridica a seguito di riconoscimento dello Stato, in cui prevale l’aspetto personale (gli associati nelle associazioni) o quello patrimoniale (il patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo nelle fondazioni).
Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della personalità giuridica è disciplinato dal d.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 che ha semplificato questo procedimento ed ha limitato, ma non annullato, la discrezionalità amministrativa nel riconoscimento della personalità giuridica ad un ente privato.
Gli articoli da 36 a 42 c.c. disciplinano, invece, le associazioni non riconosciute (quelle senza personalità giuridica) ed i comitati (organizzazioni di cittadini che perseguono un unico scopo in un tempo limitato).
Il fondamento costituzionale della legislazione ordinaria sulle organizzazioni non profit è il comma 1 dell’art. 18 della Costituzione che riconosce e garantisce la libertà di associazione dei cittadini per fini che non sono loro vietati dalla legge penale, senza che sia necessaria una qualsiasi autorizzazione.
Ricordiamo, infine, che le persone giuridiche private, vale a dire disciplinate dal diritto privato e che perseguono scopi di natura privata, vanno distinte dalle persone giuridiche pubbliche, di cui all’articolo 11 del codice civile, che sono tutti gli enti pubblici che acquisiscono la personalità giuridica in forza delle leggi che li istituiscono, perseguono fini pubblici di interesse generale e godono dei diritti derivanti dalle norme del diritto pubblico.
La grande maggioranza delle associazioni esistenti è costituita nella forma di associazione non riconosciuta, prevista e disciplinata negli artt. 36, 37 e 38 del codice civile.
Queste associazioni vengono definite “non riconosciute” in quanto sono prive di personalità giuridica.
Sebbene la legge consenta di dare vita ad un’associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale, la pratica invalsa, per intuibili ragioni di funzionalità, fa sì che l’associazione non riconosciuta si costituisca, di solito, a mezzo di un atto scritto (contratto di associazione), basato, di solito, su due componenti: l’atto costitutivo, che dà vita all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di avvio e di riferimento e lo statuto, destinato a regolare il funzionamento dell’associazione (art. 16 c.c., norma che vale però solo per le associazioni riconosciute e le fondazioni).
Il contratto associativo delle associazioni non riconosciute non richiede forme particolari. È sufficiente una scrittura privata semplice, senza la necessità di ricorrere all’intervento di un notaio; non occorre che essa contenga specifici elementi, se non quelli richiesti dalla normativa fiscale.
Le associazioni riconosciute, previste e disciplinate dagli artt. 14-24 del codice civile, devono, invece, costituirsi con atto pubblico comprendente l’atto costitutivo e lo statuto (artt. 14, comma 1, e 16, comma 1, c.c.) e, successivamente, chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica secondo il procedimento previsto dal d.P.R. n. 361/2000.
Il riconoscimento della personalità giuridica, che consiste nell’attribuzione della piena capacità giuridica (cioè della idoneità ad instaurare rapporti giuridici e quindi di essere titolare di diritti e di obblighi) ad un ente diverso dalla persona fisica, assicura, come principale conseguenza, il beneficio della limitazione della responsabilità per le obbligazioni assunte al solo patrimonio dell’associazione (artt. 31, comma 3, 38, 41 e 2740 c.c.), senza che per esse debbano rispondere gli associati coi loro beni. Si dice, pertanto, che le associazioni riconosciute e tutte le altre persone giuridiche hanno una “autonomia patrimoniale perfetta”, in quanto il patrimonio di esse rimane nettamente distinto dal patrimonio delle persone fisiche associate. Inoltre, le associazioni riconosciute possono acquistare beni immobili o mobili registrati, essere titolari di diritti reali ed accettare eredità (ma solo con beneficio di inventario, ai sensi dell’art. 473 c.c.), legati o donazioni.
Per le fondazioni (chiamate anche istituzioni), disciplinate dagli articoli da 14 a 35 del codice civile, valgono le medesime regole per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica esaminate per le associazioni riconosciute. A differenza delle associazioni, le fondazioni sono sempre persone giuridiche. Esse si costituiscono per atto pubblico o per disposizione testamentaria (art. 14, comma 2, c.c.). La particolare struttura di questi enti non rende infatti necessaria l’esistenza o la permanenza, al loro interno, del soggetto o dei soggetti “fondatori”. La struttura giuridica della fondazione non prevede la figura dell’associato, o di altre figure ad esso assimilabili.
Il metodo ordinario con cui si costituisce una fondazione è quello del lascito, da parte di uno o più fondatori, di un patrimonio vincolato al perseguimento di determinati scopi non lucrativi, ma di natura sociale, culturale, solidaristica. L’attività della fondazione è finanziata dal patrimonio conferito o lasciato dal o dai fondatori e dagli eventuali frutti di esso. L’amministrazione di essa è soggetta al controllo ed alla vigilanza dell’Autorità governativa (Prefettura o Regione).
I...