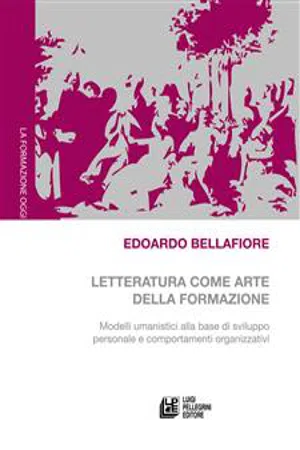La storia
L’uomo, la forma, la formazione
1. L’uomo e la forma
All’inizio di ogni scritto che affronti, nel corso del suo svolgersi, tematiche formative, si trova sempre nelle prime righe un tentativo di precisare cosa sia la formazione, di fornirne una definizione che dia – a chi scorre l’opera – la possibilità di impossessarsi di una esatta chiave di lettura. ‘Tentativo di precisare’ è un sintagma che al proprio interno suona quasi ossimorico: da un lato la consapevolezza della difficoltà di racchiudere un tema dai contorni sfocati entro definiti confini, dall’altro la necessità di renderli nitidi affinché ci si intenda. Difficilmente un’opera che tratti di legge, o di medicina, o di filosofia, sente il bisogno di dover definire alla lettera il campo entro il quale ha posto il proprio lavoro.
Come osserva Rita Santarelli, che per anni ha diretto il Coordinamento Attività Formative Confindustria, “parlare di formazione è abitualmente un argomento che suscita, nello sguardo di chi ascolta o di chi legge, una strana forma di attesa, di interrogazione, come se su questo tema ci fosse in ogni momento una nuova tendenza, un nuovo movimento o una nuova scoperta da presentare”.
Ciò accade essenzialmente per due motivi: il primo vede effettivamente essere la ‘formazione’ un tema trasversale. Il secondo delinea l’impossibilità di stabilire una definizione netta che limiti (letteralmente che ponga i ‘limes’, i ‘confini’) la formazione ad una determinazione univoca, per il poco e troppo recente retroterra di studi ed esperienze che questo settore ha alle spalle rispetto ad altri. Non che sia di per sé un settore neonato, è ben intendersi, ma troppo recenti e poco approfonditi sono i contributi che si preoccupano di indagarne con profondità storica le linee di sviluppo: la formazione non è una scoperta scientifica, e non è nemmeno un’invenzione. È sempre esistita, ma con le sue componenti sempre inserite in molteplici, altri settori.
Si è tutti concordi nel ritenere che la formazione sia ‘sviluppo’, cioè una strada la cui percorrenza debba portare a migliorare quanto normalmente si svolge; e dunque sia, innanzi tutto, ‘apprendimento’. In alcuni casi la si metaforizza con una medaglia, in cui ad una delle due facce corrisponde il sapere ‘tecnico’, all’altra quello ‘umano’. Ma andrebbe intesa come un unicum in cui al primo livello si agisce sull’uomo, al secondo sulle sue specifiche abilità.
In Sapere, fare, essere si affronta proprio la stratificazione tripartita della formazione, che per dare frutto deve appunto impattare sul sapere, sul fare (cioè sull’agire) e sull’essere dell’individuo, per poi poter generare dei cambiamenti a livello organizzativo. Deve sviluppare le potenzialità del singolo, colmando il gap tra ciò che sa e ciò che dovrebbe sapere (conoscenze), tra ciò che sa fare e ciò che dovrebbe saper fare (capacità), tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere (competenze). Anche qui si tenta di definire la formazione, risalendo al verbo che la determina: ‘formare’, cioè “plasmare, sagomare, modellare qualcosa per farle assumere la forma voluta; creare, educare, crescere, sviluppare”. La si definisce come una “fase di spinta dello sviluppo futuro”. È apprendimento, che può essere tecnico o umano. In virtù della teoria della stratificazione tripartita, è dunque “un’azione mirante allo sviluppo delle abilità dell’individuo, alla trasmissione di informazioni, all’acquisizione di un comportamento più consono al raggiungimento dei propri obiettivi”.
Tuttavia, tra il proprio tentativo di definizione e le varie citazioni, v’è un intermezzo costituito dalla dichiarazione di prammatica per cui la ‘formazione’ è di per sé difficile da precisare, in quanto “esistono diverse finestre dalle quali osservarla e ognuna singolarmente fornisce una veduta parziale ed inadeguata a spiegare la sua complessità [...]. L’utilità di una definizione sta nel cercare di separare quel determinato concetto da altri che gli sono simili o vicini”.
Subito dopo questi accenni, vengono citate fonti eminenti a dire la propria sull’argomento, a tentare di delineare questo campo con varie definizioni:
“Formare implica un intervento profondo e globale che provoca nel soggetto uno sviluppo nel campo intellettuale, fisico o morale e un cambiamento nelle strutture corrispondenti a questi campi, in modo tale che questo sviluppo non sia sovrapposto alla struttura esistente, ma sia integrato in nuove strutture più generali, che consentono ad ognuno di raggiungere, secondo le proprie capacità, un livello culturale multidisciplinare, capace di fargli meglio comprendere i fenomeni della vita [...]. Come tale, la formazione non è più un semplice fenomeno di acquisizione, come la concepiva la maggior parte dei pedagoghi, ma ha come obiettivo una trasformazione della personalità, mettendo quindi in gioco dei meccanismi psicologici in altro modo più vasti” (Goguelin, 1971).
“La formazione viene caratterizzandosi, quindi, come momento di apprendimento cambiamento, nel senso di una trasformazione che porta il soggetto ad una presa di coscienza delle proprie risorse, delle proprie capacità, dei percorsi migliorativi attuabili e dell’impiego di tali risorse, in un progetto che, tendenzialmente, supera il momento applicativo professionale, per sfociare in una rielaborazione delle proprie esperienze della vita sociale” (Castelli, 1981).
“La formazione è attività educativa. Dunque il suo obiettivo è il sapere: la promozione, la diffusione, l’aggiornamento del sapere. Nonché la promozione, diffusione e aggiornamento dei modi di utilizzo di tale sapere” (Quaglino, 1985).
Se dunque, come appare, è impossibile che la ‘formazione’ possa essere definita in un modo che sia univoco ed esaustivo, cerchiamo di procedere con un criterio scientifico: in primo luogo, se è vero che ogni tentativo di precisazione differisce dagli altri, più che concentrarci sulle differenze, risaliamo ai topoi in condivisione. Come direbbero i matematici, rintracciamo il ‘massimo comun divisore’, che nel nostro caso equivale alla chiave di volta, ciò da cui tutti partono (o passano) parlando di formazione. Dopodiché, invece di preoccuparci a costruire i nostri concetti in altezza, scaviamo ancor più in profondità, il più possibile, per risalire ai concetti originari e primigeni: per edificare, preoccupiamoci di conoscere adeguatamente la natura del terreno sottostante.
Nei passi riportati di sopra, abbiamo trovato parole che presentano una affine area semantica: cambiamento, promozione, aggiornamento e trasformazione.
Esaminiamole brevemente:
• ‘Cambiare’: ‘sostituire una cosa a un’altra’, innovare, ‘mutare’, ecc.;
• ‘Promuovere’: dal latino ‘pro’ e ‘movēre’, cioè ‘andare verso il meglio’;
• ‘Aggiornare’: letteralmente ‘mettere a giorno’, ossia ‘adeguare a nuove necessità’.
Come si può facilmente notare, sono termini tutti accomunati dal dinamismo, che sottintendono la presenza di uno stato iniziale (x) e uno finale (y): di conseguenza, implicano che la formazione sia proprio un arco teso tra questi due momenti, vale a dire il quid di esperienze e apprendimenti che in questo spazio è racchiuso.
Soffermiamoci in particolare sul termine che, non a caso, abbiamo preferito lasciare per ultimo:
• ‘trasformare’, composto da ‘trans’ (‘oltre’) e ‘forma’: cioè letteralmente ‘andare oltre la forma’, quindi ‘mutare forma’. ‘Trans’ è il prefisso dinamico per eccellenza, in quanto presuppone chiaramente un passaggio: basti osservare vocaboli come ‘trascrivere’, ‘trasferire’, ‘trasgredire’.
‘Trasformazione’ è la parola che più di ogni altra si trova nelle definizioni che vengono date della formazione. Non a caso, a comporla è il termine stesso ‘formazione’. Quando un’azienda “manda” i suoi dipendenti in formazione, lo fa per auspicare un miglioramento – che possa essere umano o tecnico – e che sicuramente dovrà incidere positivamente sul loro modo di lavorare. La formazione, per essere efficace, deve generare uno sviluppo, quindi produrre un cambiamento, piccolo o grande che sia. Per quanto riguarda le tematiche “trasversali” o “comportamentali” deve aprire uno spazio di riflessione in cui la persona mette in gioco i propri paradigmi professionali di ogni giorno.
Tutti gli ultimi lemmi presi in considerazione fanno riferimento a un passaggio, quindi a un processo dinamico.
C’è però una parola, una sola, che non si può trascurare per esprimersi sulla formazione: ed è proprio forma, come si può vedere dai termini analizzati sinora. Deve essere la prima da approfondire quando si analizza il termine ‘formazione’. Più spesso ci si ferma al verbo ‘formare’, raramente lo si scompone ulteriormente ad estrarne il lemma che lo costruisce: forma. È una parola chiave (che racchiude in sé un mondo, e in sé rispecchia l’evoluzione umana) che può aiutarci, meglio di ogni altra, a comprendere – e a inglobare nel nostro sguardo – l’intero orizzonte della formazione.
Il verbo ‘formare’ nell’antica Roma significava ‘dar forma, figurare, plasmare, fare’.
‘Forma’ è una parola latina (deriva a sua volta dal greco μορφή), e in italiano trova riscontro non solo in ‘forma’, ma anche in ‘figura’, ‘aspetto’, ‘bellezza’ (da cui l’aggettivo ‘formosus’, ‘bello’). È un termine complesso, che ha molti significati - apparentemente diversi, in realtà complementari.
Passando all’italiano, il termine ‘forma’ è usato, nei primi secoli della nostra lingua, in maniera contingente. Spesso significa ‘figura’ o ‘struttura’, ma viene usato senza la connotazione estetica datagli dagli antichi, per cui il termine era impiegato spesso in riferimento alle arti, con una forte prerogativa visiva. In questo periodo è un vocabolo che non ha ancora assunto un’importanza solida, duratura e specifica e che non ha ancora acquisito determinate valenze. È usato più che altro ...