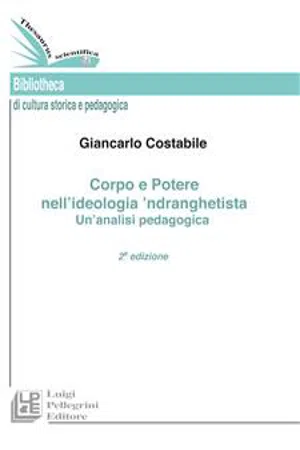1. Il problema: morire di mafia
D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,
ma la risposta che dà a una tua domanda.
Italo Calvino, Le città invisibili
Pensare è agire
Sono passati vent’anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Il boato del tritolo dimora ancora nel mio condotto uditivo che sfocia nei neuroni, scorticando la corteccia celebrale. Ho memoria di quella mattanza: avevo diciassette anni e ho, ancora oggi, scolpito nel cuore il sorriso di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e nella mente le terribili immagini di quei mesi. Mi chiedevo ripetutamente – dopo la strage di Capaci, in quei maledetti 57 giorni che intercorsero tra il 23 maggio e il 19 luglio – come Paolo Borsellino stesse affrontando la paura, perché sapeva di essere ormai condannato a prendere congedo dalla vita. Cosa sentiva in quei giorni, come passavano le sue ore, come si svegliava e quando andava a dormire, cosa sognava? Come ha fatto a prepararsi con coraggio e fermezza a una morte così orribile? Quale Pedagogia, doverosamente al maiuscolo, l’ha sorretto? Per 57 interminabili giorni Paolo Borsellino ha danzato sui carboni ardenti della morte fino a restarne orrendamente bruciato. Il suo corpo è stato mozzato dall’esplosione di cento chili di tritolo piazzati a meno di un metro da lui, in corrispondenza del citofono dell’abitazione della madre. Un boato, una nuvola nera, brandelli di umanità attaccati ovunque sulle palazzine di quella strada senza uscita: l’ombra della morte su una città insanguinata, Palermo, simbolo del Sud assoggettato al potere mafioso. Icona di una corporeità asservita, schiacciata, annichilita dal dominio criminale: tenuta in ostaggio dalla sua ideologia.
Paolo Borsellino è andato incontro alla morte celebrando la Vita, quella al maiuscolo. Il suo testamento è racchiuso nel discorso alla Veglia per Falcone, il 20 giugno 1992, a meno di un mese dalla sua tragica dipartita: «Muore e tutti si accorgono quali dimensioni ha questa perdita. Anche coloro che per averlo denigrato, ostacolato, talora odiato e perseguitato, hanno perso il diritto di parlare! Nessuno tuttavia, ha perso il diritto, anzi il dovere sacrosanto, di continuare questa lotta. Se egli è morto nella carne, ma è vivo nello spirito, come la fede ci insegna, le nostre coscienze se non si sono svegliate debbono svegliarsi. La speranza è stata vivificata dal suo sacrificio, dal sacrificio della sua donna, dal sacrificio della sua scorta. Molti cittadini, è vero, ed è la prima volta, collaborarono con la giustizia per le indagini concernenti la morte di Falcone. Il potere politico trova incredibilmente il coraggio di ammettere i suoi sbagli, e cerca di correggerli, almeno in parte, restituendo ai magistrati gli strumenti loro tolti con stupide scuse accademiche. Occorre evitare che si ritorni di nuovo indietro: occorre dare un senso alla morte di Giovanni, alla morte della dolcissima Francesca, alla morte dei valorosi uomini della sua scorta».
Giovanni Gentile nel suo Sommario di pedagogia come scienza filosofica scrive che «ognuno è martire delle idee sue: non solo le confessa e professa, ma le attesta; le prova, le realizza». Per il filosofo siciliano non è accettabile una teoresi incapace di farsi prassi sociale. È inattuale ogni riflessività lontana dalla “concretezza” dell’esistenza: essa non può trovare ospitalità nella filosofia dello spirito che si definisce compiutamente nell’interezza della sua intima e dinamica unità di pensiero e azione. Nel Sofisma dei prudenti, il suo ultimo articolo prima di essere ucciso, Gentile attacca duramente quelli che considera i disertori della vita: umani che rinunciano a lottare e a morire per difendere le proprie idee e valori. Sono uomini struzzo: nascondono la testa sotto la sabbia e aspettano che la lotta si concluda per scegliere come posizionarsi.
La società ha il nostro volto: è ciò che ne facciamo. La pedagogia gentiliana è tutta in questa affermazione vibrante: attori sempre, spettatori mai. La pedagogia attualista è radicale rivendicazione dell’autoformazione della coscienza come principio assolutamente e autenticamente umano: è cammino del Geist, laicamente inteso, come umanarsi dell’uomo. L’educazione è un continuo divenire: un costruirsi e ricostruirsi nell’atto del pensiero pensante che rifiuta l’immobilità del pensato. Per Gentile, diventare uomo è agire da tale: questo è il suo lascito filosofale, bagnato dal martirio del corpo assassinato nel terribile epilogo della guerra civile.
La pedagogia, dunque, non legittima la diserzione dinanzi alla lotta che va in scena nel teatro delle umane vicende né autorizza il licenziarsi dalle responsabilità sociali, ma invece si configura quale manifestazione razionale del potere umano di causare intenzionalmente gli accadimenti. La storia è il fare prassico dell’umano perché è la casa dello spirito. Essere spettatori significa, in questa morfologia del combattimento, viltà, latitanza, degradazione: sono vocaboli che declinano una grammatica dell’inumano contro la quale Gentile si è sempre scontrato, restando, fino alla fine, coerente con il carattere della sua filosofia.
La pedagogia, nella lezione attualista, non è dunque sintassi del suono, semmai delle idee che si fanno azione: il divenire è conquista quotidiana poiché è battaglia che attraversa ogni frammento di tempo per rivendicare il proprio diritto-dovere all’esistenza. È ciò che hanno fatto Falcone, Borsellino e tutte le vittime della mafia: hanno preferito lottare e non disertare. All’indifferenza hanno privilegiato la resistenza: alla paura, il coraggio. Alla morte, la Vita, sempre quella scritta doverosamente al maiuscolo. «Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura una volta sola»: è la frase chiave di questa pedagogia che rende omaggio all’esistenza, segnandone i momenti e costruendone, in maniera intensa, il significato sociale.
Le parole conclusive di Borsellino alla Veglia per Falcone sono il manifesto di una pedagogia della liberazione che si scopre autentica scienza della vita: «Sono morti tutti per noi, per gli ingiusti, abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera. Facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che impongono sacrifici; rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne (anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro); collaborando con la giustizia; testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere, anche dentro le aule di giustizia. Troncando immediatamente ogni legame di interesse, anche quelli che ci sembrano innocui, con qualsiasi persona portatrice di interessi mafiosi, grossi o piccoli; accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità di spirito; dimostrando a noi stessi ed al mondo che Falcone è vivo».
Conoscere le mafie significa agire contro di esse, declinare precise norme di comportamento morale: sul piano sociale, è esercitare una scelta, un’opzione (netta) di esistenza. Borsellino non si limita soltanto al ricordo, seppur profondamente commosso, di Falcone, della moglie e degli uomini della scorta. La sua memoria senza dubbio riannodava, in quegli istanti, il filo rosso di sangue che teneva unito, in un abbraccio denso di calda umanità, tutte le vite, con i loro sorrisi e sogni, spezzate dalla violenza mafiosa.
La riflessione di Borsellino è una lucida rappresentazione di una pedagogia della cura, più specificatamente del prendersi-cura: quella che accarezza teneramente i giovani, invitandoli a non piegarsi alle ingiustizie. Quella che offre il proprio corpo, la propria nuda materia, in dono per emancipare l’umano dalla paura di vivere, di morire e di restare prigioniero di un’etica che inchioda a rigidi codici di condotta. Prendersi-cura è un concepire l’educazione come atto di umana comprensione nei confronti di quella geografia delle passioni indagata con efficacia argomentativa da Machiavelli nel capitolo XVII de Il Principe . La realtà effettuale, di cui il Segretario fiorentino è un elegante studioso, ci sorregge ermeneuticamente nelle letture sociali delle relazioni di potere. E le mafie si muovono essenzialmente all’interno di questa fenomenologia, connotata, peraltro, da un forte dispositivo educativo funzionale alla riproduzione del loro sistema valoriale.
Giovanni Falcone del resto ha sempre invitato a un approccio “realista” nell’accostarsi all’analisi del potere mafioso che è metafora delle “passioni tristi” della materia umana: «Gli uomini d’onore non sono né diabolici né schizofrenici. Non ucciderebbero padre e madre per qualche grammo di eroina. Sono uomini come noi. La tendenza del mondo occidentale, europeo in particolare, è quella di esorcizzare il male proiettandolo su etnie e su comportamenti che ci appaiono diversi dai nostri. Ma se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci assomiglia».
Questa osservazione del giudice Falcone racchiude una sofisticata morfologia della lotta che spinge a “condannare al rogo” i vaniloqui della cultura complice del potere mafioso: quella che ha legittimato con il suo astratto eruditismo l’educazione al silenzio e alla rassegnazione come uniche modalità di comportamento sociale. Quella che ha scelto di stare alla finestra e di espungere dai territori cognitivi della sua riflessività ogni analisi dei contesti sociali e delle loro effettive dinamiche politico-relazionali. In Calabria e nel Mezzogiorno si muore di libertà e si vive di indifferenza: eroismo e viltà si mescolano dando vita a una rappresentazione dell’esistenza a doppia cromatura, bianca e nera. Cromatura dalla proporzione decisamente diseguale perché sbilanciata nettamente a favore del nero: questione che restituisce sul piano sociale tassi troppo elevati di analfabetismo etico.
Per stare al mondo a queste latitudini è ancora particolarmente diffusa l’aderenza a quella Weltanschauung esplicitata dal vecchio proverbio di omertà: cu è surdu, orbu e taci, campa cent’anni in paci (chi è sordo, cieco e tace, vive sempre in pace).
Nel linguaggio quotidiano, compreso quello che ha contaminato l’alfabeto esistenziale dei nostri studenti, si sente spesso ripetere argomentazioni del genere: “Ma non è colpa mia se lo Stato ci ha abbandonato”; “le cose da noi sono sempre andate così e continueranno ad andare in questo modo”; “non voglio fare l’eroe”...