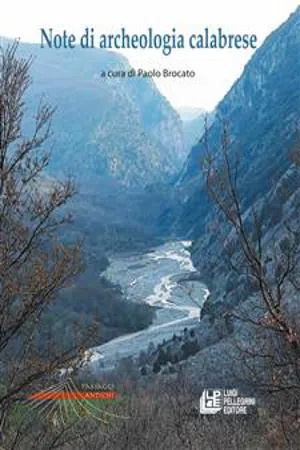Lagaria tra mito e storia
Paolo Brocato
Premessa
Le vicende mitiche di Epeio e ancor più quelle di Lagaria non sono di un’ampiezza tale da permettere riflessioni molto approfondite, non c’è grande ricchezza di dettagli, né di vicende, tuttavia i pochi elementi a noi giunti dalle fonti antiche, di contrappunto, portano a ragionare su tematiche complesse di cui è addirittura molto difficile cogliere tutte le sfaccettature e abbracciarle con piena consapevolezza; esse peraltro contengono non pochi elementi di ambiguità. Al centro della problematica è la colonizzazione e nello specifico il rapporto tra achei e indigeni, tema ricco ma nello stesso tempo vuoto se non si mettono in campo nuovi argomenti e ricerche analitiche. Ma soprattutto se al centro del dibattito non si pongono anche le questioni dei metodi della ricerca e quelli della tutela e la loro incidenza e ricaduta nella società al fine del progresso civile ed economico, anche delle zone più periferiche.
La proposta di localizzazione di Lagaria
Non si vuole qui intraprendere l’ennesima discussione sulla localizzazione di Lagaria, ma semplicemente definire gli elementi che tendono a rendere credibile l’ipotesi di identificazione del sito con la zona archeologica che comprende l’area sacra del Timpone della Motta, la necropoli di Macchiabate e le aree di abitato circostanti nel comune di Francavilla Marittima. Numerosi elementi infatti, offerti da recenti ricerche, permettono di considerare tale soluzione la più accettabile sotto il profilo scientifico.
Già in passato l’umanista Gabriele Barrio aveva proposto tale identificazione e i dati complessivi della ricerca allo stato attuale non lo contraddicono, anzi consolidano la veridicità della sua affermazione. Anche Tanino De Santis era stato un convinto assertore dell’ipotesi fin dai primi rinvenimenti archeologici. In anni meno lontani Marianne Kleibrink, protagonista di scavi ancora in parte inediti sul Timpone della Motta, ha anch’essa proposto tale identificazione facendo leva soprattutto sulla presenza del santuario di Atena e su alcuni elementi cultuali. Di recente Maggiorino Iusi, modificando la tradizione di studi, limitata alla ricerca del singolo elemento, ha proposto un sistema organico appoggiandosi su nuovi elementi emersi dalla ricerca storica, soprattutto in relazione alla toponomastica. La tesi sostenuta da Iusi porterebbe quasi a sciogliere quello che egli stesso chiama il “nodo lagaritano”, restituendo alla realtà storico topografica un antico centro, che veniva di continuo spostato dagli studiosi da una zona all’altra della costa ionica.
Se dunque allo stato attuale dovessimo sostenere tale ipotesi di identificazione, proprio sulla base dei precedenti studi, avremmo diversi elementi su cui fondare tale ricostruzione. Primari tra questi sono, a nostro avviso, due di essi: la presenza di un santuario di Atena sul Timpone della Motta, resa certa dal rinvenimento della dedica alla divinità da parte dell’agonoteta Cleombroto; e i dati toponomastici relativi ai fiumi di Lagaria, sia per l’identificazione del Kylistanos con il Raganello e sia per il Cyris con il Caldana. Questi dati primari, come altri meno diretti ma pur sempre molto rilevanti, sono stati messi in risalto da M. Iusi, che, in particolare, ha rintracciato l’acuta osservazione di Parrasio, il quale, nella parte relativa all’arrivo di Epeio dell’Alessandra di Licofrone, intravede la possibilità di leggere al verso 931 il sostantivo “falange” seguito dall’aggettivo “turia”. Tale lettura sembra avere notevole interesse, benché la maggior parte delle edizioni critiche prediligano una traduzione diversa, forse anche basata sull’interpretazione che vede la vicenda di Epeio ambientata nel metapontino, sulla scorta del noto passo di Pseudo Aristotele. Rappresentare Epeio come timoroso di fronte alla “falange turia” piuttosto che alla “falange impetuosa” cambia profondamente i termini della questione, suggerendo una localizzazione diretta di Lagaria nell’ambito geografico turino. Di nient’altro ci sarebbe bisogno per suffragare l’ipotesi e lo stesso passo di Strabone, VI,1.14, che pone Lagaria dopo Thurii e prima di Heraclea, non presenta alcuna contraddizione. È molto verosimile che Licofrone abbia voluto, come accade spesso nel suo testo, giocare sull’ambiguità del termine che, in entrambi i significati, ben si adatta al contesto narrativo e poetico.
La storia degli studi in maniera univoca ha sempre trattato della fondazione e della colonizzazione di Sibari in maniera separata e senza dar peso al materiale che le fonti letterarie fornivano sull’antico centro di Lagaria. Il problema della sua localizzazione infatti non permetteva di considerare pienamente il contesto archeologico territoriale di cui faceva parte in rapporto ai dati letterari. L’impossibilità di localizzare il sito ha di fatto prodotto una scissione tra i dati archeologici, emersi da scavi e ricognizioni di superficie, e la tradizione letteraria sull’antico centro. Si è così oscurata e posizionata nel limbo la tradizione letteraria sull’antico centro, congelandola a tempo indeterminato, sebbene i dati archeologici dei supposti siti di localizzazione siano stati esaminati secondo profili di ricerca diversi. L’incertezza della localizzazione ha causato una amnesia nella ricerca, se escludiamo la Kleibrink, rimuov...