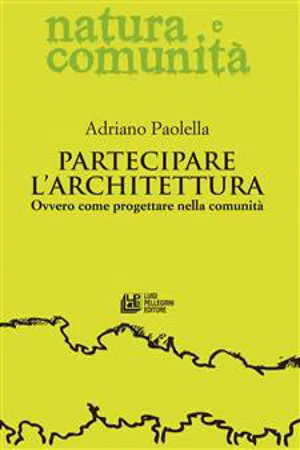1. L’architetto ordinatore
Leon Battista Alberti a metà del XV secolo, in De re edificatoria, opera la più importante classificazione delle componenti del linguaggio architettonico dell’era moderna.
È un testo fondamentale a cui in seguito si riferirà una estesa elaborazione culturale e i cui ragionamenti sulla firmitas, utilitas e venustas ancora oggi sono considerati dagli architetti importanti spunti di riflessione.
Nella sua elaborazione Alberti traccia quei criteri relativi al decorum che uniscono la parte formale dell’edificio alla dimensione etica e sociale e delinea una gerarchia tra le tipologie di edifici in relazione alla loro funzione collegando con diversi livelli di dignitas e di ricchezza di ornamentum.
Attraverso questo impegno teorico Alberti collega manufatti e società e tenta di ordinare gli edifici, la città, l’organizzazione sociale in un unico progetto.
Uscire da quella, come a lui appariva, confusione che aveva caratterizzato i secoli precedenti, recuperare le forme del costruire da una società, quale quella romana, organizzata, centralizzata, fortemente gestita, implicava un nuovo ordine insediativo e sociale.
Un ordine che manifestasse le gerarchie, garantisse un decoro per tutti gli abitanti e, attraverso di esso, raggiungesse la bellezza.
Da allora in poi molti si sono dedicati a simili elaborazioni teoriche. Fino al XIX secolo è tutto un fiorire di regole e di ordini architettonici: alcuni testi sono semplici catalogazioni di misure, di descrizioni di componenti, altri sono integrati con riflessioni di maggiore respiro.
Dato comune al panorama di elaborazioni è la figura di un architetto che ha il suo principale ruolo nell’ordinare il mondo attraverso l’applicazione di linguaggi architettonici codificati.
Molti si interessano solo delle sedi del potere politico e religioso, alcuni si occupano delle abitazioni di minor prestigio, ma tutti ritengono che la qualità della vita si esprima attraverso l’ordine definito dal loro linguaggio.
Questa tensione all’ordinare, a collocare ciascun abitante in una definita casella secondo schemi predefiniti permane anche nei secoli successivi. Così quando Fourier, Owen e poi Howard disegnano i loro insediamenti, con una sensibilità molto più accentuata nei riguardi delle condizioni abitative dei meno abbienti, sono tutte “città” regolate su forme astratte, su considerazioni teoriche, e anch’esse profondamente ordinatrici.
Anche, Tony Garnier con la sua Cité Industrielle, in cui gli edifici residenziali sono semplici e “personalizzati”, definisce un impianto insediativo ordinatore.
Il parossismo di questa impostazione professionale si raggiunge con il movimento moderno, in cui la crescente sensibilità sociale trova sfogo nella figura di architetto-interprete delle necessità, schematizzate e uniformate, degli abitanti. Le Corbusier che, con la sua Ville Radieuse, una città più che utopica molto atopica, si propone di sostituire qua e là nel mondo gli insediamenti esistenti, anche storici, dedicandosi con particolare veemenza critica a Parigi e New York, è uno dei maggiori esponenti di questa impostazione.
Ma nel XX secolo tale atteggiamento non è stato esclusiva del movimento moderno ma ha interessato anche alcuni “tradizionalisti” (si veda ad esempio Paul Schmitthenner negli anni venti), che seppure profondamente critici nei confronti del moderno, individuavano nel “mettere in ordine” il compito connaturato dell’architetto.
In molte di queste elaborazioni teoriche la ricerca di ordine formale è una tensione che eccede la mera definizione di un linguaggio e le forme sono lo strumento per indirizzare i comportamenti al fine di supportare l’organizzazione ordinata della società, cosicché gli architetti, anche quando non si interessano esplicitamente degli aspetti sociali, non esulano dall’immaginare attraverso le strutture insediative l’organizzazione della vita della comunità.
L’architetto ordinatore, sulla base dell’osservazione critica disciplinare, constata il malfunzionamento della società e assume la consapevolezza che essa, senza il suo contributo nel progettare insediamenti e architetture qualificati non avrebbe alcuna possibilità di migliorare le proprie condizioni. Partendo da questo presupposto, si ritaglia un ruolo in cui la sua azione, fondata sulla capacità tecnica acquisita nei percorsi formativi, deve attendere alle predisposizione delle soluzioni a beneficio della società.
Si definisce così una dimensione operativa collocata all’interno dell’elaborazione disciplinare in cui l’architetto si arroga, sulla base di una visione settoriale e teorica, il ruolo di interprete degli altri, dei loro bisogni e desideri, di rappresentare l’interesse comune anche quando questo non è stato esplicitamente espresso, senza sentire alcun bisogno di confrontarsi con gli abitanti. Una dimensione avulsa dalla comunità ma coerente con l’interpretazione della stessa attuata alla luce delle teorie di riferimento.
Questa impostazione, in cui l’architetto si attribuisce un ruolo eludendo un contatto diretto con le comunità, questa autolimitazione delle proprie attività all’interno del soddisfacimento delle richieste solo di alcune committenze, ha contribuito non poco a produrre i contemporanei insediamenti: un prodotto, a guardare, non ben riuscito. Una colata di costruzioni che ha ricoperto la morfologia naturale, distrutto la vegetazione, perso ogni contatto con i luoghi, sostituendo ad una varietà mirabile una uniformità alienante. Una infinità di unità abitative, per gran parte uguali (le differenze sono determinate dalle disponibilità economiche dei proprietari), mal costruite, energivore, che impediscono agli abitanti la percezione del paesaggio e il rapporto con la natura. Un deserto biologico che produce mobilità congestionate, inquinamento e danni alla salute degli abitanti.
All’interno di questo magma vi sono realizzazioni, di numero ridotto, di architettura di qualità, quelle per le quali si sono create le condizioni economiche e sociali per cui il progettista ha operato secondo il proprio linguaggio. Per delineare lo specifico ambito di azione ed evitare che esso fosse confuso con il resto degli edifici, alcuni hanno teorizzato la separazione tra il magma, nominandolo edilizia, e gli edifici generati dalle elaborazioni e dai linguaggi disciplinari, questi sì davvero architettura.
Ma il magma è il luogo dove vive la maggior parte della popolazione ed è l’esito di processi economici e sociali che gli architetti, per cultura e capacità tecnica, non dovrebbe ignorare.
La supina accettazione dello stato di fatto, il disinteresse verso ambiti operativi ritenuti, per pavidità culturale, estranei alla disciplina, l’interpretazione autoreferenziata dei fenomeni che interessano le comunità e i luoghi, impediscono all’architetto di svolgere quel ruolo propositivo e critico fondamentale per le comunità e lo limita ad essere un ordinatore in un gioco che né governa né ostacola.
Ci sono dei periodi in cui l’assuefazione alla realtà diviene una posizione diffusa, in cui la priorità condivisa dai più appare la realizzazione di un segno riconducibile al progettista; e uno di questi sembrerebbe la nostra contemporaneità.
La carenza da parte dei tecnici di riflessioni e di pratiche critiche rispetto al modello insediativo fa sembrare come se il consumo di suolo, la mobilità selvaggia, la scarsa qualità edilizia e paesaggistica, la lontananza dalla natura fossero condizioni inalienabili dell’abitare. La fascinazione nei confronti delle città dei grattacieli, degli edifici dei grandi poteri economici, delle abitazioni ricche, della straordinarietà delle soluzioni sembra denotare, oltre ad una consapevole condivisione del modello economico e sociale che li genera, forse anche un’incapacità di relazionare il fascino delle forme con l’iniquità che le genera.
Se questa è una condizione culturale diffusa forse è parte del ruolo degli architetti sensibilizzare con le proprie idee e con la propria attività verso altre soluzioni.
È possibile abitare in insediamenti che facilitino il benessere delle persone, che riducano gli effetti negativi nell’ambiente, che rispondano alle esigenze ed ai desideri degli individui e delle comunità.
È possibile rendere prossimi residenza e luogo di attività, luoghi di consumo e produzione alimentare (senza costringere ad una mobilità di persone e di merci insostenibile per il Pianeta), comporre un rapporto costante e non coercitivo con la natura (i parchi urbani, pur indispensabili, fanno pensare all’ora d’aria dei carcerati), facilitare con la conformazione degli insediamenti le relazioni e la vita degli abitanti. Non sembrano obiettivi irraggiungibili ma solo estranei agli interessi che attualmente regolano gli insediamenti; comunque non sono obiettivi al di fuori del ruolo e delle competenze degli architetti e ciò almeno in ragione dello stretto legame, ben chiaro per l’Alberti e la manualistica precedentemente citata, che regola il rapporto tra conformazioni degli insediamenti e caratteri della comunità insediata
Proprio nella modificazione dei criteri di intervento gli architetti possono esercitare un ruolo propositivo e concreto.
Oggi l’architetto è una figura professionale opaca, il suo ruolo mortificato e marginalizzato: stretta dai contenuti “scientifici” di altre discipline maggiormente funzionali alla cultura del mercato globale industrializzato, ha il suo massimo riconoscimento nell’applicare la propria creatività ad esaudire le richieste di visibilità e di rappresentazione.
Tutta la potenzialità connessa alla capacità di critica, di interloquire con gli altri, di trasformare interessi e desideri in edifici, di proporre modelli condivisi, tutte attività che sono parte del mestiere dell’architetto, è persa; il mestiere è mutilato della parte sociale e umana.
Come se non bastasse gran parte degli architetti, affascinati dalla grande notorietà raggiungibile nell’attuare acriticamente le richieste dei potenti, diventano epigoni delle star operando in uno stato di emulazione confusionale in cui non riescono nemmeno ad individuare la propria convenienza.
Forse proprio partendo dalla critica al modello insediativo contemporaneo, esito di una economia disattenta agli individui, che non dà piacere, che non aiuta il raggiungimento del benessere, che non risponde alle richieste e ai desideri dei cittadini, si può conferire un senso alla professione.
Ma per fare questo l’architetto deve riflettere su quanto l’interlocuzione con gli abitanti sia parte fondamentale del proprio mestiere. Perché proprio partendo da una relazione stretta con le comunità, dando la parola a coloro i quali abitano nel prodotto del proprio lavoro, aprendo il processo di progettazione e realizzazione ai contributi dei cittadini è possibile delineare un ruolo meno dipendente dal fluttuare delle mode e degli interessi globali.
Non solo, ma per interloquire con le comunità è necessario rientrare in esse rispondendo alle specificità delle stesse e dell’ambiente ove sono insediate.
L’architettura, proprio per non essere disciplina artistica ma mestiere creativo, è strettamente connessa alla società e quindi il progetto è un atto, consapevolmente o inconsapevolmente, di natura politica. E oggi non serve più (ma forse non è mai servito) un astratto ordinatore di un linguaggio disciplinare, troppo frequentemente asservito agli interessi dei poteri economici e politici, ma un fluidificatore dei tanti desideri individuali presenti nella società e un promotore di quegli interessi comuni che sono alla base della composizione di un insediamento.
L’architetto, inoltre, dovrebbe acquisire la consapevolezza che la sua priorità è ridurre gli effetti negativi sulla natura e nelle comunità interessate dalla trasformazione. In questo quadro ordinare è una semplificazione che impoverisce culturalmente e socialmente individui e comunità mentre la considerazione e il mantenimento della diversità sono condizioni inalienabili del progetto.