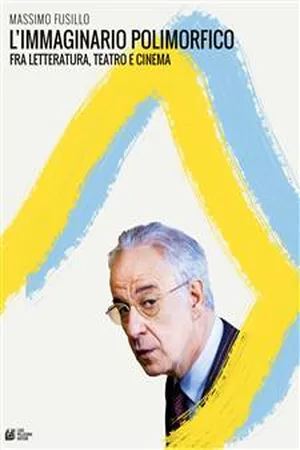I. Questioni di poetica
«Stavo solo facendo del cinema». Intersezioni e ibridazioni
Sul sistema complessivo delle arti la nascita del cinema ha esercitato un impatto senza dubbio rivoluzionario. Pari solo all’impatto che proveniva da una scienza nata in quegli stessi anni, la psicanalisi, che ha trasformato radicalmente ogni visione dell’identità umana, producendo nuove poetiche dell’immaginario. A questo sincronismo fra due fenomeni che tanto hanno caratterizzato il Novecento si è attribuito spesso, fra l’altro, un valore simbolico, a partire dall’onirismo del mezzo cinematografico, anche se certo le date di nascita in questo campo sono sempre orientative, segmentano processi fluidi. Parlare di impatto rivoluzionario del cinema sulle altre arti e quindi anche sulla letteratura oggi è un’ovvietà, ma c’è voluto un tempo lunghissimo per arrivare a questa constatazione, superando ogni sorta di pregiudizio intellettualistico. Anzi, non è certo un caso se si è giunti alla piena legittimazione estetica e accademica del cinema quando questo ha iniziato a essere incalzato da nuove forme di comunicazione e di narrazione, rischiando quasi la museificazione. Nonostante le crisi ripetute e le morti annunciate (armamentario assai trito della critica di tutti i tempi e di tutte le arti), e, soprattutto, nonostante le diverse forme di ricezione e di distribuzione che si stanno affermando, il cinema gioca ancor oggi un ruolo primario nell’immaginario collettivo.
Erede del Gesamtkunstwerk wagneriano, propugnato anche dalle avanguardie storiche, arte sintetica e mista per eccellenza, il cinema esemplifica splendidamente quell’intreccio stretto fra verbale e visivo di cui trattano i visual studies, e su cui ha scritto pagine fondamentali W.J.T. Mitchell. È dunque un’arte fortemente ibrida: non è un caso che, a differenza del purismo modernista, volto alla ricerca dell’essenza specifica di ogni arte, il purismo cinematografico sia stato e sia un fenomeno molto più ristretto: limitato a qualche posizione critica, o alle poetiche di registi come Robert Bresson o Lars von Trier. In genere si tende al contrario a non limitare per nulla la ricchezza di codici e di linguaggi tipica del cinema: prima forma di spettacolo a durare nel tempo e a ripetersi uguale a se stessa, è notoriamente un’arte visiva, grazie al ruolo fondamentale della fotografia; narrativa, grazie al montaggio; drammatica, grazie alla grammatica dei piani e all’organizzazione del profilmico. Come l’orchestra nelle opere di Wagner, la macchina da presa vi svolge la funzione del narratore, mentre è allo stesso tempo possibile attivare una voce fuori campo di vario genere, e un commento musicale; per non parlare di forme più stranianti, come l’intertitolo.
Come si accennava prima, la lentezza con cui il mondo letterario, e in particolare quello accademico, si sono misurati con le novità espressive di questa arte è piuttosto sconcertante. In Italia, ad esempio, oggi si moltiplicano gli insegnamenti di Cinema e Letteratura, ma fino a pochi anni fa erano ancora relativamente poche le cattedre di Storia del Cinema, e spesso troppo legate alla Storia dell’Arte, seguendo un’impostazione figurativa che si deve a Carlo Ludovico Ragghianti. Anche per quanto riguarda la comparatistica, a differenza di quanto è avvenuto a proposito dei rapporti con le arti visive, il confronto fra letteratura e cinema si è troppo fossilizzato sui problemi dell’adattamento, dando vita ai cosiddetti fidelity studies. Quella della fedeltà è senza dubbio una pessima metafora, non solo perché si richiama ai rigori e agli integralismi della monogamia e del monoteismo, poco adatti al polimorfismo dell’universo estetico. Ma soprattutto perché denuncia un’ossessione per l’originario che è un antico vizio della cultura occidentale. Il verbale finisce sempre per avere una posizione di primato rispetto al visivo, sentito invece come un oggetto muto, passivo, femminile (è il fenomeno che è stato argutamente battezzato fallologocentrismo). Il film tratto da un’opera letteraria dovrebbe quindi riprodurre, rendere, illustrare il testo da cui è tratto: tutte operazioni fortemente subordinate a un’entità sentita come originaria, e quindi più ricca e autentica. In fondo l’adattamento viene facilmente assimilato a una traduzione (altro campo in cui furoreggia il dogma della fedeltà): persino un intellettuale certo non accusabile di pregiudizio contro le arti audiovisive, come Umberto Eco, nel suo libro sulla traduzione, in cui si occupa anche di adattamento cinematografico, mostra un’incredibile chiusura umanistica e una scarsa sintonia con l’opera di Visconti (il film in questione è Morte a Venezia, 1971).
Come accade anche per la performance teatrale, si riconosce spesso con difficoltà l’autonomia creativa del regista. Eppure, il testo letterario da tempo non è più considerato come un sistema chiuso, ma come un fascio di potenzialità, che possono essere attualizzate in maniera assai diversa dai diversi pubblici, contesti, epoche, o singoli fruitori. Il postmoderno ha certo cambiato radicalmente i presupposti dell’adattamento teatrale o cinematografico, favorendo un’estetica della contaminazione e della riscrittura infinita, ma non sempre questi presupposti sono stati recepiti appieno dalla ricerca critica, soprattutto in ambito letterario.
Sicuramente è più stimolante riflettere sul rapporto inverso: sull’influsso che ha avuto il cinema sulla letteratura. Da questo punto di vista c’è da affrontare subito un problema critico alquanto spinoso: come valutare la reale incidenza cinematografica delle tecniche espressive di volta in volta prese in esame. Non basta che ci sia una simultaneità fra due linee di azione in un romanzo perché si parli di montaggio alternato, o che ci sia un punto di vista ristretto perché si parli di soggettiva. Non è un caso che negli ultimi tempi si siano moltiplicati i saggi su Omero, Virgilio, Dante, Tasso, Balzac cineasti: non è un semplice gioco borgesiano, che mira a rovesciare la logica lineare del tempo storico, per dimostrare che inevitabilmente leggiamo Dante in maniera diversa dopo Eliot; e ovviamente leggiamo anche Omero o Balzac in maniera diversa dopo Griffith e dopo Hitchcock. C’è comunque qualcosa in più in questa applicazione delle categorie dei film studies ad autori vissuti secoli o millenni prima dell’invenzione del cinema. C’è la riprova che non esiste uno specifico filmico, così come non esiste uno specifico letterario e uno teatrale: non sono essenze, ma modalità che si trasformano e si intrecciano di continuo. Il cinema ha realizzato tecnicamente e ci ha permesso di descrivere meglio una serie di procedimenti espressivi che sono sempre esistiti, e che rientrano in quell’intreccio stretto fra verbale e visivo di cui è fatta in primis la nostra memoria, la nostra percezione, la nostra cultura, e di cui, come si accennava prima, si occupano da tempo i visual studies. Da questo punto di vista è assai illuminante leggere le dense riflessioni estetiche di Musil sul terreno profondo comune alle varie arti, e sulla possibilità del cinema di produrre una nuova percezione della realtà, attenta al legame magico fra le cose: di raggiungere insomma la dimensione interiore delle immagini.
Ci sono però ovviamente casi in cui la derivazione cinematografica di uno stile letterario è piuttosto evidente. Un saggio di Magny, a suo tempo molto discusso, lo ha dimostrato in maniera piuttosto chiara per la narrativa americana del primo Novecento. La rigorosa focalizzazione esterna con cui Dashiel Hammett costruisce tutti i suoi romanzi fa pensare a un narratore-camera, che spia l’azione da varie angolazioni, senza poter entrare nella mente dei suoi personaggi e senza che abbia una benché minima pre-informazione sull’intreccio o una benché minima visione d’insieme. I romanzi corali di Dos Passos, con la loro alternanza di brevi scene e brevi frammenti, intervallati da corpose ellissi, non possono non far pensare a una mimesi letteraria del montaggio cinematografico: quel tipo di percezione frantumata che già Serghey Ejzenštejn, in uno dei grandi libri del Novecento, faceva risalire al mito di Dioniso e allo sparagmos subito proprio di fronte allo specchio, come in una versione archetipica della fase lacaniana del corps morcelé. Tutte le macchine e tutte le innovazioni tecnologiche (dal treno agli strumenti ottici fino alle nanotecnologie recenti) hanno trasformato la nostra percezione del mondo e i nostri stili di vita, e quindi hanno anche inevitabilmente inciso sulla letteratura. Ma molto spesso l’idea di un influsso monodirezionale non esaurisce la complessità dei fenomeni. Come ha sostenuto una delle voci più autorevoli intervenute su questo tema, e più critiche nei confronti della nozione di influsso, André Bazin, è meglio parlare di convergenza estetica fra forme di espressione contemporanee: non tanto per elaborare una narratologia comparata, che pure ha una sua innegabile utilità, quanto per integrare i diversi generi artistici in un contesto di produzione ed elaborazione dell’immaginario.
Resta comunque aperto il problema critico a cui accennavo sopra: qual è il discrimine con cui riconosciamo in un testo letterario un effetto di rifrazione del cinema? Certo non possiamo appellarci al vecchio criterio dell’intenzionalità o all’angusta prospettiva filologica delle fonti, entrambi da tempo giustamente banditi o superati dalla teoria letteraria. Non basta che uno scrittore dichiari di imitare effetti cinematografici, o che abbia visto e amato un particolare film, per poter parlare di effetto rebound del cinema sulla letteratura. Deve essere una strategia di lettura, che sappia dimostrarsi persuasiva e coerente, capace di illuminare nuove zone del testo, senza ridursi invece a una pura questione di nominalismo, a una diversa etichetta per antiche prassi narrative. Con questo non intendo certo ridimensionare il ruolo del cinema nella letteratura contemporanea: l’enciclopedia comune agli scrittori di oggi e al loro pubblico contiene inevitabilmente un gran numero di film, oltre che di romanzi e altri testi di vario genere. Come accade per alcune categorie psicanalitiche primarie, che proprio in quanto primarie sono onnipresenti, e quindi non particolarmente interessanti da notare e da trattare, così anche gli stilemi cinematografici appartengono a quella lingua comune che condividono gli scrittori attivi dopo i fratelli Lumière (e dopo Freud). Perché l’effetto rebound sia interessante, occorre innanzitutto che sia ben percepibile: che sia una strategia espressiva, non un tratto di langue.
Le cose stanno diversamente se passiamo al piano della tematica, che si è espanso sempre più negli ultimi tempi, andando ben oltre il sottogenere dei film novel, dedicati per lo più alla rappresentazione del mondo di Hollywood. Nella narrativa postmoderna il cinema non si limita al piano dell’argomento e del contenuto, ma coinvolge anche il senso, diventando quindi tema in senso pieno. Nel momento in cui in un romanzo si descrive un film, reale o inventato che sia, si producono sempre reti di rapporti complessi fra immagine e racconto, incrinando spesso i generi stessi del discorso. Il film non viene ripercorso analiticamente, come in una ekphrasis alessandrina o barocca, ma evocato nella sua materialità di evento visivo. Sempre più spesso nella narrativa contemporanea – Puig, Marías, Soriano, Auster – sono proprio i meccanismi della fruizione cinematografica a diventare oggetto centrale del racconto: una fruizione frammentaria, casuale, mediata dalle videocassette o dalla TV, che interviene nella narrazione come un corpo estraneo, richiamando nel lettore una diversa modalità di percezione, e un mondo narrativo parallelo. Come dimostra il caso particolarmente significativo di Don DeLillo, al romanziere contemporaneo imbevuto di cinema e di cultura visiva di ogni tipo non interessa creare un corrispettivo letterario del mezzo filmico, quanto, al contrario, sottolineare un’alterità dell’immagine, una dissonanza fra linguaggi difformi, che però si ibridano di continuo nel polimorfismo della videocultura. Non tende dunque ...