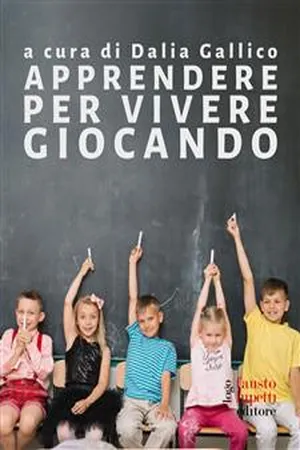![]()
OSPEDALE: STORIA E SIGNIFICATI
La storia della cura dei bambini nasce con la costituzione di orfanotrofi, di ospizi per infanti; i viandanti precari, i bambini senza famiglia, gli “esposti” e i “trovatelli” venivano accolti in “case ospitali”. A Milano nel 787 l’arciprete Dateo creò il prototipo di questi luoghi di accoglienza e cura, chiamati brefotrofi.
Nel Medioevo fiorirono in Italia e in Europa questi “ospizi” e durante il Rinascimento questo impegno caritativo crebbe ulteriormente. Nel 1500 L’Ospedale Maggiore di Milano proponeva un’assistenza dalla nascita all’adolescenza, fino alla giovinezza; purtroppo la pratica dell’esposizione (l’abbandono) cresceva progressivamente e nel Seicento furono istituite le “ruote”, bussole di legno rotanti, dotate di un’apertura sull’esterno del brefotrofio: in esse il bambino poteva essere abbandonato senza che la madre venisse riconosciuta.
Purtroppo questi luoghi subirono un’inversione di valore, proprio a causa dell’elevato numero di abbandoni; le scarse condizioni igieniche e sanitarie trasformavano i brefotrofi da luoghi di protezione dei bambini a luoghi dove questi si ammalavano più facilmente, dove la mortalità era elevata e causava vere e proprie “stragi degli innocenti”. Questo perché i luoghi di assistenza, ancora nei primi decenni dell’Ottocento, non avevano l’assistenza continuativa di medici e, soprattutto, la competenza di quest’ultimi era pressoché nulla riguardo alla cura delle malattie infantili. Il medico chirurgo Giovan Battista Palletta (1748 – 1832) ammetteva la quasi totale assenza di armi contro la mortalità infantile e riteneva che le donne, che assistevano i bambini, potevano capire meglio e più presto del medico stesso.
In Italia, le origini della pediatria possono essere fatte risalire all’istituzione di una cattedra di malattie infantili all’Università di Pisa, fortemente voluta, nel 1802, dall’Ospedale degli Innocenti di Firenze. Da quel momento alcuni medici diventarono esperti dell’infanzia e trasformarono le esistenti istituzioni di carità e assistenza in realtà ospedaliere all’insegna dello spirito scientifico.
Due figure importanti alla fine dell’Ottocento, nella città di Milano, promossero la cura del bambino: Luigi Mangiagalli (1849 – 1928) iniziatore della moderna ginecologia e Raimondo Guaita (1852 – 1913) iniziatore della moderna pediatria. Quest’ultimo fu l’infaticabile sostenitore della nascita dell’Ospedale dei bambini di Milano, oggi conosciuto come “Vittore Buzzi”. Egli sentiva molto forte la necessità di dotare anche Milano di un ospedale per bambini, ritenendo una grave mancanza, per una città che si avviava a divenire a capitale economica e morale d’Italia, l’assenza di un pedocomio (come allora veniva chiamato l’ospedale per i bambini).
Quella del dottor Guaita fu una pediatria militante, in un periodo nel quale, sul piano politico oltre che su quello medico, si poneva il problema di un miglioramento generale della salute. Una maggior tutela sanitaria dell’infanzia comportava, come primo obiettivo, la diminuzione della mortalità infantile, ancora troppo elevata in parecchie zone della penisola. Al superamento di questo grave stato, dovevano contribuire una più adeguata assistenza al parto, una migliore igiene nelle prime fasi di sviluppo del bambino, il ricorso alla vaccinazione per combattere alcune malattie infettive mortali e la diffusione di idee corrette, relative all’allevamento e all’educazione dei bambini.
Il contributo di Raimondo Guaita andava oltre la conoscenza delle malattie dei bambini e oltre le indicazioni di igiene pediatrica; chiariva anche alcuni precisi e innovativi principi. Egli esprimeva la convinzione che negli ospedali per bambini dovessero essere ammessi pazienti, sia maschi che femmine, dalla nascita fino ai 15 anni d’età. Di norma infatti l’età d’ammissione, nei pochi ospedali pediatrici, era tra i 2 e i 7-8 anni; sovente poi, i reparti prevedevano solo degenze maschili. Egli era convinto che l’architettura, le condizioni igieniche e il personale, medico e infermieristico, dovevano essere specifici.
La visione ideologica del Guaita s’incanalava tra l’ottimismo scientifico del positivismo tardottocentesco e l’aspirazione liberal-borghese ad una società migliore e più ordinata, in grado di ridurre i conflitti sociali e le ingiustizie legate alle disparità economiche e di classe, grazie all’intervento filantropico di illuminati benestanti e di lungimiranti politici, piuttosto che con una più equa ridistribuzione delle risorse. Davanti alla raffinata nobiltà e alla ricca borghesia meneghina, Raimondo Guaita non esitava a ribadire con forza una concezione della medicina, e della pediatria in particolare, nella quale egli credeva fermamente: la cura del malato non era sufficiente per guarire la malattia; occorreva anche curare la società nella quale il malato viveva. L’impegno del medico doveva essere anche sociale e politico.
Per quanto riguarda il rapporto tra medicina e bambini, guardando al passato e tentando di leggere il futuro, si possono considerare tre eventi fondamentali.
Nell’Ottocento avviene la scoperta dell’infanzia; l’accresciuta consapevolezza dei bisogni degli infanti e i progressi della medicina e della farmacoterapia spinsero la nascita della puericultura e della pediatria. Si sviluppò una modificazione, sul piano della quantità, della patologia pediatrica: riduzione della mortalità infantile, eliminazione dei disturbi nutrizionali e contenimento delle malattie infettive.
A metà Novecento si ha la scoperta della nascita; cresce la qualità nell’assistenza alla madre e al bambino che sono concepiti come un’unica entità biologica e psicologica. Si affrontano con maggiore sensibilità le sofferenze e le dinamiche psicologiche della gestante per prepararla ad affrontare con consapevolezza e tranquillità l’evento. Uno sforzo quindi verso una umanizzazione del parto, affiancata da una nuova sensibilità verso il neonato, soggetto delle moderne specialità di perinatologia e neonatologia.
In questi ultimi anni si è aperta la fase della scoperta della procreazione; le prime fecondazioni “in vitro” sono state eseguite con successo agli inizi degli anni Ottanta e da quel momento i progressi biotecnologici non hanno conosciuto sosta. Per la prima volta la medicina ha la possibilità di incidere direttamente sulla capacità di sviluppo del bambino. Non solo prima della nascita, ma addirittura prima del concepimento, guidandolo e “programmandolo”. E poi, dopo la nascita, di curarlo se necessario intervenendo direttamente sul suo corredo genetico. Questa nuova medicina biotecnologica offre grandi speranze di salute per le generazioni future, ma pone anche notevoli problemi bioetici; per la prima volta nella storia l’uomo ha la possibilità di programmare la sua stessa esistenza e di influire sul cammino della sua evoluzione biologica.
RICOVERO IN OSPEDALE
Ospedalizzazione
Le cause di ricovero di un bambino possono essere varie: si possono distinguere il ricovero d’urgenza, il ricovero in day hospital e il ricovero programmato.
Il ricovero d’urgenza avviene a seguito di incidenti o malattie acute ed è caratterizzato da una situazione di panico generale sia nei genitori, sia nel bambino.
Il ricovero in day hospital è un ricovero limitato alla permanenza diurna, ed è adottato, in particolare, per i pazienti che devono subire dei trattamenti periodici nel tempo, che altrimenti li costringerebbero ad una lunga degenza. In questo modo possono condurre una normale esistenza all’interno della loro famiglia e frequentare la scuola.
Il ricovero programmato può essere necessario per uno studio diagnostico approfondito che non è possibile fare in ambulatorio o perché la malattia diagnosticata investe un particolare impegno terapeutico non sostenibile a casa. In questi casi è importante la figura del pediatra che prescrive il ricovero; proprio dal pediatra deve cominciare la preparazione della famiglia e del bambino a questo evento, chiarendo, nel possibile, il tipo di terapia o di esami a cui verrà sottoposto il bambino, per evitare shock davanti ad esami o pratiche particolarmente invasive.
Purtroppo, ancora oggi, si verifica spesso la tendenza ad ospedalizzare il bambino malato in presenza di condizioni patologiche non gravi, anche nel caso di una malattia che potrebbe essere affrontata con un’assistenza pediatrica domiciliare.
Oggi è possibile, nella quasi totalità degli ospedali, che il bambino abbia vicino a sé la madre; ma in una situazione di lungodegenza è spesso estremamente difficile per le madri rimanere accanto ai loro bambini tutto il tempo, sia per ragioni emotive che per ragioni pratiche, dovute alle altre forme di responsabilità verso il marito e verso gli altri figli. Se poi ci si sofferma a pensare al costo delle giornate lavorative perse dai genitori per stare, ad esempio, cinque giorni in ospedale con il proprio figlio, quando il ricovero potrebbe durare esclusivamente una giornata, ci si può fare velocemente un’idea del disagio anche economico che comporta una ospedalizzazione.
Dunque il ricovero del bambino malato, quando non giustificato da sufficienti ragioni mediche, dovrebbe essere assolutamente evitato, fatta eccezione per i casi in cui il genitore deleghi completamente alla struttura ospedaliera la cura e l’assistenza del figlio malato, a causa di cattive condizioni socio-economiche della famiglia.
Per evitare o ridurre il ricovero infantile e i tempi di degenza ospedaliera, le unità operative di pediatria dovrebbero organizzare la propria attività e progettare soluzioni ambulatoriali efficienti. Normative, ricerche e sperimentazioni favoriscono e promuovono un processo di deospedalizzazione che vede nell’apertura di day hospital, nell’assistenza sanitaria domiciliare e nell’autogestione della malattia cronica, delle forme d’intervento volte realmente a salvaguardare la salute psichica e fisica del bambino.
L’assistenza sanitaria domiciliare, purtroppo ancora insufficientemente diffusa, consente al bambino malato di vivere l’esperienza del dolore fisico totalmente all’interno della sua famiglia, grazie all’assistenza garantita da piccole equipe sanitarie.
Quindi, tranne i casi in cui il periodo di ospedalizzazione si protrae più del dovuto o si verifica con una certa frequenza, a causa di malattie croniche o di gravi patologie, il bambino lungodegente, oggi, viene ospedalizzato con il proprio genitore per un lasso di tempo che raramente supera le due o tre settimane di ricovero.
Accoglienza
I bambini ricoverati, fin dal loro arrivo in ospedale, sono sempre spaventati e nemmeno la stretta vicinanza dei famigliari che li accompagnano riesce a tradursi in una sicurezza contro l’ignoto. Spesso il volto e le espressioni, tesi e preoccupati, dei genitori, fanno percepire al bambino di entrare in un brutto posto, dove succedono brutte cose.
M. Petrillo e S. Ranger consigliano addirittura l’opportunità di non ammettere al rooming-in quelle madri che, in colloqui preparatori, si fossero dimostrate incapaci di collaborare adeguatamente con il personale; sono quei genitori che, con la loro presenza, tendono a impedire il contatto del bambino con i suoi pari e ad interferire in genere con il suo adattamento.
Anche l’interlocutore in camice bianco è tutt’altro che rassicurante: spesso appare serio e distaccato, magari nello sforzo lodevole, ma non sempre riuscito, di sdrammatizzare la situazione. Il primo passo, verso un’umanizzazione dell’assistenza, dovrebbe consistere allora nel delineare un modo migliore di accoglienza del bambino e del genitore, “un modo più umano di prendersi cura di ogni ammalato, che presuppone delle relazioni interpersonali e una comunicazione attenta e costante da parte del personale medico e infermieristico”.
L’accoglienza è quindi l’incontro che di fatto mette in gioco la capacità relazionale e la professionalità dell’infermiere; quest’ultimo infatti ha un ruolo primario nell’accoglienza ed è colui che deve essere in grado di gestire questo momento.
Poiché il primo contatto del bambino malato con l’ospedale è fondamentale per gli interventi futuri, è importante che il personale, fin dal colloquio iniziale, instauri con il bambino e i genitori una relazione che dia fiducia e sicurezza. Si tratta di essere comprensivi e disponibili alle richieste di spiegazioni, accettando con pazienza la libera espressione di tutti quei sentimenti che si manifestano nelle forme di paura, di difficoltà d’espressione e di incapacità di valutare realmente la situazione, proprie del bambino e della madre spaventati e sprovveduti.
Una volta avvenuto lo scambio di informazioni puramente tecnico-burocratiche tra il genitore e la caposala sul bambino e sulle dinamiche di reparto, il modo migliore per accogliere il bambino malato è quindi quello di portarlo, assieme alla propria madre, in visita al reparto: mostrargli le stanze dove giocano e dove si riposano i coetanei, presentargli il personale di reparto e cercare di fargli superare, con le parole più adatte, le paure di quelle che saranno le cure che dovrà affrontare.
Degenza
Affinché il ricovero, anche se abbreviato a poche settimane, non si trasformi in un’esperienza traumatica, è necessario che la struttura del reparto pediatrico aiuti l’azione protettiva della madre, creando degli spazi che consentano al bambino di non rompere drammaticamente con le sue attività consuete e con lo stile di vita abituale: i bisogni del bambino relativi allo sviluppo della motricità, al suo bisogno di esplorare, di disporre di un’ampia gamma di stimolazioni sensoriali, di sentirsi sempre ed ovunque rassicurato, non dovrebbero essere trascurati neppure in questo nuovo ambiente.
Un reparto pediatrico efficiente dovrebbe rispondere non solo alle esigenze strettamente mediche, ma anche alle esigenze psicologiche e affettive del bambino che di colpo si trova proiettato fuori dalla sua famiglia.
Avviare un processo di umanizzazione dell’ospedale, non significa per forza ristrutturare ex novo gli spazi; l’intervento di ristrutturazione può anche volgersi esclusivamente ad una riqualificazione degli spazi già esistenti e ad una migliore organizzazione degli stessi, attraverso modifiche che non richiedono particolari trasformazioni e oneri finanziari.
Oggi l’ambiente fisico delle pediatrie è in molti casi accogliente, sia che si tratti di strutture vecchie che di edifici moderni: non sono anonimi e c’è molto colore. Il bambino può avere la sensazione di entrare in un ambiente famigliare che gli richiama alla mente l’atmosfera di un asilo o di una scuola materna. Il bambino e il suo accompagnatore non possono, infatti, che trovarsi a proprio agio ed essere tranquillizzati da un reparto che si presenti con pareti variopinte, dai colori vivi, che rallegrano i corridoi e le stanze dei bambini degenti; con un locale adibito a sala giochi in cui i bambini non affetti da patologie gravi, assistiti da un’educatrice, da volontari e dagli stessi genitori, trascorrono il tempo libero, giocando da soli o in compagnia di coetanei; ed infine, con delle sta...