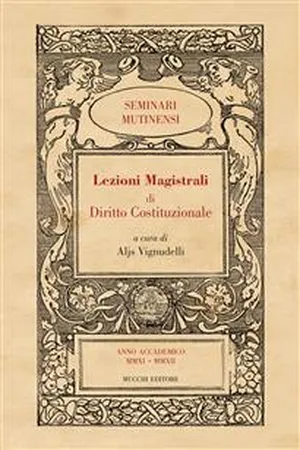1. I plurimi impatti della Costituzione sulla pubblica amministrazione
nota l’affermazione (risalente a Otto Mayer) per cui le Costituzioni passano, ma le pubbliche amministrazioni restano e con esse il diritto che le regola. Tale rilievo era da ritenersi condivisibile al tempo in cui le Costituzioni nulla stabilivano con riguardo alla pubblica amministrazione, dato che si limitavano a dettare regole afferenti ai soli vertici del potere esecutivo. Ad esempio la Costituzione USA stabilisce che del potere esecutivo è investito il Presidente (art. II, Sez. 2), di cui si determinano le procedure di elezione, le funzioni, le modalità di rimozione, la indennità di carica. Ma nulla si dispone in merito alle caratteristiche della organizzazione amministrativa e tantomeno ai principi di svolgimento della relativa attività. D’altra parte devesi ricordare che nel costituzionalismo rivoluzionario si guardava all’amministrazione con diffidenza: la Rivoluzione aveva dietro di sé una fortissima spinta verso la liberazione da ogni potere non rappresentativo, e appunto l’amministrazione e la sua attività potevano costituire un vulnus al primato della legge generale ed astratta. È significativo il silenzio sull’amministrazione anche nelle Costituzioni napoleoniche malgrado, a livello di legislazione ordinaria, si fosse dato luogo ad un profondo rinnovamento. Non dissimile la disciplina nello Statuto Albertino e nelle altre Costituzioni del XIX secolo: esse infatti si limitavano a definire i “rami alti” dello Stato.
Da quando invece le Costituzioni – antesignana quella di Weimar – dedicano articoli e articoli alla pubblica amministrazione, questa non è più impermeabile alle dinamiche costituzionali: anche se – e ciò costituisce una conferma indiretta della validità originaria della massima di esperienza da cui siamo partiti – è indubbio che l’amministrazione ha sempre ontologicamente un assetto consolidato di tradizioni, prassi, modi di agire, che fa da barriera alle innovazioni costituzionali, di modo che lo spiegarsi delle innovazioni costituzionali di necessità ha carattere graduale. Con la conseguenza che l’analisi delle disposizioni della nostra Costituzione in materia di pubblica amministrazione si traduce anche nel ripercorrere il lungo e laborioso iter di attuazione delle stesse, onde descrivere sia le fasi attraversate per il loro disvelarsi, sia la evoluzione interpretativa (derivante anche dall’influenza dei Trattati comunitari), che ne fa emergere di continuo nuove potenzialità, nuovi contorni, nuovi profili.
La Costituzione italiana dedica espressamente una sezione, composta di due articoli (97 e 98), a “La pubblica amministrazione”. Ma le disposizioni costituzionali che la riguardano sono ben più numerose: così l’art. 5, che pone il principio della promozione e del riconoscimento delle autonomie locali e del decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato; l’art. 28, relativo alla responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato, nonché dello Stato stesso, gli artt. 51 e 53, sull’accesso ai pubblici uffici e sull’esercizio delle funzioni pubbliche, l’art. 95, sui rapporti tra Governo e amministrazione, i vari precetti sulla tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione (artt. 24, 100, 103, 113), oltre che tutto il titolo V e, in particolare, l’art. 118 relativo alla attribuzione delle funzioni amministrative. Non solo: come ebbe a rilevare Carlo Esposito, pressoché tutta la Costituzione è intrisa di principi che chiamano in causa la pubblica amministrazione. Difatti il dovere di solidarietà (art. 2), il diritto al lavoro (art. 4), la promozione e lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (art. 9), il diritto alla salute (art. 32), il diritto all’istruzione (art. 34), i vari servizi sociali (es.: art. 31, comma 2, art. 35, comma 2, art. 38), i controlli sull’attività economica pubblica e privata (art. 41), la regolazione della proprietà privata (art. 42) etc., hanno tutti come riferimento la pubblica amministrazione, deputata a curare e rendere effettive, nel quadro delle indicazioni date dalla legge, le finalità e le garanzie poste dalla Costituzione.
2. Nozione di pubblica amministrazione
Prima di procedere oltre, ci si deve chiedere cosa si intende per pubblica amministrazione, di cui esiste una definizione legislativa (v. art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), ma anche una nozione che possiamo qualificare “esistenziale”, tenuta presente dal Costituente. La prima definizione però non è esaustiva, e comunque entrambe sono sottoposte a revisione a seguito di indicazioni di provenienza comunitaria e del diffondersi delle c.d. privatizzazioni formali (enti pubblici trasformati per legge in società di capitali o in fondazioni). Un dato di riferimento fondamentale viene fornito dalla stessa Costituzione, laddove inserendo la pubblica amministrazione nel titolo dedicato a “Il Governo”, fa sì che questa sia identificabile come il complesso di uffici “serventi” il Governo. Questa definizione è suscettibile di ricomprendere i dicasteri (termine impiegato dall’art. 95, comma 2 Cost.: per molti è sinonimo di ministero ma in realtà è idoneo a comprendere sia l’organizzazione ministeriale centrale che quella periferica) e gli enti pubblici sottoposti a vigilanza o indirizzo governativo: in altre parole ciò che la stessa Costituzione (v. art. 117, comma 2, lett. g) definisce Stato ed enti pubblici nazionali. Al che si devono aggiungere Regioni ed enti locali riconosciuti espressamente dall’art. 114 Cost., e con essi tutti gli enti soggetti al loro indirizzo. Ma il problema identificativo sta appunto nell’individuare gli enti “serventi” o comunque “indirizzati”. Difatti l’appartenenza alla categoria “enti pubblici” e dunque la riconducibilità alla pubblica amministrazione (da cui derivano rilevantissime conseguenze sul piano del regime giuridico: sotto il profilo della disciplina penale, della giurisdizione, del regime dei beni, del rapporto di lavoro, della disciplina dell’attività, della sottoposizione alle numerose regole di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento di spesa pubblica, etc.), malgrado la loro istituzione debba trovare fondamento nella legge, come si ricava dall’art. 97 Cost., è invero discussa per alcuni enti, per lo più risalenti a prima della Costituzione, soprattutto accademie, fondazioni culturali, istituzioni di assistenza e beneficienza. A tal fine si ricorre ad una summa di indici “rivelatori”, rappresentati dal controllo e dal finanziamento pubblico, dalla presenza di amministratori nominati da enti pubblici, dalle fonti istitutive (autonomia negoziale o potere pubblico), che appunto sono ritenuti suscettibili di disvelare la soggezione all’indirizzo dello Stato o delle Regioni o di altri enti pubblici: inutile dire che si tratta di parametri che non sempre danno esiti univoci, come dimostrano le ricorrenti incertezze giurisprudenziali. Dubbi circa la ascrivibilità o meno al novero delle pubbliche amministrazioni sorgono anche con riguardo a soggetti qualificati per legge società per azioni ma nel contempo istituiti dallo Stato, con unico azionista lo Stato, affidatari della cura di rilevanti interessi pubblici, soggetti a controllo pubblico, etc.: si pensi a Poste Italiane, ANAS (ora Ente nazionale per le strade), RAI o alle fondazioni (come le Casse di previdenza dei professionisti), che, pur avendo natura privata, dispongono di poteri pubblicistici e/o di entrate stabilite per legge. In tutti questi casi si dà valore al dato sostanziale, a meno che non emerga comunque dalla legislazione una ineludibile e chiara attribuzione della natura privata (come – secondo la interpretazione prevalente – è il caso della RAI). Altra terra di confine è data dagli enti pubblici economici, enti che hanno cioè finalità imprenditoriali e agiscono con gli strumenti di diritto privato, per quanto istituiti per legge e soggetti a controllo pubblico e provvisti di dotazioni e di risorse di provenienza pubblica. Tali enti sono in via di recessione, dopo le privatizzazioni degli anni ’90 (enti pubblici economici erano IRI, ENEL, ENI, le Casse di Risparmio, istituti di credito come Monte dei Paschi, San Paolo di Torino, IMI): comunque oggi appartengono pur sempre alla categoria le Aziende sanitarie locali, i Consorzi di sviluppo industriale, i Consorzi di bonifica, l’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile), l’Agenzia del demanio. Essi si caratterizzano per la soggezione ad un regime pubblicistico attenuato (accostabile, sotto certi profili, a quello della società di capitali a prevalente partecipazione pubblica) e che investe la responsabilità, le procedure contrattuali, le procedure selettive del personale, il diritto di accesso, i controlli della Corte dei Conti. Essi comunque sono esclusi esplicitamente dall’elenco di pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 165/2001.
La geografia delle pubbliche amministrazioni si è poi arricchita, a partire dagli anni ’90, delle autorità amministrative indipendenti, che sono indubbiamente amministrazioni (come riconosciuto dalla giurisprudenza e dai vari testi legislativi) ma che si caratterizzano perché non sono soggette a indirizzo e controllo da parte del Governo. Conseguentemente sfuggono alla politica generale del Governo di cui all’art. 95 Cost., il che ha fatto nascere dubbi di costituzionalità perché determinano di rimando una alterazione del canone tipico della responsabilità ministeriale, in quanto disconoscono il rapporto Governo-Parlamento incentrato sulla triade fiducia – responsabilità – indirizzo. Tra le varie risposte, quella più accreditata (oltre a quella della presenza di una disciplina europea che prescrive l’indipendenza di talune amministrazioni rispetto ai governi, come ad esempio è per le banche centrali, ma così non è per tutte le autorità) è nel senso che l’attività delle autorità indipendenti ha carattere esclusivamente tecnico e pertanto si sottrae alla discrezionalità politico-amministrativa che è propria della pubblica amministrazione tradizionale. In altri termini, le decisioni delle autorità indipendenti consistono in mere applicazioni della legge, corroborate da valutazioni di carattere tecnico, così come potrebbe fare un giudice (ed infatti – si osserva – ad es. nel settore della concorrenza ci sono ordinamenti in cui la tutela è affidata in toto al giudice e non ad una autorità indipendente come la nostra Autorità per la concorrenza e per il mercato). L’assenza di responsabilità politica del Governo non è una anomalia, giacché la riserva dell’esecutivo c’è tutte le volte che può esservi una responsabilità politica, nell’attuazione di una legge. Ma laddove si ritenga che non possa esservi una responsabilità politica, ovvero, come spesso si dice con una formula molto usata, ma invero non poco generica, ci si trovi di fronte a “neutralità tecnica”, in quanto non c’è scelta politico-amministrativa, allora finisce la riserva dell’esecutivo e dunque la soggezione al Governo, pur restando pubblica amministrazione.
Da avvertire infine che taluni soggetti, pur privati, a determinati fini e in determinate materie esercitano funzioni amministrative e dunque adottano provvedimenti amministrativi: come tali, sottoposti alla giurisdizione del giudice amministrativo e alle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo (v. art. 29, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241). Casi tipici sono i concessionari di lavori pubblici e gli “organismi di diritto pubblico” (categoria di derivazione comunitaria che comprende anche enti privati) laddove esperiscano procedure contrattuali, ma anche le federazioni sportive con riguardo alle loro determinazioni in materie non riservate agli organi di giustizia sportiva e che sono state ritenute dal legislatore dotate di valenza pubblicistica (v. art. 3, d.l. 19 agosto 2003, n. 220. conv. in l. 17 ottobre 2003, n. 280). Tuttavia tali “segmenti” di pubblicità non sono sufficienti a farli inserire nel novero delle pubbliche amministrazioni.
3. Rapporti tra Governo e amministrazione. La c.d. separazione tra politica e amministrazione
Con l’eccezione delle autorità indipendenti (peraltro fonte – come appena ricordato – di dubbi di costituzionalità) la pubblica amministrazione è al servizio del Governo, di cui è strumento primario di azione, come si ricava dall’art. 95 Cost. e dal fatto che la sua disciplina è innestata nel titolo dedicato a “Il Governo”. Tale rapporto di dipendenza strumentale vale anche per le Regioni, come si ricava dall’art. 121, comma 4 Cost. (e dagli Statuti delle Regioni speciali) e per gli enti locali, dai cui organi politici dipende l’ordinamento degli uffici e dei servizi (v. art. 42, comma 2, lett. a, e art. 43, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U. enti locali).
La strumentalità, che a sua volta discende dal principio di democraticità, in quanto il Governo costituisce un apparato rappresentativo e dunque fornito di legittimazione elettorale (se pur con l’interpositio del Parlamento), pone il problema del rapporto con il principio di imparzialità (art. 97 Cost.) e con la previsione per cui gli impiegati pubblici (e dunque con essi l’amministrazione), operano “al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98 Cost.). Sintomo dei problemi che pone la coabitazione tra politica e amministrazione imparziale è anche l’art. 98, comma 3 Cost., che attribuisce alla legge la possibilità di limitare il diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero, ritenendo che l’appartenenza attiva di queste categorie di pubblici impiegati a movimenti politici organizzati potrebbe compromettere l’espletamento imparziale delle funzioni, stante l’influenza ideologica di interessi estranei a quelli di servire con dedizione esclusiva la Nazione (di tale potenzialità la legge ha fatto applicazione con riguardo al personale civile e militare dell’amministrazione di pubblica sicurezza, ai militari delle forze armate e ai magistrati, tra l’altro ricomprendendo nelle attività vietate la partecipazione a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, sindacati e organizzazioni politiche, nonché lo svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative).
Dalle suddette previsioni costituzionali si è dedotta la necessità di una separazione tra politica e amministrazione. In realtà tale formula è non solo del tutto generica, ma pure non in linea con il dettato costituzionale, ai sensi del quale l’amministrazione è soggetta all’indirizzo politico-amministrativo del Governo. Infatti l’art. 95, comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri; mentre il 3° comma stabilisce la responsabilità individuale dei Ministri per gli atti dei loro dicasteri. Sicché una vera e propria separazione non può esservi. Vi sono invece, anzi vi devono essere, garanzie a difesa della imparzialità. A tal fine, oltre alla presenza del principio di legalità (v. infra § 4), che costituisce il primo e fondante fattore di garanzia, e a tutte le varie declinazioni dei principi di imparzialità e buon andamento (v. infra § 5), che costituiscono diffusi presidi verso le interferenze politiche (intendendo come tali quelle non preordinate alla corretta applicazione della legge, ma ispirate da ragioni di parte), lo strumento di base è dato dalla distinzione dei compiti. La quale è insita nel fatto stesso che la Costituzione assegna al Governo il potere di indirizzo. Cioè la definizione degli obiettivi e dei programmi: una elencazione degli atti di indirizzo è contenuta nell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, peraltro non esaustiva in quanto la funzione di indirizzo politico-amministrativo è un genus del quale fanno parte species non a numero chiuso (Cons. Stato, Ad. plen., 10 giugno 1999, n. 9 che ha precisato come il criterio basato sulla latitudine della discrezionalità normativamente commessa all’organo adottante, se pur valido, vada usato con parsimonia e tenuto a disposizione in sede ermeneutica quale ultima ratio). Di converso attribuisce all’amministrazione tutto ciò che non attiene a tale categoria dell’azione amministrativa, ovvero l’attività di gestione. Ciò sulla base del principio per cui, da un lato, abbiamo la determinazione dell’indirizzo politico amministrativo, per definizione di parte, in quanto espressione della parte di maggioranza (funzione “di governo”) e, dall’altro, abbiamo la sua attuazione che invero deve essere imparziale e al servizio esclusivo della Nazione (funzione di “amministrazione”). Invero a tale distinzione di compiti si è pervenuti solo con la legislazione degli anni ’90, che appunto attribuisce ai dirigenti l’attività gestionale, la quale include il potere di compiere gli atti e di esercitare i poteri di spesa, attribuzione peraltro derogabile solo ad opera di espresse e specifiche disposizioni di legge (v. comma 3): il che costituisce già una apertura verso una incrinatura del principio della distinzione dei compiti e di converso postula l’apprestamento di ulteriori garanzie per assicurare l’imparzialità degli organi politici laddove siano titolari di poteri di gestione, titolarità che peraltro deve essere determinata da ragioni funzionali da scrutinare con rigorosità (esempio di tali controlimiti a difesa della imparzialità è dato dalla complessa procedimentalizzazione e definizione di criteri oggettivi di selezione previsti dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001, con riguardo alla attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale – cioè i più elevati – di competenza – inevitabile – degli organi politici).
Tale distinzione, volta a far sì che la dipendenza funzionale dei dirigenti nei confronti degli organi politici non si tramuti in dipendenza politica (Corte Cost....