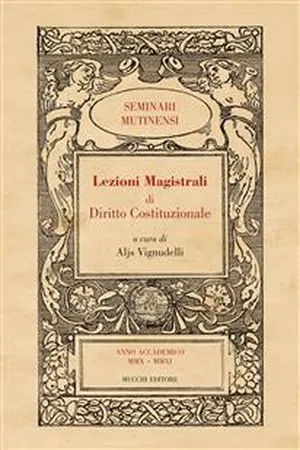Questa lectio si propone due obiettivi: mettere a fuoco i principi normativi diretti a dare ordine a una comunità politica, definendo una tipologia; indicare i criteri preposti a una classificazione dei diversi tipi individuati. Il primo obiettivo richiede un esame dei diversi ordinamenti, individuando i principi organizzativi e di funzionamento di ogni comunità politica. Tali principi caratterizzanti la “forma di stato” (o regime politico) una volta che siano inseriti nella costituzione assumono valore giuridico e in quanto tali hanno natura prescrittiva. Possono identificarsi in tal modo diversi esempi di costituzioni, ognuna portante i propri principi identificanti. I giuristi partono dall’esame di una costituzione ritenuta esemplare per metterne a fuoco gli elementi identificanti, elaborando un tipo che diviene modello e che per definizione si ritiene che possa essere replicato in altre esperienze, sia in linea teorica allo stato puro che nella pratica tramite inevitabili adattamenti e contaminazioni. Il secondo obiettivo comporta una sistematizzazione dei tipi enucleati. In tal caso la dottrina mira a definire criteri normativi in base ai quali stabilire una classificazione con particolare riferimento a quelle che si definiscono “forme di governo”. Ma tali criteri vengono predisposti unicamente in sede dottrinale, anche se a volte certe qualificazioni vengono poi recepite a livello di normativa costituzionale o internazionale. Le considerazioni che si svolgono partono quindi dalla osservazione di dati empirici ma si propongono di individuare prescrizioni costituzionali tese a stabilire principi-valori identificanti un ordinamento e modalità dirette a fare ordine fra le diverse soluzioni normative adottate.
1. Il profilo giuridico del regime politico
Intendiamo partire dalla considerazione della giuridicità dei principi individuanti il regime politico in quanto gli stessi entrano a far parte della costituzione e costituiscono il parametro di riferimento di molteplici aspetti dell’indagine costituzionale interessante lo studio delle comunità politiche. Le costituzioni possono quindi essere utilizzate per una prima individuazione del regime politico.
I principi-valore e le finalità cui deve orientarsi il potere politico caratterizzano tutte le costituzioni a prescindere dalla ideologia che incorporano. In alcuni casi la caratterizzazione ideologica è particolarmente accentuata e ai principi ideologici viene riservato un ampio spazio, come nelle costituzioni rivoluzionarie francesi, in quelle socialiste, in quelle degli stati di recente indipendenza, in quelle islamiche più recenti. La caratterizzazione ideologica è forte nelle costituzioni che segnano il passaggio da un regime a un altro, come nella generalità delle costituzioni dell’est europeo e dell’area ex sovietica, in cui si sottolinea oggi la condivisione dei principi liberali insieme al rigetto dei precedenti principi socialisti. In altri casi il riferimento all’ideologia ufficiale è meno incisivo ma non meno significativo, dovendosi sottolineare come non esistono costituzioni neutre quanto alla scelta di valori caratterizzanti. Dal punto di vista qualitativo la differenza più evidente è fra costituzioni che incorporano scelte di regime che consentono il pluralismo politico e altre che lo negano, seguendo la elementare contrapposizione fra regimi democratici e autocratici. I principi individuanti il regime trovano riscontro anche in trattati internazionali e in tal caso possono svolgere la loro influenza sulle scelte costituzionali. Così, i trattati relativi alla attuale Unione Europea prevedono che l’Unione condivide i principi di regime propri delle costituzioni degli stati membri (art. 2 TUE) e impone agli aspiranti membri come condizione giuridicamente vincolante l’inserimento nelle proprie costituzioni di tali principi (art. 49 TUE). Inoltre, l’eventuale violazione dei principi da parte di uno stato membro può comportare forme giuridiche di sanzione (art. 7 TUE).
Quanto premesso indica che in ogni ordinamento è possibile individuare disposizioni normative di rango costituzionale che fissano in modo prescrittivo i criteri individuanti il rispettivo regime politico o da cui è possibile desumere la prescrittività dei principi relativi al regime.
a) Procedendo con ordine possiamo ricordare come i principi qualificanti si rinvengono in quelle disposizioni che esplicitamente fanno riferimento al regime politico. A volte nei testi costituzionali vengono utilizzati concetti omnicomprensivi quali quello di “forma” riferita all’insieme dell’ordinamento. Si veda, ad esempio, la previsione della “republican form of government” della costituzione degli Stati Uniti d’America (art. IV, sez. 4), della “forma repubblicana” nella costituzione italiana del 1948 (art. 139), della “forme républicaine de gouvernement” della costituzione francese del 1958 (art. 89, comma 5). Più frequente è l’indicazione del richiamo ai “valori superiori” o a “principi fondamentali” che caratterizzano la vita di ogni ordinamento in quanto insieme di credenze, convinzioni, tradizioni che condizionano il modo di concepire la convivenza civile in una data comunità politica. Questi valori dal piano etico passano in quello giuridico nel momento in cui vengono considerati come principi normativi che caratterizzano le regole di organizzazione e comportamento sociale, sia che siano formalmente inseriti nel testo formale della costituzione, negli ordinamenti a costituzione scritta, sia che non lo siano come avviene in ordinamenti con costituzione non formalizzata. Il richiamo ai valori ha assunto estesa rilevanza nelle costituzioni ispirate alla ideologia liberale. La costituzione francese del 1958 (art. 1) afferma i principi d’indivisibilità, laicità, democraticità ed eguaglianza giuridica e sociale come elementi costitutivi della Repubblica: tali principi, uniti ai valori-principi consacrati nella Dichiarazione dei Diritti del 1789 e dal preambolo del 1946, rappresentano quello che il Conseil constitutionnel ha efficacemente definito “bloc de constitutionnalité” (déc. n. 44-71 DC del 16 luglio 1971). I valori liberali, e in particolare il pluralismo politico, trovano ampio richiamo nelle costituzioni degli stati che hanno abbandonato i principi socialisti dopo il superamento della bipolarizzazione est-ovest nel 1989 (cfr. ad es.: Federazione russa, 1993, artt. 2 e 13, comma 3). Negli ordinamenti socialisti erano particolarmente forti i richiami ai valori tipici della dottrina marxista-leninista. Essi sono ancora presenti nella costituzione cinese del 1982 (preambolo e art. 1) e in quella vietnamita del 1992 (art. 4), mitigati dal parziale richiamo ai principi della economia socialista di mercato. Nelle costituzioni islamiche africane e asiatiche i valori dell’Islam sono proclamati come valori costituzionali primari (ad es.: Tunisia, 1959, preambolo; Iran, 1979, art. 4; Comore, 2001, preambolo). Negli atti costituzionali provvisori delle giunte militari iberoamericane è la sicurezza nazionale che appare come valore costituzionale prioritario (Cile, 1973; Brasile, 1964, Argentina, 1976; Ecuador, 1976). L’enunciazione dei valori che è possibile individuare in tutte le costituzioni rappresenta dunque una sorta di manifesto di orientamento politico che deve guidare l’azione degli organi costituzionali e dei soggetti che operano nell’ordinamento.
b) La rilevanza primaria di alcuni principi caratterizzanti il regime politico si desume con sufficiente chiarezza da quelle clausole che sono poste a protezione della costituzione e che impongono divieti di revisione. Tutti i principi e gli istituti protetti dal divieto rientrano nel perimetro degli elementi essenziali che individuano un regime politico. Fra i casi più frequenti vi sono le clausole che vietano la modifica della forma di governo monarchica (cost. Norvegia, 1814, art. 112) o repubblicana (cost. Francia 1946, art. 95 e 1958, art. 89; Italia, 1948, art. 139). Oggetto di tutela specifica possono essere singoli principi ritenuti qualificanti, quali i diritti e le libertà fondamentali, definiti non revisionabili (cost. Namibia, 1990, art. 131) o i principi islamici posti a fondamento del sistema politico, anch’essi non revisionabili (cost. Iran, 1979, art. 177. comma 5). Oggetto di tutela è l’ordinamento federale, vietandosene la modifica (cost. Stati Uniti d’America, 1787, art. V; Legge fondamentale tedesca, 1949, art. 79, comma 3; Brasile, 1999, art. 60, comma 4). Così pure devono ritenersi ispirate dalla esigenza di garantire stabilità e continuità al regime politico le clausole costituzionali che impongono garanzie procedurali quali maggioranze qualificate, reiterazione di votazioni parlamentari, interventi referendari e decorso di intervalli temporali per poter accedere alla revisione.
c) Natura prescrittiva ovunque abbinata alla previsione di rimedi sanzionatori è data dalle clausole di omogeneità delle costituzioni federali. Nell’ordinamento degli Stati Uniti la garanzia della forma repubblicana di governo (republican clause o guarantee clause: art. IV, sez. 4) comporta che gli stati membri debbano darsi un regime ispirato a principi democratici e allo stato di diritto. La costituzione svizzera del 2000 contiene a sua volta clausole di omogeneità: vincolo di democraticità delle costituzioni cantonali che devono essere approvate da parte della Confederazione dopo verifica del rispetto del diritto federale (art. 51), e forme di tutela dell’ordine costituzionale dei cantoni con diritto di intervento in caso di turbativa dell’ordine interno (artt. 52 e 53). Simili vincoli esistono nell’ordinamento tedesco (art. 28, comma 1 GG) e in quello austriaco (artt. 95 e 99 B-VG. In un ordinamento regionale quale è quello italiano la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato come l’omogeneità della forma di governo regionale rispetto alla costituzione dello stato sia imposta dall’obbligo di “armonia con la Costituzione” di cui all’art. 123 cost. (Corte costituzionale, sentenza 106/2002).
d) A tutela del regime politico stanno le clausole di sospensione della costituzione che comportano la contestuale introduzione di regimi di eccezione. Fra le previsioni più note viene generalmente ricordato l’art. 48 della costituzione di Weimar del 1919 che ammetteva tale regime eccezionale. Altra ben conosciuta previsione è l’art. 16 della costituzione francese del 1958 che abilita il presidente della repubblica a prendere le misure di eccezione in caso di minaccia grave alla sicurezza dell’ordinamento.
e) A tutela del regime politico stanno le legislazioni penali. Tali normative hanno sempre mirato a proteggere il regime ma hanno assunto particolare incisività con l’affermarsi dello stato monopartitico nel corso del secolo passato. In questi ordinamenti la tutela del regime politico ha assunto un carattere omogeneo e totale e il potere dello stato-partito diveniva oggetto di tutela nei confronti delle aggressioni esterne e interne. Il modello scelto dallo stato monopartitico ha influenzato ordinamenti di sicura tradizione liberale e la difesa delle libere istituzioni ha condotto in alcuni paesi, quali la Germania, ad affermare gli istituti della democrazia che si difende (artt. 18 e 21 GG).
f) Gli organi di giustizia costituzionale offrono la massima garanzia giuridica dei principi di regime Infatti, secondo una chiara posizione del Tribunale costituzionale spagnolo, la funzione dell’organo di garanzia costituzionale consiste nel “custodire la permanente distinzione tra l’oggettivazione del potere costituente e l’attuazione dei poteri costituiti, i quali mai potranno oltrepassare i limiti e le competenze fissati dal primo” (sentenza 76/1983, punto 4).
L’esame della casistica riportata indica senza possibilità di dubbio come i principi caratterizzanti il regime politico risultino positivizzati nel momento in cui entrano a far parte della costituzione, assumendo quindi inevitabile valore giuridico. Si tratta di principi prescrittivi, assistiti da forme a volte penetranti di tutela e la cui infrazione comporta la attivazione di rimedi giuridici.
2. Comparazione e classificazione dei regimi e delle forme di governo
Per forma di stato (o regime politico) s’intende convenzionalmente il complesso degli elementi che caratterizzano globalmente un ordinamento con particolare riferimento ai principi-valori e alle finalità che sono poste come obiettivi all’azione degli organi costituzionali. Nel suo ambito rientrano i conseguenti criteri relativi alla disciplina dello stato-comunità, al ruolo dell’individuo e dei gruppi e quelli relativi allo stato-apparato e alle sue modalità di intervento. In particolare vi rientrano i principi che caratterizzano il sistema economico e quello politico comprendente quest’ultimo il regime dei partiti politici e la legislazione elettorale, elemento di immediata saldatura con il funzionamento degli organi costituzionali. Per “forma di governo” s’intende il complesso degli strumenti che vengono congegnati per conseguire le finalità statali e quindi quegli elementi che riguardano la titolarità e l’esercizio delle funzioni attribuite agli organi costituzionali. In questa prospettiva ogni forma di governo si inquadra in un più ampio regime politico da cui viene condizionata. Il rapporto fra regime politico e forma di governo mette in evidenza come le strutture di governo disciplinate dalle varie costituzioni, con riferimento alla titolarità e all’esercizio delle funzioni, non possano essere comprese e considerate prescindendo dalla concezione di fondo accolta da ogni ordinamento statale quanto alle basi economiche, sociali e politiche ed ai connessi principi direttivi cui ispirare la propria azione. È questa concezione di fondo che dà una propria “forma” al potere, e quindi allo stato, e che influisce in concreto sull’operare della forma di governo.
Per quanto riguarda le scelte circa l’accentramento o il decentramento del potere statale sembra corretto ricondurre alla forma di governo le scelte sulla separazione/raccordo delle sfere di competenza decisionale dello stato centrale e degli stati membri. Ad un tempo però tali scelte hanno a che fare con i principi che caratterizzano un regime politico in quanto si tratta di scelte che sono influenzate dalla concezione di fondo di un ordinamento. In proposito appare certa la connessione fra principi inspiratori del costituzionalismo, propri del liberalismo politico, e modello organizzativo del potere ripartito fra stato centrale e stati membri comportante una particolare valorizzazione delle autonomie che consente di avvicinare il potere politico al cittadino e ai diversi interessi presenti sul territorio che si è concretizzato nella concezione storica del federalismo.
La dottrina delle forme di stato (regimi...