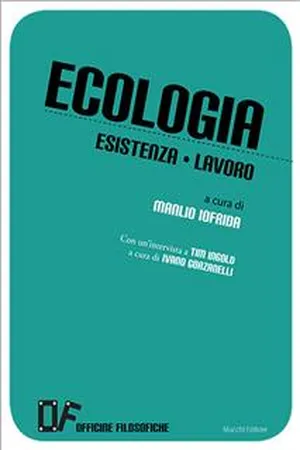Alfonso M. Iacono
Ambivalenza della cooperazione
1. Il ritorno dell’uomo come animale sociale
Dopo anni di elogio dell’individualismo nel bel mezzo della globalizzazione, mentre ritornava in un modo piuttosto primitivo l’abusata metafora della mano invisibile, qualcosa è cambiato. Dopo l’euforia degli anni ’80, un po’ di attenzione si è spostata da una filosofia ingenua (ma estremamente vantaggiosa per alcuni) dell’individuo verso la facoltà collaborativa e cooperativa degli uomini. In un certo senso è tornata, se non proprio al centro, almeno lateralmente, l’immagine aristotelica dell’uomo come zòon politikón, dell’uomo cioè, come ebbero a tradurre Seneca e Tommaso d’Aquino, come animale sociale. L’elemento sociale è tornato a essere considerato come costitutivo della formazione dell’individuo sul piano etico, politico e cognitivo. Recentemente il sociologo Richard Sennett ha pubblicato un libro che significativamente ha per titolo Insieme ed è un’indagine sulla facoltà cooperativa degli uomini esplicitamente influenzata dalle teorie di Amartya Sen e Martha Nussbaum. «Le idee di Amartya Sen e Martha Nussbaum, egli scrive, sono state per me fonte di ispirazione e costituiscono il tema di fondo che orienta questo libro: le capacità di collaborazione delle persone sono di gran lunga maggiori e più complesse di quanto la società non dia loro spazio di esprimere». In sostanza la facoltà cooperativa degli uomini, nel nostro sistema sociale, non riesce ad esprimersi appieno e in particolare non assicura la piena realizzazione delle capacità emotive e cognitive umane. Lo scenario che emerge da questa tesi è dunque in primo luogo che la società non riesce a realizzare la facoltà cooperativa umana e in secondo luogo che tale facoltà si realizza grazie alle capacità emotive e cognitive e viceversa, nel senso che, queste, a loro volta, si realizzano appieno soprattutto nella collaborazione e nella cooperazione.
Lo psicologo Michael Tomasello con il suo gruppo di ricerca ha a sua volta individuato nella facoltà cooperativa l’elemento che caratterizza e distingue i bambini dai cuccioli di scimpanzé. “Mentre le ‘culture’ di altre specie animali si basano quasi esclusivamente sull’imitazione e altri processi di utilizzo e sfruttamento, le culture degli esseri umani si fondano non soltanto sullo sfruttamento ma anche su processi essenzialmente cooperativi. L’Homo sapiens si è adattato, a un livello senza precedenti, ad agire e pensare cooperativamente in gruppi culturali e, di fatto, tutte le più straordinarie conquiste cognitive umane – dalle tecnologie complesse ai simboli linguistici e matematici alle più intricate istituzioni sociali – sono il prodotto non di individui che operano da soli, ma di individui che interagiscono”. Particolare curioso ma significativo di questo ritorno all’uomo sociale e cooperativo è che tanto Sen e Sennett quanto Tomasello e gli altri fanno riferimento allo Adam Smith teorico della simpatia così come si trova nella Teoria dei sentimenti morali piuttosto che allo Adam Smith teorico della mano invisibile, la cui metafora divenne a sua insaputa e inintenzionalmente il paradiso morale dell’individualismo possessivo.
Anche l’importante teoria dei neuroni-specchio ha creato aperture all’uomo sociale, in particolare con Vittorio Gallese, e così pure la teoria del sé e della coscienza di Antonio Damasio.
Strana storia quella dell’uomo come animale sociale. Da quasi due secoli si continua a dichiarare che la figura dell’homo oeconomicus è ormai tramontata, eppure da quasi due secoli essa ritorna sotto varie forme e oscura quella dell’animale sociale. L’homo oeconomicus funziona un po’ come quei partiti di governo che tutti dichiarano di non aver votato o di non voler votare e che poi alla fine prendono alla grande la maggioranza.
L’aristotelico zoon politikon, che Seneca tradusse con “sociale animal” e così pure Tommaso d’Aquino, è stato modernamente riproposto con “animale politico”. Non pochi sono gli autori che hanno usato la figura dello zòon politikon in contrapposizione all’uomo moderno e non certo nei termini di un richiamo nostalgico al mondo greco, bensì nel senso di una comparazione critica interna al mondo moderno e con un ruolo, sotto questo aspetto, che non sembra ingiustificato denominare utopico. In tali contesti, nonostante le precisazioni di Hanna Arendt a proposito dell’accezione della politica e della nozione di zòon politikon nella polis greca, irriducibili sia alla cultura cristiana che a quella moderna, resta il fatto che il tipo moderno di separazione della politica dalle altre sfere della società tende, più nei fatti che non forse nelle teorie, a restringere il campo della politica a un punto tale che finisce col rendere ambigua la traduzione di zòon politikon in “animale politico”, almeno nel ruolo utopico che tale immagine ha assunto in alcuni pensatori moderni. Un ruolo utopico che si è espresso nella chiave della critica proprio delle due sfere per eccellenza separate della società occidentale moderna: l’economia e la politica. Da questo punto di vista, zòon politikon può essere tradotto con “animale sociale”, se a tale denominazione si dà il senso di un rapporto con l’economia che non si riduce al commercio con le cose e di un rapporto con la politica che è partecipazione collettiva e non gestione separata del potere. Per il primo caso, cioè quello della critica dell’economia moderna, l’immagine dell’uomo come “animale sociale” viene evocata da Karl Marx e da Karl Polanyi contro l’immagine dell’homo oeconomicus. Per il secondo caso, quello della critica della politica, essa viene evocata da Moses Finley contro la riduzione della democrazia moderna a strumento dell’oligarchia.
Negli anni ’50 del secolo scorso Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg e Harry W. Pearson affermarono che pochi studiosi ormai accettavano l’immagine del cosiddetto uomo economico primitivo. Le scoperte di Comte, Quetelet, Marx, Maine, Weber, Malinowski, Durkheim e Freud avevano permesso di sviluppare una concezione “ormai divenuta corrente, secondo la quale i processi sociali rappresentano un intreccio di rapporti tra l’uomo, definito come entità biologica, e quella particolare struttura di simboli e di tecniche che è sorta nel corso della sua lotta per l’esistenza”. Eppure, a un secolo dalla critica che Marx fece alle “robinsonate” dell’economia politica classica e a più di trent’anni dal Saggio sul dono di Marcel Mauss, quella affermazione risultava fin troppo ottimistica. Dovevano esserne consapevoli gli stessi autori, se sentirono il bisogno di avvertire che la tradizionale concezione dell’uomo economico, isolato, individualista, dedito al traffico delle merci, dotato di una ragione utilitaria e calcolatrice era ben lungi dall’essere superata: “In molti momenti decisivi tendiamo a ritornare alle vecchie razionalizzazioni dell’uomo inteso come atomo utilitarista. Questa ricaduta risulta particolarmente evidente se guardiamo alle nostre idee sull’economia. Nell’affrontare lo studio dei diversi aspetti dell’economia, gli scienziati continuano a essere perseguitati dall’eredità intellettuale che vede nell’uomo un’entità dotata di una propensione innata a trafficare, barattare e scambiare un oggetto con l’altro. Questa visione permane a dispetto di tutte le proteste contro l’uomo economico e i ricorrenti tentativi di inserire l’economia in un contesto sociale”.
Nel 1972 l’antropologo Marshall Sahlins scrisse: “Endemico alla scienza economica per oltre un secolo, il dibattito formalista-sostantivista sembra tuttavia senza storia, perché nulla di sostanziale sembra essere cambiato dacché Karl Marx ne definì i termini fondamentali in contrapposizione ad Adam Smith. Comunque, l’ultima incarnazione in forma antropologica ha spostato l’accento della discussione. Se inizialmente il problema era l’antropologia ingenua dell’Economia, oggi è l’economia ingenua dell’Antropologia”. Sahlins mostra i limiti di un’“economia ingenua dell’antropologia”, e sposta l’oggetto dell’interesse teorico dallo studio delle attività utili degli individui allo studio del processo vitale, materiale e simbolico della società. Da questo punto di vista, l’economia cessa di essere una categoria comportamentale e diventa, invece, una categoria ...