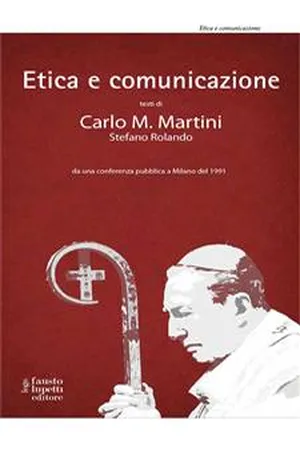![]()
Etica, comunicazione
e responsabilità
di Stefano Rolando
Il mondo dell’informazione e della comunicazione, in ogni latitudine, si interroga sulla crescita dei poteri dei media e sulla crisi di responsabilità dei soggetti professionali che vi operano. Crisi di qualità. Crisi di libertà. Crisi di complessità. Alla ricerca di nuovi equilibri e di soluzioni alle crisi. Un dibattito politico, culturale, giuridico e professionale. Su questa materia ci si sente per lo più dalla parte di chi tenta solo qualche riflessione inquieta e incerta. Nessuna delle analisi che fanno seguito può essere identificata come un modello. Una semplice testimonianza, piuttosto. Schegge di un dibattito in cui siamo più coinvolti che giudici.
Chi comunica oggi
Innanzi tutto c’è da porsi il problema di chi sia il comunicatore oggi, nella società italiana, sia che svolga attività giornalistica o pubblicitaria o di divulgazione educativa. Ovvero quale sia il profilo della sua identità e delle sue motivazioni, che nascono in un complesso intreccio con molti e diversi fattori: la creatività; la riconoscibilità (della firma, del profilo creativo, della capacità di esercitare influenza); il potere; il successo; la pubblica utilità; il personale arricchimento; il proprio apprendimento; l’esercizio di un certo profilo pedagogico; la politicità; il rapporto con lo sviluppo del sistema economico; la gestione di uno strumento di giustizia e di libertà; il concorso ad uno schema di conflittualità e di concorrenza; il concorso ad un’opera di solidarietà.
Una gamma di identificazioni che esprimono valori individuali (anche estremamente individuali) e valori sociali (anche estremamente sociali).
Per essere chiari, anche dal punto di vista di un operatore pubblico, non è per nulla detto che l’etica sia riposta tutta nella sfera sociale di questi fattori che formano in concreto l’identità del comunicatore. Ognuno di questi fattori, quelli sociali e quelli individuali, contiene un suo quoziente etico.
Ognuno di questi fattori contiene un suo quoziente cinico.
Quello che è certo è che contano meno gli equilibri tra appartenenze e valori, come hanno scritto, tra gli altri, Francesco Alberoni e Salvatore Veca in un recente saggio. Ovvero quelle condizioni per cui scelte di campo e di schieramento (destra-sinistra, laici-cattolici, rivoluzionari-conservatori, apocalittici-integrati), in rapporto a culture talvolta della magnificazione o dell’invettiva, attribuivano o requisivano il carattere “etico”. Usiamo qui la parola “etica” che ci obbliga a sostare su una categoria filosofica. Quella parte della filosofia, cioè, che si occupa del problema morale, ossia del comportamento dell’uomo in relazione ai fini, ai mezzi, ai moventi. O, ancora, in una semplificazione originaria, aristotelica, lo studio della condotta umana e i criteri in base a cui si giudicano comportamenti e scelte.
E quindi un’etica che può appartenere a diverse visuali: edonistica, utilitaristica, cristiana, protestante, eccetera. Tema gigantesco, che dai classici greci a Sant’Agostino e a San Tommaso, da Dante a Bacone a Kant, da Vico a Marx, da Nietzsche a quasi tutto il Novecento – fino a John Rawls e alla sua Teoria della giustizia o ai contributi di Habermas – è una dominante del pensiero e della dottrina sul dialogo sociale.
La relazione tra etica e deontologia
Ma nel nostro dibattito forse si può anche accogliere come pertinente lo spazio di relazione tra etica e deontologia, ovvero il problema del modello dei comportamenti che un individuo o un gruppo di individui segue nelle proprie azioni. Se non bastano più le appartenenze e se si deve ragionare sui casi e sulle esperienze, si scopre che il bene e il male non sono dunque facilmente etichettabili pregiudizialmente, così da comporre categorie di comportamenti sempre accettabili o sempre inaccettabili.
Riguardo all’informazione, questo manicheismo si è più volte riproposto negli ultimi decenni, complici mode politiche e il bisogno per molti di vivere piuttosto attraverso l’esistenza di nemici. Così, in questi anni novanta, si possono cominciare a vedere pragmaticamente alcuni dati oggettivi. E soprattutto il fatto di una maggiore centralità delle condizioni individuali (che non vuol dire “solitarie”). Lo stesso D’Alembert, scrivendo del rapporto tra intellettuali e potenti a metà del Settecento, osservava che non deve sorprendere l’attrazione, ma si corre il rischio della “miseria dell’amor proprio” (un valore quanto mai personale).
Innanzi tutto – e ciò vale per giornalisti e per pubblicitari, per professionisti privati e per operatori pubblici – va approfondito il rapporto reale con le ragioni della committenza.
Sia agendo nell’area della comunicazione di mercato, quella che presuppone un prodotto comprato o venduto, dunque soggetto alla legge della domanda e dell’offerta, sia agendo nell’area della comunicazione di pubblico interesse, dove prevale la logica di servizio, è evidente che è comune il problema della ricerca di un punto di equilibrio tra prestazione e deontologia. Anche qui è bene dire a chiare lettere che non pare vero che, di per sé, la collocazione della prestazione nell’area pubblica o comunque di servizio renda acquisito il rispetto deontologico o, in ogni caso, consenta di pensare che in tale prestazione sia radicato un maggior quoziente deontologico rispetto ad un’attività esercitata nelle condizioni proprie del mercato. Il contesto professionale certamente agevola, ma non produce automatismi etici.
Nel mercato vi può essere un’etica degli affari che rispetta diritti e libertà. Nel settore pubblico vi può essere un’etica del servizio che equilibra distorsioni e soddisfa bisogni. Ma in entrambi i campi può anche avvenire esattamente il contrario. Abbiamo visto, in casi concreti riguardanti entrambi i fronti, che ciascun profilo professionale presenta soluzioni deontologicamente articolate, spesso contraddittorie, qualche volta drammaticamente antinomiche. È quasi scontato osservare che il pubblicitario, nel comporre un punto di equilibrio creativo e propositivo, tra condizioni di verità, oppure di lusinga, oppure di proposta onirica, oppure di contraffazione oppure ancora di ingannevolezza, può fare parecchie cose: può scegliere, può favorire o consentire scelte, può subire, può far finta di scegliere. Può anche, come è scritto nella Communio et progressio, “imporsi norme limitative atte ad impedire alla prassi commerciale di ledere la dignità umana e di invilire la società”. E non sempre il pubblicitario riesce a far fronte, eticamente, al rapporto con il prodotto, al rapporto con l’utenza e al rapporto con i valori veicolati. Vale a dire a tutti e tre questi livelli, insieme, con uguale serena coscienza di non essere co-autore di una frode intellettuale.
Il fattore D nel giornalismo
Specularmente, il giornalismo dovrà ricercare la qualità del suo “fattore D”, appunto quello deontologico, nel rapporto, di tutti i giorni, tra informazione e spettacolarizzazione; trattando la singola notizia o il singolo evento e, più in generale nella sua posizione culturale e professionale, si troverà in condizioni di piena libertà, oppure di occasionale o di costante disponibilità alla manipolazione, persino di esposizione alla corruzione. La natura selettiva e competitiva del mercato dei media, naturalmente, incalza questa contraddizione e tiene oggi aperto l’interrogativo etico al di là degli stessi schieramenti politici. Al centro il problema dell’informazione e della risonanza che il cardinale Carlo Maria Martini ha ricordato nella sua lettera pastorale sulla comunicazione. “La comunicazione di massa – scrive l’Arcivescovo di Milano – sembra avere da tempo abdicato alla funzione di collante sociale di prim’ordine per divenire cassa di risonanza, anzi di ampliamento di tutti i conflitti, anche di quelli interpersonali. Tende sempre di più a suscitare sensazioni forti ed eccitanti per vendere meglio e più d’altri le informazioni. E la cosa diventa più preoccupante quando la “cassa di risonanza” appare legata ad interessi forti e occulti”. Non è estraneo l’operatore lobbistico a questo processo. Il “fattore D” gioca non poco nella recente costruzione di immagine di questa professione, di per sé legittima ma, appunto, subordinata a scelte che possono essere orientate al corretto ampliamento della base informativa di giustificate ragioni di parte oppure ad una vera e propria organizzazione della manipolazione dell’opinione pubblica che, in Italia e non solo in Italia, è resa più facile dalla carenza di regole importanti sulla trasparenza, sui sondaggi, sull’attività professionale, eccetera.
Il tema nel sistema pubblico
Fin qui le figure prevalenti nell’area della comunicazione di mercato. Non cambia l’approccio antinomico nell’area di comunicazione pubblica. Il comunicatore pubblico può agire, sui contenuti, con una dimensione di servizio all’opinione pubblica o al servizio piuttosto del solo bisogno di esternazione del suo ente di appartenenza. Rispetto a tali opzioni può promuovere un profilo di iniziativa politicamente neutrale oppure sostanzialmente schierato. In questo tipo di rapporti vale poco (o molto relativamente) il primato, spesso magnificato dai professionisti, del fattore qualitativo, come se una buona realizzazione tecnica potesse cancellare la complessità delle ragioni profonde di un messaggio. Pur riconoscendo al dibattito sulla qualità – anzi, come va di moda dire in quasi tutto l’occidente negli ultimi tempi, sulla “qualità totale” – anche caratteri di sintonia con le ragioni dell’utenza e con il carattere etico delle prestazioni. Vero è, caso mai, che se le ragioni di immagine o di schieramento prevalgono sostanzialmente su quelle di servizio e di contributo all’informazione, non c’è niente di male a considerare quell’operatore all’interno della deontologia della sua istituzione di appartenenza, più che all’interno di un profilo deontologico proprio del sistema dell’informazione. Se, per esempio, il comunicatore delle Forze Armate non riesce a trovare un accettabile equilibrio tra esigenze dell’istituzione e attese reali della gen...