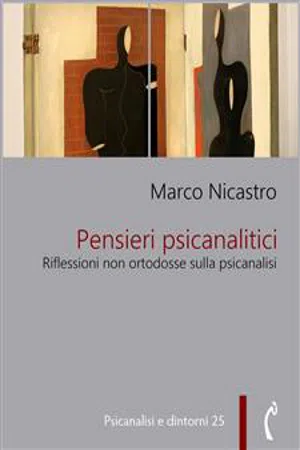![]()
III. IL TRATTAMENTO PSICANALITICO: ASPETTI TECNICI, SCOPI E PROBLEMI SPECIFICI
3.1 Il setting
Il setting in psicoterapia fornisce come dei punti cardinali fissi su quella carta geografica molto ampia e complessa che si può immaginare essere un trattamento psicoterapeutico1.
Dai cambiamenti che i pazienti inducono nel setting all’inizio del percorso di cura il clinico ha la possibilità di intuire e ipotizzare i significati e le configurazioni psichiche interne che il paziente agisce o sente. Quanto accade deve essere registrato dal terapeuta ma non necessariamente discusso e approfondito col paziente, a meno che esso non metta a repentaglio fin dall'inizio la continuità e il senso stesso della psicoterapia.
Sono solito lavorare dopo la seduta a queste turbolenze trasmesse al setting dal paziente, creando ipotesi anche molto diverse tra loro (a volte anche nessuna ipotesi) sulla base della storia del paziente e dei dati controtransferali. È possibile che queste, una volta formulate e definite, cadano nell'oblio per parecchio tempo e che si riattivino in seguito nella mia mente sulla spinta di altri dati immessi nell’interazione dal paziente col suo comportamento e le sue verbalizzazioni. Solo allora quelle ipotesi esplicative potrebbero essere chiarite e discusse con lui, non come idee che piombano dall’alto quindi, ma come concezioni possibili della sua esperienza, che dovranno essere ulteriormente specificate da lui stesso. Forse potrebbero essere paragonate ad una tavola imbandita da cui attingere vivande comuni e sulle cui caratteristiche (sapore, odore, aspetto) ci si scambierà dei pareri, consapevoli che nessuno degli interlocutori possiede la verità oggettiva di quanto accade: il paziente per le sue rimozioni e scissioni, il terapeuta per i suoi umani limiti empatici. Le sedute possono configurarsi così come profondi scambi di opinioni, sulla base però di un sentire autentico e condiviso.
*
L’importante per un terapeuta non è, credo, preoccuparsi di non inquinare il setting – creato grazie al rispetto del principio di astinenza/neutralità – temendo di influenzarlo indebitamente con interventi poco “ortodossi” dal punto di vista di una certa teoria. L’importante per un terapeuta è piuttosto saper seguire il processo di libera associazione del paziente e i propri contemporanei movimenti ideo-affettivi, lo sviluppo delle emozioni nel campo, l’oscillazione della relazione con lui, per elaborare da questi elementi possibili significati. Poiché non importa l’evento/stimolo della seduta da cui ci si trovi a partire, anche una turbolenza venutasi a creare nel setting o nelle libere associazioni del paziente, a causa di un intervento fuori tempo o inadeguato del terapeuta può costituire, invece che un semplice errore, un’altra possibilità di ripartire nel processo analitico, ma solo se il terapeuta continua a mantenere un atteggiamento empatico e riflessivo su quanto accade, evitando di lasciarsi prendere dal timore di commettere “errori” rispetto ad un modello di seduta ideale.
*
Un paziente che mette fin dalla prima seduta in discussione il setting, nel senso di modificarlo secondo le proprie necessità o programmi, non andrebbe assecondato.
L’atteggiamento corretto sarebbe quello di mantenere il setting ben saldo, chiarendo che non si hanno altre possibilità al momento per attuare cambiamenti (di orario, di giorno) oppure nell’esplorare le richieste del paziente e poi decidere se concedere o meno il cambiamento.
I tentativi precoci di rottura del setting sono, nei pazienti adolescenti e in quelli con disturbi del Sé (personalità falso-Sé, narcisistiche e borderline), modalità per vedere se l’oggetto relazionale rimane stabile e differenziato oppure se lo si può manipolare a proprio piacimento. Nel primo caso l’oggetto-terapeuta risulterà differenziabile dalle fantasie del paziente e disponibile in seguito ad essere interiorizzato come qualcosa di differente, con benefici per la definizione del Sé del paziente; nel secondo invece sarà confondibile col Sé del paziente e quindi poco utile per la sua evoluzione.
Un po’ diversa potrà essere la spiegazione di questo comportamento del paziente qualora si presentasse solo nel corso della psicoterapia; allora esso potrebbe configurarsi più che altro come un tentativo inconscio di comunicare qualcosa di sé a un terapeuta già differenziato, allo scopo di permetterne l’individuazione.
*
Inserire degli elementi esterni come parte integrante del setting che si è venuto a stabilire con un certo paziente e, per elementi esterni, intendo dire qualunque aspetto non fosse fin dall’inizio contemplato e stabilito nel patto col paziente, o qualunque elemento che non nasca da un’esigenza interna al trattamento, comporta il rischio di una conclusione prematura dello stesso.
Così, anche elementi comunemente considerati utili per il buon andamento della terapia come l’uso di un farmaco in un momento di crisi acuta del paziente (per lenire non solo le sue emozioni ma anche quelle del clinico), il consiglio di un supervisore circa un certo atteggiamento da tenere con quel paziente, l’esperienza esemplare fatta da un autore noto con analoghe tipologie di pazienti, possono essere alla fine più nocivi che utili in quanto possono alterare un equilibrio sufficientemente buono stabilitosi tra terapeuta e paziente, anche se l’intensità del disagio o certe caratteristiche di personalità potrebbero rendere comprensibile l’utilizzo di quegli espedienti tecnici.
In un rapporto terapeutico la realtà oggettiva non esiste; esiste solo ciò che il terapeuta sente di fare, fatti salvi la consapevolezza dei propri movimenti interni e l’irrinunciabile rispetto per la dignità di chi ha di fronte. Ogni elemento potenzialmente utile per il clinico, estrapolato dall’esperienza altrui, dalla teoria più consolidata o dal semplice buon senso deve essere attentamente vagliato prima di essere introdotto in un trattamento in corso, sulla base dei due criteri summenzionati e del rapporto unico e assolutamente specifico con quel paziente.
*
Un modo per essere veramente neutrali in terapia potrebbe essere quello di mantenere la consapevolezza di non poterlo essere. Se mi impongo di esserlo (ammettendo anche che ciò sia possibile) sto già attuando un atteggiamento silenziosamente di parte, quindi non neutrale.
Se il terapeuta ha ben presente il senso del setting dentro di sé – come spazio “terzo” rispetto alla diade terapeutica, spazio che entrambi i componenti devono rispettare – se lo ha autenticamente interiorizzato può permettersi col paziente di essere meno neutrale di quanto la teoria psicanalitica richiederebbe.
*
Il setting, inteso come insieme di elementi che connotano il contesto spazio-temporale e intrapsichico del terapeuta al lavoro, è un elemento di certo indispensabile per facilitare l’emersione e la comprensione delle dinamiche psichiche nella relazione terapeutica (il setting come costante che permette di scorgere più facilmente delle variabili) e per proteggere sia il clinico che il paziente da un uso indebito della relazione (il setting come fonte di prevedibilità e limite che garantisce sicurezza). Ma se il setting viene inteso anche come insieme di regole e procedure immodificabili cui il paziente deve adeguarsi, pena il non poter procedere col trattamento, si rischia di fare una forzatura indebita che non rispecchia, a mio avviso, il significato più proficuo di questo elemento della terapia. Il setting dovrebbe sì sempre mantenere una funzione fondamentale, quella analitica di favorire la comprensione del paziente ma, per poter arrivare a questo, deve anche creare una situazione confortevole per il paziente. Perciò sostengo che ogni terapeuta dovrebbe creare un setting capace di deformarsi entro certi limiti – che devono però essere ampi con pazienti molto sofferenti e regrediti – e, come un elastico, tornare poi alla posizione iniziale, seguendo le tensioni che si creano all’interno della diade terapeutica.
*
Sulla base della mia formazione e della mia esperienza clinica, mi sento di affermare che il setting vis-à-vis può effettivamente comportare il rischio di influenzare e turbare il paziente nella libertà delle sue affermazioni o nell’esplorazione dei suoi moti interiori attraverso varie interferenze (basti pensare alle semplici reazioni mimiche da parte del terapeuta) che, invece, vengono eliminate nel setting analitico standard grazie all’uso del lettino2.
Se, in ogni caso, una volta imposto il lettino come elemento fondamentale del setting questo possa anche essere accettato dal paziente e permettere alla coppia di lavorare bene, non bisogna tuttavia assolutizzarne il valore tanto da renderlo un requisito necessario per avviare il processo analitico. Infatti, non si può escludere che alcuni terapeuti possano riuscire a mantenere ugualmente un atteggiamento sufficientemente astinente e neutrale anche guardando in faccia i loro pazienti. Certo, mantenere la neutralità terapeutica con un setting vis-à-vis sarà più difficile, in particolare con i pazienti più regrediti che tendono a coinvolgere e turbare maggiormente il terapeuta con le loro fantasie primitive e i loro stati potenti emotivi. Tuttavia, poiché il lettino turberebbe maggiormente questi pazienti, che si sentirebbero privi di un appiglio necessario all’integrità del loro psichismo, cioè il fatto di poter guadare in faccia il terapeuta mantenendo così un contatto con la realtà esterna dinnanzi al potere delle loro fantasie e dei loro bisogni inconsci, causando presto o tardi un’insostenibilità del trattamento, un’interruzione o una manipolazione di esso, il vis-à-vis, risultando decisamente più sostenibile e rassicurante per loro, costituisce l’unico modo per permettere l’avvio di un reale processo esplorativo.
La cosa inversa probabilmente succederebbe coi pazienti meno regrediti, i cosiddetti nevrotici. In questo caso, il terapeuta potrebbe lavorare molto più tranquillamente col vis-à-vis, ma perdere una certa intensità dello scambio emotivo e del lavoro sulle fantasie, a causa del maggiore controllo psichico tipico dei nevrotici; il paziente nevrotico, invece, si troverebbe più a proprio agio nell’esplorare sé stesso senza guardare il terapeuta, come nel setting tradizionale.
È possibile quindi che Freud abbia sentito la necessità di usare in modo permanente il lettino in analisi a causa della pressione esercitata dai suoi conflitti inconsci inesplorati, che si attivarono per la notevole tensione a cui lo sottoposero molti dei suoi pazienti, i quali evidentemente non erano poi così nevrotici come lui pensava che fossero, o come noi potremmo pensare adesso, sulla base delle nostre conoscenze attuali3.
Non deve quindi sfuggire che, se di certo l’intento iniziale di Freud era buono – ridurre il rischio di suggestione per il paziente – si trattava in ogni caso di una reazione a stati di disagio soggettivi da lui esperiti nel vis-à-vis, quindi di un acting-in4 a cui, in seguito, egli trovò anche una giustificazione teorica plausibile.
Quindi un’ultima considerazione che si può fare, a mio avviso, relativamente all’uso del lettino è che esso può depotenziare il coinvolgimento del terapeuta nel rapporto col paziente; può condurre cioè ad una sua maggiore tranquillità interiore e ad una maggiore protezione del suo equilibrio personale, che si suppongono utili nell’attività di riflessione e di interpretazione del materiale proposto dal paziente, ma riducendo, al contempo, l’impatto della relazione sullo psichismo di entrambi. Ciò significa che il lettino stimolerebbe maggiormente i processi cognitivi e razionali piuttosto che quelli affettivo-relazionali, col rischio di rafforzare i processi di intellettualizzazione del paziente e del terapeuta. Se ne può concludere che il lettino, elemento costitutivo essenziale di un setting di cura che ruotava attorno al principio di neutralità/astinenza, sia stato fin dagli albori più uno stratagemma per proteggere il clinico dai turbamenti emotivi dell’analisi che un modo per aiutare maggiormente il percorso di cambiamento e di cura del paziente. Infatti, sono proprio quei turbamenti emotivi interpersonali, tipici di tutti i rapporti tra persone, a garantire umanità, spontaneità e veridicità agli scambi relazionali e a permettere a mio avviso di fare esperienza, in modo molto più diretto a autentico, del mondo interiore del paziente.
Per queste ragioni il lettino rischia di far perdere veridicità e potenza a ciò che il terapeuta esperisce da un punto di vista emotivo nel corso delle sedute, riducendo drasticamente il potere di cambiamento degli scambi comunicativi nel processo analitico.
3.2 Il processo terapeutico
Quando inizio un colloquio di solito non mi chiedo niente, né provo a ricordare alcunché di...