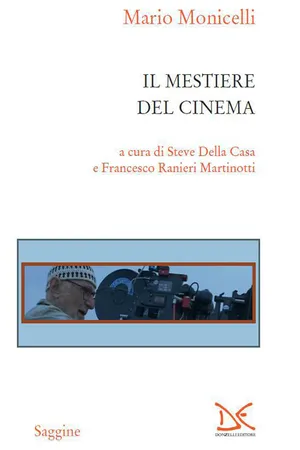![]()
Vademecum di un mestierante
Conversazione con Mario Monicelli
D. Vorremmo capire insieme a te come sono nati o piuttosto come hai lavorato ai tuoi film. Insomma, vorremmo fare una summa dei tuoi «dietro le quinte».
R. Volete farmi parlare di vecchi film?
La nostra intenzione è un’altra. Vorremmo indurti a svelarci l’esistenza – cosa che tu negherai – di un metodo Monicelli. Vale a dire il modo in cui, passo dopo passo, partendo dall’idea originale e poi attraverso tutte le fasi successive, sei solito costruire i tuoi film. Un metodo da artigiano, da mastro carpentiere, che opera sulla base di precise regole non codificate, che sono frutto di un’assoluta conoscenza del mestiere. Partiremmo dalla scrittura, perché tu nasci scrivendo sceneggiature, non è vero?
No. Io nasco facendo l’assistente. Proprio il più miserabile degli assistenti, quello che comincia ad accendere la sigaretta al regista, che lo aiuta a mettersi il paltò. Ho cominciato così, avevo circa diciott’anni, erano gli anni tra il ’32 e il ’34.
page_no="31" Però prima di fare l’assistente avevi firmato un film come regista?
Sì, avevo fatto un film insieme a Mondadori, che era mio cugino: erano dieci minuti a passo ridotto, per i Littoriali della cultura. Il fascismo faceva tutti gli anni d’estate queste gare di cinema, di letteratura, di pittura, di sport nelle quali si cimentavano tutte le varie università sparse in Italia, che allora erano poche. Mondadori, Lattuada e io, come Università di Milano, partecipammo con un filmetto di otto, dieci minuti, che era il limite massimo consentito. Si chiamava Il cuore rivelatore, tratto da una novelletta di Edgar Allan Poe. La cosa era talmente parossistica che fu definita dalla giuria un’opera da paranoici, tanto che ci cassò. Quello è il primo film che facemmo a passo ridotto. Poi da lì, spinti dall’euforia del cinema che allora cominciava, prendemmo un romanzo di Molnár che aveva avuto un grande successo in Italia, I ragazzi della via Paal. Lo avevano già trasposto per il cinema in America e aveva ottenuto un buon successo; noi lo facemmo a passo ridotto, in 16 millimetri. Dico sempre noi, perché eravamo io e mio cugino, insieme e Lattuada che faceva lo scenografo. Perché lui allora era studente di Architettura a Milano. Così costruimmo questo film senza mettere le didascalie, perché allora il 16 millimetri non aveva la colonna sonora, si doveva girare per forza muto con le didascalie. Invece noi ci piccammo di voler raccontare tutto senza didascalie. E facemmo un film abbastanza noioso anche perché la storia si trascinava a lungo. Però, siccome all’epoca c’era una cosa abbastanza intelligente, nonostante che ci fosse il fascismo: a Venezia, oltre alla mostra dei film a passo normale, c’era allegata una mostra a passo ridotto che era un’idea intelligente. Prevedeva una premiazione a parte che, altra idea intelligente, invece di dare degli animali, dei leoni, delle targhe eccetera, dava la possibilità al vincitore di andare a fare l’assistente in un film normale a Cinecittà ed entrare in quel mondo. Noi vincemmo, ed entrambi andammo a fare gli assistenti. Io mi ritrovai con Machatý a Tirrenia, dove c’erano due teatri di posa, e andai lì a fare appunto quello che dicevo: ad accendere le sigarette, a lustrargli le scarpe. Ma era una cosa che mi esaltava anche quella. Sono entrato allora nel cinema e non sono più uscito.
Anche tu eri iscritto ad Architettura?
No, no… a Storia e Filosofia.
Quando tu dici «facemmo un film», avevate un produttore o lo avevate prodotto da soli?
No, era auto-prodotto, perché noi avevamo un amico che si chiamava Civita che era possessore di una bella macchina da presa. Poi noi avevamo dei soldarelli, Mondadori, senza parere, ma se li faceva dare da suo padre. Poi, visto che i ragazzi della via Paal sono ragazzi di ginnasio, liceo, noi siamo andati a pescare gli amici nostri di liceo, di università e abbiamo messo in piedi il film.
E dove avete girato, in strada o in teatro?
No, in strada, nella periferia milanese, perché il romanzo si svolge quasi tutto in un deposito di legna, un cortilone col legname, e lì a Milano ce n’erano due o tre. Girammo gran parte fuori, ma qualche cosa anche in interno, in casa di uno dei nostri amici.
La fotografia la facevi tu?
Il fotografo era Civita, che era un po’ più anziano di noi, aveva cinque o sei anni più di noi. Possedeva questa bella cinepresa del tempo, molto moderna, e così lui fotografava. Poi non era che fosse questo gran direttore della fotografia, ma si divertiva, era molto appassionato, faceva dei piccoli documentari per conto suo. Quindi era uno bravo. Attraverso questo lavoro, lui entrò in confidenza con Mondadori, il quale poi lo salvò dal campo di concentramento, perché era un ebreo e quando ci furono le leggi razziali dovette scappare. Mondadori lo protesse, lo nascose e in seguito lo mandò in Sud America, in Brasile o in Argentina, a tenere in piedi la Mondadori. E fece una bella carriera. Io l’ho rincontrato a New York negli anni settanta e lavorava sempre per la Mondadori con una carica molto importante, ma era sempre appassionato di fotografia e di macchine da presa. Insomma si cominciò così: tra un gruppo di amici con delle forti affinità.
Quindi come premio ricevesti la possibilità di seguire le riprese di un film di Machaty´?
Sì, Machaty´ era venuto dalla Cecoslovacchia con una troupe sua, il montatore, il direttore della luce che poi rimase in Italia e diventò famoso. Machaty´ invece era di passaggio, perché era stato chiamato a Hollywood dalla Metro, in quanto il suo film precedente aveva vinto a Venezia. Era un film abbastanza noioso, visionario, c’erano immagini di foreste, un fiume… e c’era questa bellissima donna che si aggirava nuda nei boschi della Boemia. Questa cosa era talmente audace, talmente rivoluzionaria (anche se le nudità si vedevano poco, quasi per niente) che il film prese un premio. E questa tale, questa giovane attrice cecoslovacca, per la verità, molto bella, era Eddy Lamar, che poi divenne una star a Hollywood. Allora questi qui erano degli sconosciuti, però, dopo il premio a Venezia, il Minculpop ne approfittò per dirgli: «Nel vostro viaggio prima di andare in America fermatevi in Italia, fate un film. Questo a noi serve per sviluppare il cinema italiano…». Allora io fui inviato da questo Machaty´ che a me sembrò subito un matto, perché lo vedevo che urlava, inveiva, faceva spegnere le luci, insomma un comportamento da esaltato, ma pensavo che così si comportasse un grande regista; poi dopo vent’anni capii che invece fiutava la cocaina. In ogni modo io cominciai con lui. E siccome allora il cinema aveva pochi praticanti, appena uno era praticante nessuno lo mollava più. Solo il fatto che io avevo fatto un film normale, subito mi chiamarono altri. E trattandosi di andare in Libia, che era la nostra colonia, a fare un film nel deserto, mi chiesero se volevo partire. Risposi: «Sì, e come no, ci vado!», e andai a fare questo film che era Lo squadrone bianco, uno squadrone di meharisti cioè le truppe che montavano i dromedari in Libia. Il regista era Genina. Insomma andai là, lavorai come assistente e seguitai a fare cinema.
Qual era il titolo del film di Machaty´?
Si chiamava Ballerine, ed era tratto da un romanzo sul corpo di ballo e la scuola di danza delle ballerine della Scala. All’epoca non si scrivevano romanzi per poi farne un film, non ci si pensava proprio. Pensarono che per Machaty´, visto il soggetto, andasse bene, e il Minculpop glielo affidò. Lui lo fece fregandosene. Infatti il film era sgangherato, era brutto e fu un flop.
Ma a parte il ricordo degli atteggiamenti da esaltato di Machaty´, quali furono le tue primissime impressioni nell’arrivare su un set?
Devo dire che i set un po’ li conoscevo già, perché ero viareggino ed ero amico e compagno di scuola di Giacomo Forzano, figlio di Gioacchino Forzano, grande personaggio della cultura e dello spettacolo in Italia.Mussolini lo stimava molto e lo sostenne per mettere in piede dei teatri di posa vicino a Viareggio, tra Livorno e Pisa. Quindi qualche volta mi sono trovato a seguire questo mio compagno, ad andare con lui a vedere in questi teatri quello che succedeva, quindi ne sapevo un po’. La prima volta che entrai in un teatro di posa era proprio lì. Facevo il liceo, era circa il ’29. Entrai al buio e in questo grande ambiente, c’era una luce in fondo, e una donna bellissima sedeva su una poltrona; a poca distanza c’era uno che le parlava mentre le stava facendo un primo piano. Mi ricordo questa immagine, e seppi dopo che l’attrice era Arletty.
E lì prendesti la decisione di fare cinema?
L’avevo già presa prima, nel senso che io da sempre volevo fare quello.
Quando hai iniziato a fare l’assistente, in che cosa precisamente consisteva il tuo lavoro?
Con Machaty´ ero una specie di attrezzista, mentre con Genina dopo un po’ cominciai a fare il ciak. Diciamo che ero un passo avanti. Perché allora era una cosa molto importante battere il ciak, sembrava chissà che. Erano i primi tempi del sonoro e ci voleva uno apposito; così un giorno mi hanno affidato questo misterioso oggetto e sono passato da non fare nulla a fare il «ciacchista», per lungo tempo. Ed era una cosa a suo modo complessa perché non la si conosceva. Così c’era uno che pigliava i quattrini solo per fare questo. Si dovevano mettere i numeri e se non corrispondevano alle pagine del copione il montatore era disperato; qualche volta non andava bene neanche come si diceva il numero, il tono della voce; insomma, per l’epoca era una cosa complessa. Poi accadeva che fra un’inquadratura e l’altra, che a volte ci volevano delle ore e non si faceva niente, io mi dessi da fare per aiutare. Per me durò due o tre anni, mica poco.
E quando ritornasti dalla Libia che cosa accadde?
A Viareggio c’erano alcuni miei amici d’infanzia che avevano capito che il cinema era una cosa che attirava, e siccome loro erano i parenti e i figli di Zacconi, che aveva una compagnia composta dal cugino, dalla moglie, dalla figlia e dai figli, dallo zio, allora i figli dissero: «Facciamo un film anche noi, tanto costa poco siamo, tutti in famiglia, vediamo come si può arrangiare. C’è Monicelli che sa fare il cinema, perché è andato con Genina in Libia». Io dissi: «Facciamo, facciamo…», e girai un film del quale per fortuna si è persa traccia; però era un film con gli attori e tutto quanto, e soprattutto era recitato da Zacconi che allora era un mito della drammaturgia in Italia. Non credo che fu mai distribuito, però a loro portò un po’ di quattrini. Io lo firmai con uno pseudonimo.
page_no="38" E tu sei contento che sia sparito? Forse sei stato tu a distruggerlo…
No, non sono stato io a distruggerlo, perché il film ce lo avevano loro, gli Zacconi, e, non avendo trovato una distribuzione, ci saranno stati al mass...