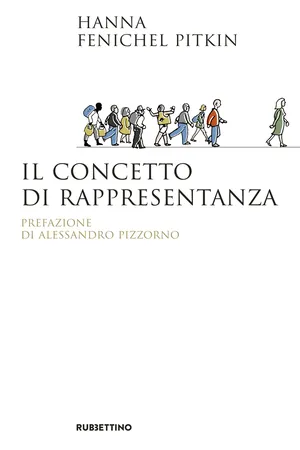![]()
1. Introduzione
Poiché riguarda la rappresentanza, questo libro è dedicato a un’idea, un concetto, una parola. È, soprattutto, un’analisi concettuale, e non uno studio storico dell’evoluzione che ha caratterizzato il governo rappresentativo, o una ricerca empirica sul comportamento dei rappresentanti politici contemporanei oppure sulle aspettative degli elettori nei loro confronti. Eppure, sebbene il libro sia dedicato a una parola, non riguarda semplici parole, né riguarda semplicemente le parole. Per il filosofo sociale, per lo scienziato sociale, le parole non sono «semplici»: sono gli strumenti del suo mestiere e una parte vitale della sua argomentazione. Poiché gli esseri umani non sono semplicemente animali politici, bensì anche animali che usano il linguaggio, il loro comportamento è plasmato dalle loro idee. Ciò che fanno e come lo fanno dipende da come si considerano e da come osservano il loro mondo, e questo a sua volta dipende dai concetti attraverso i quali compiono questa azione. Capire che cosa significa «rappresentanza» e come rappresentare sono questioni intimamente connesse. Ma, oltre a questo, il teorico sociale vede il mondo attraverso una rete di concetti. Le nostre parole definiscono e delimitano il nostro mondo in modi rilevanti, e ciò è particolarmente vero per il mondo delle cose umane e sociali. Perciò, uno zoologo può catturare una specie rara e osservarla semplicemente; ma chi può immortalare un caso di rappresentanza (o di potere, o di interesse)? Anche simili entità possono essere osservate, ma l’osservazione presuppone sempre almeno una concezione rudimentale di ciò che è la rappresentanza (o il potere, o l’interesse), ciò che vale come rappresentanza, dove essa finisca e inizi qualche altro fenomeno. Le questioni relative a cosa sia (o a cosa somigli) la rappresentanza non sono perciò completamente separabili da quella che riguarda il significato di «rappresentanza». Questo libro riflette sulle prime attraverso la seconda.
Tuttavia, difficilmente si suggerirebbe di analizzare tutti i concetti sociali o politici in una monografia. La scelta di destinare tale attenzione specificatamente alla rappresentanza dipende da un lato dall’importanza e onnipresenza del concetto, dall’altro dalla sua complessità e dal relativo ruolo assunto in controversie teoriche di lunga data. Tali complessità rendono un chiarimento necessario e tanto più urgente alla luce dell’importanza del concetto.
Non è difficile sostenere che la rappresentanza sia oggi un concetto significativo e ampiamente utilizzato. Nell’epoca moderna quasi tutti vogliono essere governati da rappresentanti (sebbene non necessariamente da un governo rappresentativo convenzionale); ciascun gruppo politico o causa politica rivendica la rappresentanza; ogni governo afferma di rappresentare. Allo stesso tempo siamo ossessionati dalla differenza tra istituzioni rappresentative autentiche e fasulle, e dalle diverse modalità concorrenti nelle quali la rappresentanza può essere istituzionalizzata. L’intera questione della rappresentanza è stata recentemente riaperta negli Stati Uniti dall’azione della Corte Suprema nel caso Baker vs Carr, e dal tema della ripartizione legislativa dei voti richiamato nella relativa sentenza1.
Senza alcun dubbio, la popolarità contemporanea del concetto in questione dipende in gran parte dal suo legame tanto con l’idea di democrazia, quanto con le idee di libertà e giustizia. Ma, per gran parte della loro storia, sia il concetto sia la pratica della rappresentanza hanno avuto poco a che fare con la democrazia o la libertà. Rappresentanza non significa necessariamente governo rappresentativo. Un re può rappresentare una Nazione, così come può farlo un ambasciatore. Qualunque pubblico ufficiale può, talvolta, rappresentare lo Stato. Così, le istituzioni e le pratiche che incarnano in qualche modo la rappresentanza sono necessarie in ogni società complessa e articolata senza avere necessariamente a che fare con l’autogoverno popolare.
Il concetto di rappresentanza, in particolare tra esseri umani, è essenzialmente un concetto moderno. Gli antichi Greci non avevano un termine corrispondente, anche se eleggevano alcuni ufficiali e, a volte, inviavano ambasciatori – attività che, noi potremmo dire, coinvolgono la rappresentanza2. I Romani possedevano il termine repraesentare, dal quale per mezzo del francese antico deriva il nostro «rappresentanza», ma lo utilizzavano per intendere letteralmente l’atto di rendere presente qualcosa, altrimenti assente, o l’incarnazione di un concetto astratto in un oggetto (per esempio, la personificazione del coraggio in un volto umano o nel pezzo di una scultura). Non applicavano il termine agli uomini che agiscono per conto di altri, o alle istituzioni politiche. Utilizzi di questo tipo cominciarono a emergere nel latino del XIII e XIV secolo, in inglese anche più tardi, dal momento in cui gli individui inviati a partecipare ai consigli ecclesiastici o alle sedute del Parlamento furono gradualmente definiti rappresentanti3. Inizialmente, né il concetto né le istituzioni cui questo era applicato erano associate alle elezioni o alla democrazia, e nemmeno la rappresentanza era considerata materia di diritto.
In Inghilterra, per prendere il classico esempio, la convocazione di cavalieri e borghesi chiamati a incontrare il consiglio del re sembra sia iniziata come una questione di convenienza e necessità per il re stesso4. Lungi dall’essere considerata un privilegio o un diritto, la partecipazione all’attività del Parlamento era un’incombenza noiosa e un dovere svolto con riluttanza5. Solo con il passare del tempo la rappresentanza parlamentare iniziò a essere utilizzata come uno strumento per promuovere interessi locali, come controllo sul potere del re. Fino al XVII secolo il diritto a eleggere un membro del Parlamento poteva essere rivendicato addirittura dal «più povero degli uomini presente in Inghilterra», anche se in tanti ne mettevano comunque in discussione la fondatezza6. Da questa tradizione, a sua volta, è giunto il grido di battaglia della Rivoluzione americana, «la tassazione senza rappresentanza è tirannia»7. La rappresentanza era diventata uno dei sacri e tradizionali «diritti degli inglesi» per i quali valeva la pena lottare; con le Rivoluzioni americana e francese fu trasformata in un «Diritto dell’Uomo»8. Perciò, la rappresentanza è diventata gradualmente rappresentanza popolare, connessa all’idea di autogoverno, al diritto di ogni uomo di prendere parola in merito a ciò che lo riguarda. In questo modo essa si è incarnata nelle nostre istituzioni.
Se consideriamo l’importanza del concetto, e la frequenza con la quale esso è utilizzato da chi scrive di politica, sorprende la scarsità di dibattiti o analisi sul suo significato. Forse esso rientra fra le idee fondamentali date per scontate al punto da sfuggire a un esame minuzioso; o, forse, la sua complessità ha scoraggiato le analisi. Tra i principali teorici politici, Hobbes è il solo a offrire un resoconto sistematico del significato di rappresentanza, articolato in tutti i suoi aspetti; le opinioni di altri teorici devono essere carpite da osservazioni casuali o lette tra le righe. Perfino John Stuart Mill, che dedica un’opera intera al governo rappresentativo, non ritiene comunque necessario spiegare cosa sia o significhi il concetto di rappresentanza9.
Tuttavia, la letteratura è gremita di dibattiti espliciti riguardo il suo significato. Alcuni teorici offrono definizioni che contraddicono direttamente quelle date da altri o (peggio ancora) non le prendono nemmeno in considerazione. Dati i rari tentavi di chiarire queste confuse discrepanze, le discussioni sulla rappresentanza sono segnate da annose e persistenti controversie che sembrano non trovare soluzione. Hobbes, ad esempio, ritiene che ogni governo sia rappresentativo in quanto rappresenta i suoi sudditi: una visione condivisa anche da autori assai più recenti. D’altra parte, in questo secolo ha preso piede la tendenza a denigrare come leggendaria o illusoria la rappresentatività delle cosiddette democrazie indirette. Alcuni studiosi segnalano che tutti i governi usano la propaganda per manipolare i loro sottoposti; che, per contro, perfino i dittatori totalitari hanno (e devono avere) l’appoggio popolare. Questi autori sostengono che nessun governo rappresenti veramente, che un governo veramente rappresentativo non esista. Eppure, tanto gli scienziati politici quanto i profani parlano del governo rappresentativo come distinto da altre forme. Ma allora: i governi sono tutti rappresentativi, oppure lo sono solo alcuni, o non lo è nessuno? È certamente il caso di fare chiarezza in merito.
Un’altra controversia esasperante, e apparentemente senza fine, riguarda la giusta relazione tra il rappresentante e il rappresentato. Hobbes afferma che il rappresentante è libero di fare qualsiasi cosa voglia (almeno per quanto riguarda i suoi rappresentati). La maggioranza dei teorici sostiene che il rappresentante debba fare ciò che è meglio per i soggetti che rappresenta, ovvero ciò che ritiene meglio, utilizzando il proprio giudizio e la propria saggezza, poiché è scelto per prendere decisioni per i (cioè, in vece dei) suoi rappresentati. Ma una posizione di minoranza afferma che il dovere del rappresentante è riflettere accuratamente i desideri e le opinioni dei soggetti che rappresenta. Qualsiasi altra cosa viene da essi considerata come una parodia della vera rappresentanza. La verità potrebbe risiedere da qualche parte nel mezzo, ma, in tal caso, dove si colloca e come lo si stabilisce?
Confrontandosi con queste divergenze, si potrebbe scegliere una particolare posizione e difenderla come corretta, dimenticando il resto; o si potrebbe scartarle tutte e proporne una ancora nuova e migliore. Ma questo non aiuterà a spiegare come abbiano potuto tanti pensatori intelligenti ed esperti sbagliarsi completamente. Soprattutto, non ci aiuterà a capire la plausibilità delle loro opinioni, la ragione per cui siamo in grado di seguire le loro argomentazioni e siamo tentati dalle loro definizioni. Se leggiamo uno qualsiasi di questi autori dimenticando gli altri, siamo inclini ad accettare il suo punto di vista; le difficoltà diventano evidenti solo quando procediamo su argomentazioni diverse, ugualmente plausibili ma incompatibili. Infine, la pretesa di individuare la giusta definizione non spiegherà perché i dibattiti teorici sono intramontabili, né perché essi persistono e si ripetono senza soluzione.
In alternativa, poi, potremmo concludere che la rappresentanza non ha un significato fisso, che i vari teorici sono in disaccordo perché effettivamente parlano di cose differenti. Forse il concetto si è evoluto, ed è per questo che gli autori antecedenti si trovano in disaccordo con quelli successivi. Oppure, forse, se il significato non è invariabile, ogni autore è libero di usare il concetto come preferisce, attribuendogli un significato qualsiasi. Ora, certamente questo è vero in un senso: ogni autore è libero di usare e definire un termine come preferisce. Ma non può utilizzare le parole come vuole e comunque pretendere di comunicare con gli altri, riferendosi alla precisa situazione che ha in mente10. Né il filosofo politico si considera solitamente come colui che ridefinisce le parole o dà loro nuovi significati: piuttosto, ritiene di dover spiegare i significati che esse già hanno. Anche la ridefinizione ha le sue difficoltà. È probabile che sia gli autori sia i lettori dimentichino che un termine è stata ridefinito, e inizino a pensarlo nel suo vecchio significato. E anche una ridefinizione, per essere comprensibile, deve essere espressa con termini che abbiano un significato conosciuto. Un autore potrebbe davvero dover ridefinire un termine se non vuole che esso mantenga il suo significato comune. Ma ciò non rispecchia quanto la maggior parte degli autori ha fatto riguardo alla rappresentanza.
Si potrebbe altrimenti concludere che la difficoltà derivi dalla parola stessa. Alcuni analisti hanno recentemente asserito che «rappresentanza» è un termine vago, «ambiguo», che «potrebbe essere a volte una cosa, altre volte un’altra», che la parola è «utilizzata con svariati significati in connessioni differenti»11. E con questi giudizi essi abbandonano ulteriori sforzi, o si rassegnano alla compilazione di una lista di definizioni offerte da altri12. H.B. Mayo, osservando che «le teorie della rappresentanza rappresentano una sorta di palude», addirittura ci invita semplicemente ad abbandonare il termine in ragione della sua complessità13. Ma in realtà egli stesso ha continuato a usarlo come se ne conoscesse perfettamente il significato. Evidentemente, non è così semplice abbandonare una parte della nostra struttura concettuale.
In filosofia, un recente studio suggerisce che, anche se sappiamo come usare una parola senza esitazione e correttamente, e comprendiamo l’utilizzo che ne fanno gli altri, potremmo non essere comunque in grado di definirla interamente, di esplicitare ciò che conosciamo di essa. Ma, se ciò si applica alla rappresentanza, potremmo comunque non restare intrappolati nel pantano verbale in modo tanto irrimediabile. Poiché la filosofia ha prodotto strumenti e tecniche per affrontare casi di questo tipo – modi di esplicitare la conoscenza che tutti abbiamo delle dinamiche interne e inarticolate della nostra lingua.
A tale scopo ho utilizzato alcuni metodi della scuola della filosofia contemporanea conosciuta variamente come «filosofia del linguaggio ordinario», «filosofia di Oxford», o «analisi linguistica», e in particolare il lavoro di J.L. Austin14. Ciò significa, in primo luogo, che ho prestato attenzione al modo in cui utilizziamo comunemente le parole quando non ci occupiamo di filo...