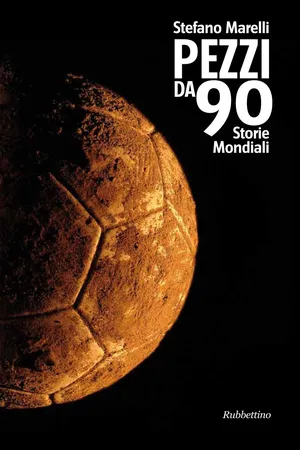![]()
1. Uruguay 1930
«Vi siete trovato bene, Monsieur, nel nostro Paese? È stato un soggiorno gradevole?».
A chiedermelo è il funzionario addetto all’ultimo controllo passaporti, già a bordo. Io sono devastato da stanchezza, tensione, paura. E mezzo congelato. Il tassista mi ha raccolto a bordocampo, sudato, mentre cominciava a nevicare, e mi ha scarrozzato direttamente al porto. Indosso ancora la divisa: calzoni alla zuava, giacchetta a quattro tasche, cravatta. Ho solo cambiato le scarpe, giusto per non attraversare la passerella sui tacchetti da football.
Per rispondere in modo sincero, ci vorrebbero dieci minuti. Troppi. Voglio solo chiudermi in cabina e farmi portare un brodino. Così taglio corto: «Impeccabilmente. Delizioso». Racconterò soltanto a voi come ho trascorso questi ultimi ventisei giorni.
Insieme alla nazionale romena, ai francesi e ai brasiliani, sono sbarcato a Montevideo il 4 luglio. Siamo qui per il primo Campionato del mondo di calcio. Sulla stessa nave ha viaggiato anche la Coppa, chiusa in cassaforte.
Quando inizia il torneo, lo Stadio del Centenario non è ancora completato. Così, i primi incontri si disputano al Parque Central e nel minuscolo campo di Pocitos, dove per l’attesissimo Romania-Perù accorrono ben trecento spettatori.
Assisto ad Argentina-Francia e vedo il mio collega brasiliano Almeida Rego fischiare la fine del match all’84’, mentre il francese Langiller s’invola verso la porta sudamericana. Poteva essere il gol dell’1-1. La delegazione francese minaccia di tornarsene subito a casa. Rego ci ripensa e fa disputare gli ultimi sei minuti, ma ormai la frittata è fatta. Cominciamo bene.
Io e i padroni di casa debuttiamo il 18 luglio, esattamente 100 anni dopo il giuramento sulla prima Costituzione uruguagia. E per l’occasione – magia – il Centenario è finalmente pronto. Francia e Messico hanno già giocato due partite, mentre la Celeste deve ancora esordire: non sembra troppo onesto, ma così stanno le cose. Uruguay-Perù termina 1-0, protocollo rispettato e tutti contenti.
Il giorno seguente mi accomodo in tribuna per Argentina-Messico e scopro che a dirigere l’incontro è Ulises Saucedo, che di mestiere fa il CT della Bolivia, anch’essa impegnata nel Mundial. Roba da matti. Assegna cinque rigori, tre dei quali piuttosto dubbi, e uno solo viene trasformato. Ma il vero tocco di genio è far battere tutti i penalty da almeno quattordici metri, ritenendo troppo ravvicinata la misura regolamentare. Mi chiedo cosa ci faccio in questo angolo di mondo e mi vergogno di avere chiesto un congedo di due mesi al governatore di Anversa, del quale sono capo di gabinetto. Mi consolo pensando che i lettori di «Kicker», testata tedesca per la quale scriverò corrispondenze dalla Coppa del Mondo, potranno farsi grasse risate.
La mia seconda designazione è Argentina-Cile, da sempre uniti da un proverbiale amore fraterno. Oltretutto, il match è decisivo: chi vince va in semifinale. I capoccioni della FIFA mi dicono: abbiamo scelto te perché, col tuo metroenovantatré di altezza, i giocatori forse non oseranno metterti le mani addosso. Un intervento energico di Monti su Torres scatena la bagarre. Calci, pugni e sputi. In campo e sugli spalti. Ma, con l’aiuto della polizia a cavallo, riesco a portare a termine l’incontro senza comminare nemmeno un’espulsione. Vince l’Argentina 3-1.
Torno in campo per la prima semifinale. L’Argentina affronta gli USA, nella cui rosa ci sono un sacco di inglesi. Mi aspetto una gara equilibrata, invece i sudamericani vincono facile. Il terreno è allagato, il pallone non rimbalza. Dopo 10’, un’entrata in scivolata di Monti (ancora lui!) spezza una gamba a Tracey, che resta in campo eroicamente fino al 45’. Gli Stati Uniti giocano in dieci il resto della partita e perdono 6-1. Il medico USA, scontento di una mia decisione, mi scaglia addosso la borsa dei medicinali. Decine di boccette in frantumi, arbitro e giocatori strafatti di cloroformio.
Il mio Mondiale è finito, così me ne vado a Buenos Aires per qualche giorno di vacanza. Una sera, però, ricevo in albergo una telefonata di Jules Rimet, che mi ordina di attraversare di nuovo il Rio de La Plata. La finale è in programma due giorni dopo e nessuno dei miei colleghi vuole dirigerla. Neanche quel mattacchione del CT boliviano. Troppa paura. Uruguay-Argentina sarà una guerra. E dunque può scapparci il morto, pocheballe. Penso «col cavolo», invece rispondo «arrivo, presidente». I francesi non hanno sempre torto, quando dicono che noi belgi siamo coglioni.
La vigilia è un inferno, sotto il mio albergo vedo strani assembramenti. Chiedo e ottengo una scorta armata. Nemmeno le finaliste se la passano bene. I giocatori vengono menati e minacciati di morte dai tifosi avversari. Almeno quindicimila argentini hanno invaso Montevideo, poco importa se non hanno il biglietto.
La mattina del 30 luglio, i cancelli del Centenario aprono alle 8, a mezzogiorno gli spalti sono gremiti e al fischio d’inizio mancano ancora quattro ore. Mi presento sotto la tribuna Colombes e vengo arrestato, roba da chiodi. Chiarita la faccenda, mi spiegano che, prima di me, già tredici furboni si sono spacciati per l’arbitro, giusto per entrare gratis. Raggiungo Rimet e pongo le mie condizioni: voglio una cabina sulla prima nave in partenza dopo la finale e una milionaria assicurazione sulla vita. E faccio bene, perché durante le perquisizioni ai tifosi vengono requisite centinaia di armi da fuoco. Maledico il giorno in cui decisi di infilarmi in bocca quel cavolo di fischietto. Avrei dovuto rinunciare dopo il primo test fallito, quando mi chiesero come avrei dovuto comportarmi se il pallone avesse colpito un aereo che volasse molto basso(!) e non seppi rispondere. Invece diedi l’esame di nuovo e finalmente divenni arbitro, accidenti a me.
La finale comincia male. Anzi, non inizia proprio. Perché gli argentini rifiutano di giocare con un pallone uruguayano. E i padroni di casa non accettano di usarne uno portato dagli ospiti. I novantatremila sugli spalti attaccano una cagnara infernale. Bisogna decidere in fretta. Lo faccio io, alla maniera di Salomone: primo tempo con la palla argentina, ripresa con quella uruguagia (che pesa il doppio).
Al 37’, Guillermo Stabile porta il vantaggio gli ospiti (2-1). Scoppia il pandemonio. Giocatori e dirigenti delle Celeste mi chiudono nella tonnara. Era fuorigioco, pretendono. Potrei annullare, del resto durante il torneo se sono viste di tutti i colori. Ma proprio non ce la faccio. Agisco secondo coscienza e convalido. E così ho la certezza che morirò a Montevideo, a trentanove anni da compiere, sotto un cielo di neve che – mi assicurano – a queste latitudini non s’è mai visto. Per fortuna, però, nella ripresa l’Uruguay ribalta la situazione (4-2) e la mia condanna a morte, per il momento, è rimandata.
Ed ora eccomi qua, nella mia cabina a bordo del Duilio, pronto a salpare per l’Europa. Sento bussare, scusatemi. Sarà il cameriere col mio brodino. Lasciatemelo godere in pace. Ad ogni modo, viste le premesse, scommetto che ‘sta faccenda della Coppa del Mondo avrà vita breve. A nessun pazzo verrà mai in mente di provare a organizzarne un’altra.
Sopravvissuto, John Langenus
![]()
2. Italia 1934
Lo spogliatoio è una bolgia. Grida, spinte, canti. Eia! Eia! Alalà! Dirigenti, stampa e musi mai visti. I compagni, a turno, vengono ad abbracciarmi e mi dicono «Grazie, Luisito». I giornalisti, invece, se ne stanno alla larga. Con loro non parlo mai. E non lo farò nemmeno oggi, poco importa se finalmente ho vinto la Coppa del Mondo. Quattro anni fa, difendendo i colori dell’Argentina, sono stato battuto in finale dall’Uruguay padrone di casa. Per alzare al cielo il trofeo, ho dovuto infilarmi questa maglia azzurra col fascio littorio cucito sul petto.
Sono felice, claro. Ma non è che impazzisca dalla gioia. Avevo immaginato che vincere quella maledetta coppa mi avrebbe fatto perdere la testa. Invece me ne sto qui, seduto su una panchetta, muto e dolorante. Più che altro, mi fa piacere per il nostro maestro Vittorio Pozzo. E per i ragazzi, specie Orsi e Guaita, argentini come me. Dovete capirmi: sono vecchio, ho trentatré anni e ho combattuto mille battaglie. Non vedo l’ora che questo carnevale finisca, per infilarmi sotto la doccia e scappare in albergo.
Poi, però, qualcuno grida «Sua eccellenza! Sua Eccellenza!». Cala il silenzio e tutti si mettono sull’attenti. Entra Mussolini. Doccia di nuovo rimandata. Tendiamo il braccio e gridiamo vivailduce. Monzeglio, che è iscritto al Partito e frequenta Villa Torlonia, strappa il trofeo dalle mani di qualcuno e lo porge al capo del fascismo, inchinandosi oltre la decenza e pronunciando enfatico «È Vostro!». Monzeglio y la concha de su madre. Ma il Duce, magnanimo, appoggia una mano sulla spalla del nostro terzino destro e dichiara «No! È degli italiani!». Applausi. Vivailduce bis. Poi Sua Eccellenza attacca un sermone, ma io non riesco a seguire nemmeno una parola. Penso a ieri sera, quando Mussolini è venuto a parlarci in albergo. «Finora – ci disse – dentro e fuori dal campo di gioco, ognuno ha fatto il proprio dovere affinché il Campionato del Mondo si svolgesse secondo i piani stabiliti».
In effetti, è vergognoso il modo in cui siamo giunti in finale. Per il primo incontro, il sorteggio ci regala gli USA, che ridicolizziamo 7-1. Nei quarti affrontiamo la Spagna: andiamo in svantaggio e raggiungiamo l’1-l solo perché, mentre Ferrari tira in porta, Meazza tiene inchiodato a terra il portiere iberico Zamora. Lo vedono tutti, tranne l’arbitro belga Baert, che ci consente di picchiare come maniscalchi per 90’. Tanto che nella ripetizione, il giorno seguente, la Spagna deve rinunciare a sette titolari, tutti infortunati. Vinciamo 1-0 perché alle Furie rosse viene annullato un gol. In semifinale ci tocca l’Austria di cartavelina Sindelar, reduce da una battaglia feroce contro l’Ungheria. Finisce anche stavolta 1-0 e, por supuesto, sul gol di Guaita il balilla Meazza, che ormai ha affinato la tecnica, se ne sta seduto sulla schiena del guardameta austriaco Platzer.
«Dunque, ragazzi – aggiunse il Duce – vedete di non rovinare tutto proprio sul più bello. Nemmeno immaginate quanto grande sia la responsabilità che avete sulle spalle. Siatene all’altezza. Altrimenti,…». Chiuse passandosi una mano, di taglio, sotto la gola.
Così, mi tocca giocare un’altra finale mondiale a richio della vita, proprio come quattro anni fa a Montevideo, quando la vigilia, insieme a Paternoster, Varallo, Botasso e altri argentini, venimmo tutti minacciati di morte. Non da poveri tifosi anonimi ed esaltati. Ma da gente davvero pericolosa. Se l’Argentina avesse vinto il Mondiale, noi o i nostri familiari l’avremmo pagata cara. Normale, dunque, che scendessimo in campo paralizzati dalla paura. E che il nostro impegno fosse quasi nullo. Solo Peucelle e Stabile, disgraziati, sembravano non capire la gravità della situazione. E infatti, maledetti, segnarono i gol che ci permisero di andare al riposo avanti 2-1. Nell’intervallo, perciò, provvedemmo a spegnere in loro qualsiasi sogno di gloria. A schiaffoni. Nella ripresa, l’Uruguay segnò tre reti e tutto si concluse per il meglio. La pelle era salva. Ma i nostri connazionali non ce la perdonarono mai. Sebbene tutti avessimo giocato per perdere, stampa e tifosi demolirono soprattutto me. Io infatti ero sempre stato il più duro, il più grintoso, l’ultimo a mollare. Mi chiamavano «doble ancho», qualcosa tipo «armadio a due ante». Di quell’Argentina ero divenuto l’emblema. Quella volta, però, tirando indietro la gamba e sbagliando l’impossibile, li avevo delusi. Ma cos’altro avrei potuto fare? Quei pendejos vevano minacciato di morte mia madre.
Da quel giorno, per tutti diventai «el cagon», «el maricon». Così decisi di smettere di giocare. Avevo quasi trent’anni e non ero più disposto a subire offese e minacce di morte. Certo non per duecento dollari al mese, che era lo stipendio che mi passava il San Lorenzo de Almagro. Presi casa a Tigre e misi su una fabbrica di ravioli e tagliatelle. Producevo roba squisita, tanto che in sei mesi ingrassai una ventina di chili. Mi guardavo allo specchio e vedevo mio nonno. Niente a che fare con quello che, a detta di tutti, negli ultimi dieci anni era stato il miglior centromediano al mondo. Ma in Europa, evidentemente, nessuno sapeva dei miei exploit gastronomici. E così, tutte le settimane, ricevevo lettere da Torino. La Juventus voleva ingaggiarmi. E ogni volta ritoccava verso l’alto i termini economici della sua offerta. Risposi in una sola occasione, per ribadire di avere ormai chiuso con il fùtbol.
Finché un giorno si affaccia alla porta del mio pastificio Renato Cesarini, anche lui figlio d’italiani d’Argentina e, da un anno, mezzala della Juve. Edoardo Agnelli lo ha spedito a Buenos Aires per farmi cedere alle sue lusinghe: cinquemila(!) dollari al mese, una casa di proprietà nel centro di Torino e un’automobile a mia scelta. Declino l’offerta, ma invito l’amico a pranzo. Al quarto piatto, Renato mi dice «Che, Luisito, con quei soldi, anche se firmassi per una sola stagione, diventeresti il re dei maccheroni di tutta l’Argentina». Interessante, ma praticamente impossibile: sono un vecchio ciccione, nemmeno riesco più a piegarmi abbastanza per infilarmi scarpe bullonate e parastinchi.
Cesarini, però, è uno tenace e all’ultimo minuto (ovvio) riesce a convincermi. Lo seguo alla Juve. Quando i dirigenti mi presentano alla stampa, peso novantadue chili. I cronisti si sganasciano e scrivono cose terribili sul mio conto. Decido che con loro non parlerò mai più. Los periodistas y las putas que los parieron. Mi infilo tre maglioni, mi alleno sei ore al giorno, sudo da far paura. In venticinque giorni, perdo quattordici chili. Ridivento il miglior centromediano del mondo e sotto l’albero di Natale trovo un passaporto italiano: Vittorio Pozzo dice che la sua Nazionale non può fare a meno di me. Renato, intanto, ci prende gusto a risolvere le situazioni allo scadere. Nasce la famosa zona Cesarini e noi vinciamo tre scudetti di fila.
Poi Mussolini smette di parlare. A noi! Lascia lo spogliatoio, seguito da un codazzo infinito. Restiamo soli, finalmente. Guardiamo la Coppa e ripensiamo alla finale appena conclusa. È con un brivido che ricordiamo il gol di Puc, che a 20’ dal termine ha portato in vantaggio la Cecoslovacchia. Che, in quel momento, eravamo certi di morire. Se la mascherata messa in piedi dal regime si fosse conclusa con un disastro, il Duce avrebbe certo trovato il modo per tener fede alle sue minacce. Poi però quel matto di Orsi riesce a superare Planicka e ci porta ai supplementari. Mumo ci ha salvato la vita e io quasi lo stritolo per la felicità. Il gol che regala il Mondiale al fascismo lo firma Anzulein Schiavio al 95’. Onestamente, non ricordo quanto distante fosse in quel momento Pepin Meazza dal portiere avversario.
Salutando romanamente, Luisito Monti
![]()
3. Francia 1938
Acquartierati gli uomini nelle cuccette, posso finalmente guadagnare il posto telefonico e dettare il mio pezzo per «La Stampa». Conosco bene la Gare de Lyon, è la stazione di noi italiani. Ho ordinato al mio attendente di vigilare che a nessuno venga l’idea di scendere dal convoglio, magari per procurarsi un giornale. Fino al rompete-le-righe, la consegna va rispettata: proibiti alla truppa quotidiani e riviste. Poco importa che l’ultima battaglia sia stata vinta. E che la guerra sia ormai finita. Almeno fino a Modane, i ragazzi sentiranno una sola campana, la mia.
È anche grazie a simili regole che, in un decennio, abbiamo regalato alla patria due Coppe Internazionali, un oro olimpico e due titoli mondiali, compreso quello conquistato oggi allo Stadio di Colombes. Quest’ultima è stata la vittoria più importante, nessun dubbio. Giunge infatti dopo quattro anni in cui per noi, dall’estero, sono piovuti soltanto dileggio, critiche, accuse. Fino a stamani, fuori dai confini del Regno, io venivo bollato come raccomandato, macchietta, servo del fascismo. E lo stesso diranno di me in Italia – lo so bene – il malaugurato giorno che dovesse cadere il regime.
Vero, la conquista della Coppa del Mondo del 1934 non fu limpidissima. Ma esiste forse un esercito che, combattendo in casa, non riesca ad av...