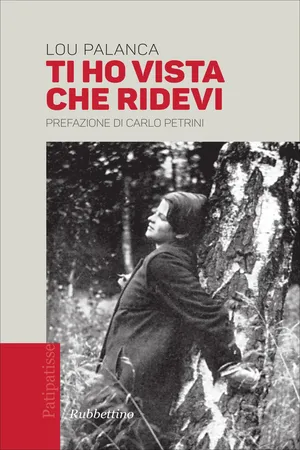![]()
Luigi e Riace
Tutto passa
Riace, settembre 2012
Tutto passa. Passa la mia vita, più che altro. Me ne rendo conto ogni volta che mi avvicino a Riace. Nelle domeniche d’inverno, con la strada desolatamente vuota e la pioggia che rende ancora più tristi i bar e gli stabilimenti balneari che puntellano la statale 106; come nei giorni d’estate, con la coda delle auto immobili, che intasano il percorso, e che mi appare ben più insopportabile del caldo che accompagna il viaggio. Non si registra alcuna differenza tangibile nell’orientamento dei miei pensieri. Questo paese è un pugno di case che resistono contro ogni logica. È un pugno di uomini e di donne che si ostinano a credere che non sia ancora finita. La loro storia, la loro comunità, la loro civiltà non rientrano in nessun asse strategico internazionale, non compaiono in nessun report del fondo monetario e rappresentano poco più di una nota a piè di pagina nei mille piani strutturali della Regione Calabria. Eppure Riace esiste ancora. E io ci vengo sempre di meno, ma ancora ci vengo.
Riace continua ad essere molto diversa da Catanzaro. Ma quando ci crescevo dentro, la città era proprio un altro mondo. Riace e Catanzaro erano separate da un abisso che appariva incolmabile: gli abitanti parlavano dialetti differenti, la città si gonfiava di palazzi e il paese di case vuote, in un luogo cresceva una borghesia impiegatizia che esprimeva classi dirigenti e vaghe prospettive di sviluppo, nell’altro tutto restava identico a se stesso. Catanzaro si apriva al mondo progettando ponti e viadotti e Riace osservava con il solito disincanto lo sviluppo della marina: Catanzaro si voleva città, Riace si voleva sempre e solo Riace. Un altro modo di pensare, un altro modo di intendere la modernità. Quelle che altrove sembravano possibilità qui erano percepite come deviazioni effimere, intralci da rimuovere. Mentre tutto mutava rapidamente, i paesani di queste montagne guardavano il mare immutabile dall’alto, con la convinzione di condividerne l’immortalità.
Nel 1971, quando avevo appena cinque anni e già giocavo a pallone nella piazza con i ragazzi più grandi, mentre i calabresi inseguivano il sogno del turismo e costruivano case lungo tutta la statale, mentre si aprivano lidi e birrerie e si ingrossavano le marine di tutti i paesini del basso Jonio, Riace contava 1.748 abitanti. Dieci anni dopo, quando la Calabria raddoppiava le sue sedi istituzionali, la giunta era a Catanzaro e il consiglio regionale a Reggio, quando i bronzi erano stati finalmente conosciuti dal mondo intero ed esposti a Firenze ma non qui, mentre la ’ndrangheta si lanciava verso il successo planetario e le case a due piani continuavano ad occupare il litorale, Riace era scesa a 1.668 abitanti. Nel 1991, mentre festeggiavo la mia laurea di studente fuori corso a Firenze con pochi amici toscani e molti cognomi pieni di i, j, doppie r e accento sulla o, mentre in Calabria si sequestravano farmacisti, imprenditori e finanche gli otorinolaringoiatri ma mai le abitazioni abusive, mentre l’Italia si trasformava senza gioia da paese di emigranti a terra di immigrazione, Riace aveva 1.694 abitanti.
Nel 2001, io avevo preso casa a Catanzaro e lavoravo con ingenua soddisfazione all’Ansa, il terzo millennio si presentava con l’odore misterioso dell’antrace, la guerra aveva rioccupato la scena e il berlusconismo aveva occupato le anime, la Regione nominava un commissario straordinario per l’ambiente mentre i calabresi modificavano allegramente il corso dei fiumi, scaricavano di tutto nel mare e procedevano coraggiosamente a innalzare nuovi edifici che non sarebbero mai stati completati, e Riace aveva 1.605 abitanti. Variazioni impercettibili, meno giovani e più vecchi, attenuazione del differenziale tra uomini e donne, come registravano le statistiche; meno ambizioni e più isolamento, come lasciavano intendere i volti dei riacesi. Ma nelle giornate calde di luglio le donne continuavano a riposarsi in strada, sulla sedioline di paglia, con le cosce grasse e sudate leggermente aperte, pronte a lamentarsi del caldo e a preparare provviste per i parenti che partivano verso qualche parte del mondo, e nelle giornate uggiose di gennaio come sempre il paese spariva di sera e riappariva per la messa, mentre tutti attendevano che venisse maggio per la festa.
Ci sono ricordi che mi inumidiscono gli occhi. Ci sono tornanti di questa stradina che collega la statale 106 con il mio paese che da sempre percorro in apnea sentimentale. Poi arrivo a casa di mia madre, posteggio l’auto e tutto scompare.
La mia vita, in fondo, è come Riace. Non ho mai conosciuto anni feroci, non ho mai attraversato eventi tumultuosi, non piango per il dolore, casomai per malinconia. Scandisco il mio tempo come un paesino sospeso tra le montagne della parte più sperduta della penisola, il mare brilla lontano esattamente come lontane mi restano le passioni che bruciano l’aria. Non cambio mai, e sì che ci hanno provato a cambiarmi, prima di andare via. Anche questo paese hanno provato a cambiarlo, prima modernizzandolo a colpi di cemento e ora cercando di restituirgli un’anima, con i muli che sostituiscono i mezzi utilizzati per la raccolta differenziata. Hanno rifatto le strade, hanno costruito e asfaltato, ma prima o poi si sono arresi tutti, resta uguale a se stesso.
Io e Riace siamo così, c’è poco da insistere. Mai un’inchiesta, mai un pezzo in cui emergesse con vigore il mio punto di vista, il mio mestiere di giornalista è tutto nella cura che sperpero per rifinire i lanci di agenzia, nel rigore assoluto con cui confeziono le notizie che metto in circolazione. Leggo, memorizzo, recepisco informazioni, elementi, suggestioni. Conosco le ragioni palesi e le motivazioni occulte di ogni cosa che accade in Calabria, ma utilizzo tutti i dati che possiedo solo per evitare gli errori e prevenire le polemiche. Sono un operaio specializzato dell’informazione, probabilmente utile ma certamente invisibile. Non ho mai desiderato sentirmi indispensabile, nel lavoro come nelle relazioni personali.
Nel 2011, Riace aveva 1.793 abitanti. Dopo aver raggiunto un certo grado di notorietà per la sperimentazione di innovative politiche di accoglienza nei confronti degli immigrati che sbarcano sulle coste calabresi, dopo aver rappresentato un modello per le misure di integrazione realizzate nel proprio territorio, dopo che sono stati inaugurati un ristorante etnico e qualche bottega di artigianato africano, dopo che Hassan e Fatima hanno preso posto nel banco della scuola elementare e dopo la celebrazione di qualche centinaio di convegni, il censimento del 2011 registra un insignificante aumento degli abitanti che riporta il paese alle dimensioni del 1971.
Ma nel 1961, Riace aveva più di 2.500 abitanti e da qualche anno le case avevano ripreso a riempirsi di uomini e di bisogni. Da qualche finestra rimasta incautamente socchiusa penetravano addirittura delle speranze. Se è accaduto qualcosa è stato allora. E se non è accaduto, forse allora poteva almeno accadere. In quel decennio in cui Riace, come mille altri centri dell’entroterra calabrese, è stata rimodellata da una nuova ondata migratoria, questa volta tutta protesa verso il Nord Italia. Era la generazione di mia madre. Quella in cui le donne restavano qui e gli uomini andavano via, quella che ha saputo conquistarsi con le unghie un futuro personale ma che ha dovuto rinunciare ad ogni tentazione collettiva. Dopo, è stata solo una opposizione muta al destino, una rincorsa alla salvezza individuale, un investimento sui figli che sarebbero andati via.
Mia madre ci ha cresciuto così, sperando di vederci partire. Sono qui per lei, oggi. Sono qui per un funerale, più precisamente. Il funerale di mia madre.
È morta ieri, si è spenta dopo una lunga malattia dimostrando un tenace attaccamento alla vita, come recita il necrologio che abbiamo pubblicato sulla «Gazzetta del Sud». Le formule di rito, come ogni manifestazione della burocrazia, mi provocano da sempre un mezzo sorriso incontrollabile. Le banalità mi inibiscono la lacrimazione, finanche oggi.
I fratelli Vizzarro
Non ci vado mai ai funerali, figurarsi ai cimiteri. Non è una questione di tristezza né di malinconia, come pure si potrebbe immaginare. Più semplicemente è che non li capisco. Non sono mai riuscito a comprenderne la funzione, ad accettare che i morti vengano ricordati in un luogo preciso, e poi addirittura ciondolando accanto ad altre persone, magari degli sconosciuti. Mi pare che i cimiteri rispondano a un bisogno di ostentazione, di visibilità sociale del dolore e del ricordo, ed io mi sento refrattario alla condivisione pubblica delle emozioni. Sono un navigatore solitario dei sentimenti, un uomo di mezza età continuamente sopraffatto dal pudore. Ai miei morti ci penso quando voglio io e dove voglio io. Da solo, comunque.
Ci sono occasioni in cui non si può scegliere, evidentemente. Avrei fatto volentieri a meno della messa, dello strofinio dei corpi, degli abbracci dei compaesani, dello sforzo di associare i nomi ai volti, della saliva delle vecchie sulle mie guance, avrei fatto volentieri a meno di tutti questi vestiti neri che mi hanno accompagnato fin qui, ma non avevo niente da scegliere. Solo esserci, camminare a fianco di quel che resta della mia famiglia.
Mia madre, Carmela Lucà sposata Vizzarro, era l’ultimo pezzo antico. Morti i nonni, morto zio Salvatore senza aver mai preso moglie, ora restiamo solo noi, i tre fratelli Vizzarro, i ragazzi e una manciata di parenti sparsi per il mondo. A Riace è rimasta mia sorella Rosaria, sposata con Angelo Rechichi, assessore tuttofare della nuova amministrazione comunale, e madre di due figli. Mio fratello Valerio vive a Viterbo, anche lui è sposato e anche lui ha due figli. Io ho bruciato un matrimonio in sei mesi, ho rivenduto la fede bombata d’argento, ho affittato un bilocale con vista mare e ho resistito alla tentazione di riprodurmi.
Una volta che sono qui ne approfitto per salutare mio padre. Non so da quanto tempo manco dalla sua tomba. Non mi stupisco di trovarla in ordine e piena di fiori, so quanto ci tiene mia sorella. La foto di quando era giovane non gli ha mai reso ragione, non restituisce quella serenità che aveva conquistato nei suoi ultimi anni. Magari ci arriverò anche io, un giorno, ma non gli rassomiglio, non ho i suoi tratti ruvidi come non avrò le sue rughe. Non rassomiglio nemmeno ai miei fratelli, peraltro. Più alti, più slanciati, più belli, oserei dire, anche più esuberanti di me, che della pacatezza ho fatto il tratto distintivo del mio carattere, la rivendicazione silenziosa della mia estraneità agli eccessi dei calabresi; quasi che io, il primogenito, sia il risultato di un esperimento non del tutto riuscito.
Riace è molto più pulita e ordinata della maggior parte dei paesini circostanti, ma oggi il cimitero ha addirittura un’aria svizzera. C’è molto silenzio, molta assenza; di carte, di buche, di automobili in doppia fila, di gente, di vita.
Con mia madre ho appena seppellito anche Riace, ora che non c’è più lei sarà molto improbabile che io venga ancora qui. Inviterò mia sorella qualche volta a Catanzaro, magari ci vedremo l’estate in qualche pizzeria affacciata sullo Jonio, ma qui su ci risalirò raramente. Mio padre non si accorgerà di niente, mia madre mi perdonerà come mi ha sempre perdonato tutto. In fondo, essendo nata e vissuta qui, era abituata alla solitudine. Dove c’erano sentieri impervi, vallate, burroni ora ci sono strade e viadotti, le distanze si sono accorciate, i tempi di percorrenza si sono ristretti ma questo posto non è divenuto più vicino a niente. Ancora fuori dal mondo, come prima.
Mentre mi destreggio in questo disordine mentale si avvicina Rosaria, mi sfiora impercettibilmente, chissà se per un istante avrà pensato che stessi pregando.
«Stiamo andando via, vieni» mi dice con dolcezza.
Ma prima che prenda a camminare mi porge una busta chiusa: «Da mamma, per te. Me l’ha data un paio di mesi fa, aggiungendo di consegnartela solo dopo la sua morte».
Prendo la busta, la infilo in una tasca del giacca e inizio a camminare. Rosaria mi chiama, mi guarda con sconcerto. «Non la apri?».
Faccio spallucce, rispondo solo: «No».
«Ma come? Sono due mesi che mi chiedo cosa ti ha scritto mamma. Ho dovuto resistere con tutte le mie forze alla curiosità di aprire la busta, ho provato a chiedere a mamma e niente. Perché una lettera, e perché solo a te? Aprila, dai».
Sorrido appena, riprendo a camminare e le dico: «Andiamo, Rosà. C’è tempo».
Sono un navigatore solitario dei sentimenti, come ho già avuto modo di dire. Un uomo di mezza età che non conosce l’urgenza.
Niente dolce
Locale di merda. Come mille altri ristoranti di questa zona. Detesto i luoghi troppo affollati, credo che non si possa pranzare dignitosamente in mezzo al frastuono da banchetto con duecento invitati, odio la televisione accesa che mi distrae, che soffoca i pensieri e confonde le conversazioni. Sono passati due giorni dal funerale di mamma, due giorni di visite, di vecchie zie che ti ricordi quando venivi a mangiare i torroni alla casa di donna Rosa, eri na creatura bella, bella, tutta uguale a mamma tua, due giorni di scartoffie, carte, appuntamenti. Peggio della burocrazia c’è solo la burocrazia dei morti.
Siamo venuti a pranzare qui, in uno dei locali pretenziosi della marina, dove tutto è più luminoso di come dovrebbe, dove tutto è più abbondante di quello che serve, dove tutto è più congelato e gommoso di quello che potrebbe essere. Locali senza qualità per famiglie senza qualità. In serata riparte Valerio, poi dovrei andare via pure io.
Per arrivare al ristorante siamo passati da Stignano, dove adesso sorgono delle vigne ben curate e dove, mi dicono degli amici ben informati, viene imbottigliato un interessante vino biologico.
Nel luglio del 1986 avevo venti anni, ero appena tornato da Firenze e giravo dappertutto per il solo gusto di stare in movimento. Qualche amico aveva già la macchina, chi era fidanzato si lasciava per una pausa di riflessione lunga tutta l’estate, mamma aveva già cominciato a chiedermi quando avrei ripreso a studiare per l’esame di settembre, qualcuno proponeva una sagra, un concerto, un falò, tutti parlavano di femmine e di calcio, poi in piazza arrivò la notizia che avevano sequestrato Ponziano Salerno, quello che viveva a Catanzaro e aveva le terre a Stignano.
La prima cosa che pensammo fu solo che la nostra estate era già finita. Sarebbero arrivati i posti di blocco, i divieti familiari di uscire dopo cena, i giornalisti a cercare qualcuno che raccontasse una storia aspra o raccapricciante, non necessariamente vera, gli elicotteri a ricordarci che eravamo in guerra, sarebbe arrivata soprattutto la paura di chi aveva i soldi, e poi l’odio di chi si sentiva ingiustamente sospettato, sarebbero tornate le differenze sociali, le voci, le maldicenze, lo sfoggio di omertà.
Solo dopo, qualcuno pensò a quel poveretto, ma nessuno disse mai niente. Non lo conoscevamo, non sapevamo, non era roba nostra. Tornammo semplicemente a casa, rassegnati a un’estate sottotono come un inverno a Riace. Io però volevo sapere, volevo sapere tutto. E cominciai a leggere, a chiedere, a ricostruire i nessi, a riordinare il passato. Mi dedicavo con la medesima intensità all’albero genealogico della famiglia Salerno e alle biografie degli ’ndranghetisti locali. Diventai giornalista durante quel sequestro, almeno credo.
Forse il cibo. Forse il cibo potrebbe essere una mia passione, se trovassi la forza per scrollarmi dalle abitudini degli altri. Che amano questi posti tutti uguali, come i sapori dei piatti, come le facce dei proprietari. Preferisco i locali contenuti, con le portate modeste ma tracciabili, con i clienti silenziosi, con i cibi che hanno sapori riconoscibili, quei posti dove a volte può essere piacevole anche pranzare in solitudine. Quando viaggio porto sempre con me la Guida delle osterie di Slow Food, ricerco con un certo piacere luoghi più simili al mio carattere e al mio gusto, ma in questa zona è un deserto: nessun locale consigliato, nessuna salvezza dalla carne argentina con la rucola sopra.
Insalata di mare, pasta con le vongole e poi vediamo. Frittelle di bianchino certamente no, è vietato e ci sarà pure una ragione. Grigliata di gamberoni, nemmeno: se va bene provengono dall’Oceano Atlantico. Patati e pipi, quasi quasi. Sì, per me una porzione di patate e peperoni. Valerio cambia posto con sua moglie per venirmi vicino e mi chiede della lettera di mamma. Rosaria non sa mica tenerli i segreti, e poi starà morendo di curiosità.
«Non l’ho ancora aperta, con tutte le cose che abbiamo dovuto sbrigare in questi giorni me ne ero quasi dimenticato».
Valerio finge di crederci, mi raccomanda solo di tenerlo informato, poi inizia a raccontare di suo figlio Rocco, che il prossimo anno cambierà scuola, che non ama gli allenamenti in piscina, che ha già la fidanzatina e io mi perdo pian piano tutto il resto. È che non è vero che me ne stavo dimenticando. Anzi, ci ho pensato continuamente a questa lettera di mamma. Ha avuto tutto il tempo per comunicarmi ogni cosa, una lunga malattia per non dimenticare nulla, che bisogno c’era di scrivere? Lei, poi, che di scrivere non è mai stata molto capace. Ricamare, cucire, rammendare, ma scrivere proprio no.
Qua le notizie che arrivano all’improvviso sono sempre brutte notizie. Sequestri, omicidi. Terremoti e frane un tempo, licenziamenti e arresti più recentemente, mai nessuno che scopra un pozzo petrolifero, che vinca un premio letterario nazionale, che brevetti qualcosa di utile. Temo per la mia precarietà, per il mio instabile equilibrio conseguito rinuncia dopo rinuncia.
Quando si passa attraverso le propaggini marine di questi paesi tutto appare precario, in via di ultimazione, tutto ha il sapore dell’approssimazione, a volte per difetto e a volte per eccesso. Eppure gli abitanti di questi luoghi cominciarono a spostarsi vers...