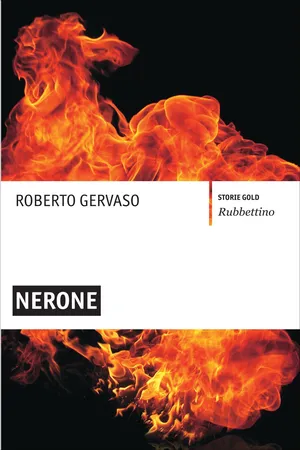eBook - ePub
Nerone
About this book
Nerone, imperatore romano, nato nel 37 e morto nel 68 d.C., fu anche un mostro, ma, per cinque anni, consigliato da Seneca, governò con saggezza. Ebbe la sventura di cadere sotto la penna di Svetonio e di Tacito, che ne hanno tramandato un'immagine perfida e viziosa. Non che Nerone vada assolto dai delitti che commise e dai misfatti che perpetrò. Assassinò la madre, che stava congiurando per assassinare lui, spense col veleno il fratellastro, aspirante alla porpora, fece "suicidare" Seneca, suo ex precettore e ministro. Crimini che non meritano alcuna indulgenza, ma dei quali non furono scevri altri sovrani.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
Topic
StoriaSubtopic
Biografie in ambito storicoCaput mundi
Nel 54 dopo Cristo, quando Nerone salì al trono, Roma era divisa in quattordici quartieri: tredici di qua, uno di là dal Tevere. L’assetto risaliva ad Augusto che, per ogni circoscrizione, aveva nominato un magistrato, il quale durava in carica un anno.
Il cuore della città era il Foro, da cui s’irradiavano le principali arterie, e dove si dava convegno l’establishment. Originariamente deserto e melmoso, lo spiazzo era stato bonificato durante la monarchia, man mano che il colle Palatino, che su di esso incombeva, si stipava di edifici. Il boom demografico esigeva l’espansione dell’Urbe anche in quelle zone malsane e inospitali. Il Foro divenne così il capolinea della Via Sacra e di altre strade, sulle quali s’affacciavano palazzi e templi, come quello di Giano, aperto solo in tempo di guerra. Tagliato longitudinalmente dalla Cloaca Massima, l’immensa fogna capitolina, ospitava botteghe e bottegucce, mescolate a uffici pubblici e monumenti. In seguito, le esigenze amministrative della Repubblica, al cui carro gli eserciti avevano aggiogato popoli di tre continenti, imposero l’evacuazione dei fondaci. Al loro posto spuntarono enti e ministeri, e la burocrazia espropriò il commercio, che si riversò sui quartieri vicini. Il Foro acquistò in monumentalità, mantenendo però la sua pittoresca concitazione: i quiriti seguitarono ad affluirvi a ogni ora del giorno.
Il cuore di questo cuore erano i rostra, con accanto il vero centro dell’Urbe, contrassegnato da un cippo di pietra ricoperto di bronzo dorato, postovi a suo tempo da Augusto. Le vie consolari partivano di qui, e di qui si calcolavano le distanze fra Roma e le città del suo sterminato Commonwealth.
Nel Foro, fino a Cesare, s’erano riunite le assemblee e oratori d’ogni risma e fazione avevano calcato le sue celebri tribune, applauditi o fischiati dai volubili romani. Nel Foro si celebravano i trionfi, si svolgevano le esequie dei cittadini illustri, si compivano i grandi riti. Qui, fra templi e basiliche, sorgeva la Curia, sede del Senato.
Espulsi dal Foro, i commercianti s’attestarono nelle zone circostanti, soprattutto verso il Tevere, la Suburra e l’Argileto, i quartieri più sordidi, popolosi, sguaiati dell’Urbe.
I suoi asfittici e gomitosi chiassuoli ospitavano centinaia di empori: macellai, fruttivendoli, fornai, pasticcieri, merciai, calzolai, parrucchieri, farmacisti, librai. Il caos era indescrivibile e la vigilanza sommaria. Non solo perché a regolare quella variopinta bolgia la polizia cittadina era insufficiente; anche perché v’imperversava la malavita, che della legge s’infischiava, anzi, la dettava.
Fra il Viminale e l’Esquilino s’assiepavano i lupanari della Capitale. Quanti fossero non sappiamo ma, stando a Marziale e Giovenale che, per averli descritti così bene, bene dovevano averli conosciuti, costituivano l’industria più redditizia dell’Urbe, e la meno esposta ai rischi d’una recessione.
Il grande commercio era invece concentrato lungo le rive del Tevere. I barconi e le chiatte che da Ostia, il porto di Roma, lo risalivano, rovesciavano sui piccoli moli, costeggianti il fiume, carichi di grano, olio, vino, spezie, tessuti, manufatti, e infiniti altri prodotti. I generi alimentari venivano trasferiti su rozzi carri al Velabro, il mercato generale, mentre il resto raggiungeva i magazzini dei grossisti, dislocati in vari punti della città.
Lungo le rive del fiume e nella Suburra si trovavano anche case d’abitazione: poche di lusso, la maggior parte senza pretese, né comfort. I rioni residenziali sorgevano infatti altrove, specialmente sul Palatino, la più bella vetrina della Capitale. In epoca repubblicana vi avevano dimorato politici, avvocati, intellettuali alla moda. Qui era nato Augusto, che vi andò a vivere dopo la vittoria di Azio. Coi successori, però, il colle era decaduto e la Roma-bene aveva trasferito suppellettili e lari sul Celio.
Ai tempi di Nerone, i quartieri più esclusivi erano il Viminale e il Quirinale, con la splendida gemma degli orti sallustiani. Ambito anche l’Esquilino, per secoli una delle plaghe più desolate e desolanti della città. Un tempo, infatti, vi si seppellivano i poveri, gli schiavi e i giustiziati, messi a morte nello stesso luogo. Finalmente risanato, Mecenate ne trasformò una grossa fetta in parco, e molti contemporanei v’innalzarono ville, palazzi, templi. Un po’ come il Campo Marzio, definitivamente bonificato da Agrippa nel 36 avanti Cristo.
Qui costruzioni se ne fecero poche, o comunque meno che altrove, ché gli imperatori preferirono destinarlo, sia pur parzialmente, a zona verde, luogo di ricreazione e svago per i giovani (Nerone vi edificò le terme).
Non tutta la città era circondata e protetta da mura, ma solo il nucleo centrale, e anche questo con soluzione di continuità, a causa d’antiche brecce. La periferia n’era tagliata fuori, avendo la vecchia cinta serviana un diametro limitato.
Una difesa naturale era rappresentata dal Tevere, le cui opposte rive comunicavano attraverso una mezza dozzina di ponti. Su quella destra, fra campi, prati e pascoli, si stendevano piccole case coloniche: oasi bucolica alla quale, del fragore metropolitano, non giungeva nemmeno l’eco.
L’architettura dell’Urbe rispecchiava il censo, e lo sottolineava. Ogni ceto ribadiva il proprio rango anche esteriormente. La divisione di classi era dettata dalle funzioni, dalle leggi e dal costume, ma a evidenziarla erano soprattutto le abitazioni.
Le più sontuose, nei quartieri più sofisticati dell’Urbe, ospitavano le famiglie senatorie: un’élite ancora ricca e potente, che godeva d’innumerevoli privilegi, di cui volentieri abusava. Non essendo il laticlavio remunerativo, e dovendo il suo titolare sfoggiare un superbo treno di vita, era giocoforza disponesse di molto denaro (solo chi aveva un’entrata di almeno un milione di sesterzi poteva entrare nella Curia). Somme cospicue il senatore era poi tenuto a investire in demagogia: feste e spettacoli pubblici, distribuzioni di grano, beneficienza. Con la liberalità si guadagnava la popolarità, dispensata dalla plebe ai mecenati più generosi. Chi non pagava un simile scotto s’alienava l’opinione pubblica, diventandone spesso lo zimbello.
Non tutti, però, avevano alle spalle patrimoni familiari cui attingere per far fronte a tanto cospicue spese di rappresentanza. I rentiers erano pochi, e i più s’impinguavano col commercio e l’industria. Ma non direttamente, ché la legge vietava a chi sedeva sui banchi della Curia attività imprenditoriali, delegate a procuratori scelti fra i liberti. Dunque, se non ogni ricco era senatore, ogni senatore – o – quasi era ricco, anche perché non poteva non esserlo.
I padri coscritti, come i cavalieri – alti funzionari, uomini d’affari, professionisti di grido –, vivevano in splendide abitazioni, dallo stile e dalla pianta inconfondibili, e i cui elementi essenziali erano l’atrio e il peristilio. Il primo (vi s’accedeva dal vestibolo, attraverso un piccolo corridoio) era contornato da vari locali. Più che d’una camera, si trattava d’una grande anticamera, con in mezzo il focolare: per molto tempo questo fu il centro della vita domestica. Successivamente, all’atrio venne aggiunto il peristilio, un giardino circondato di portici, sostenuti da colonne, cinto a sua volta da altri locali.
I principali erano il cubicolo, il triclinio, il tablino. Il cubicolo era la camera da letto, su cui gravava un soffitto a volta più basso che nel resto della stanza. Il pavimento era di mosaico, e le pareti ingentilite da pitture. Nel triclinio si mangiava, ma non come mangiamo noi, seduti, bensì sdraiati su un triplice ordine di letti. Il tablino faceva da soggiorno.
Altri ambienti erano la cucina, ampio stanzone con bracieri portatili o fuochi in muratura, un piccolo forno e uno scolatoio, la dispensa, il gabinetto, il bagno.
La casa romana, popolare o di lusso, non aveva aperture esterne. Le finestre guardavano all’interno, illuminando i locali, i quali prendevano aria anche dal soffitto dell’atrio, parzialmente forato, e dal peristilio. L’edificio aveva di solito un unico piano: più che in altezza, si sviluppava in lunghezza e larghezza.
Se i senatori monopolizzavano, o quasi, il vertice della scala sociale, i cavalieri godevano di vaste rendite e molto decoro. I sovrani, per diffidenza verso la Curia, sentimentalmente legata al vecchio regime repubblicano, favorivano i secondi, colmandoli di benefici, sinecure, privilegi.
I cavalieri formavano quella che oggi chiameremmo l’alta borghesia, influente più sul piano economico che su quello politico, solida, attiva, devota.
Vi spiccavano gli avvocati, funzionari civili riveriti e temuti, i quali, dopo aver per secoli esercitato gratis, sotto Claudio avevano finalmente spuntato un onorario, pur se modesto. A differenza dei colleghi d’oggi, assistevano il cliente, non lo rappresentavano: il che nulla toglieva alla serietà del loro impegno.
I dibattimenti richiamavano molta folla e un’arringa riuscita o un’appassionata requisitoria facevano spesso la fortuna di chi le pronunciava, spianandogli la via della carriera politica.
Ogni avvocato aveva il suo stile, che tanto più piaceva, quanto più commuoveva, o infiammava, l’uditorio. Lo stesso collegio giudicante ne era influenzato, come testimoniano molte sentenze. Quando, però, sotto l’Impero, la professione forense divenne venale, e a esercitarla non furono più i Cicerone, i Lelio, i Crasso, ma piccoli legulei, volgari azzeccagarbugli, digiuni di dottrina e avidi di denaro, la categoria entrò in crisi. Per accalappiare i clienti, gli avvocati ricorrevano ai più volgari stratagemmi: un tale, al fine di spillar quattrini a chi sollecitava il suo patrocinio, si fece innalzare nel vestibolo una statua equestre.
Fra i cavalieri c’erano anche i medici, divisi in generici e specialisti, questi più numerosi di quelli. Molti venivano dalla Grecia, dove l’arte d’Esculapio furoreggiava. Alcuni ricevevano a domicilio, altri in ambulatori, altri ancora prestavano servizio presso qualche ricco signore o a palazzo reale (i principi ne avevano uno stuolo).
La preparazione variava dall’uno all’altro e parecchi n’erano completamente digiuni. Scienza e stregoneria si fondevano e confondevano ed era impossibile stabilire dove questa finisse e quella cominciasse. La mancanza di validi ausilii diagnostici, la rozza conoscenza del corpo umano, la grossolanità dei farmaci rendevano problematiche le diagnosi e aleatorie le terapie. L’idea, ad esempio, che il riso scaturisse dalla milza, l’odio sprizzasse dal fiele, l’amore albergasse nel fegato, la superbia nei polmoni, fuorviava le indagini mettendo a repentaglio l’incolumità del paziente.
Il rimedio più in uso era il laserpizio, potente digestivo, servito alla fine dei banchetti. «Lontano progenitore del fernet,» scrive Paoli in Vita romana «sugli animali aveva effetti vari: faceva addormentare le pecore, starnutire le capre, scoppiare i serpenti. Ma all’uomo recava vantaggi infiniti. Nelle convalescenze, nello stato di prostrazione, nelle digestioni difficili, nei disturbi di circolazione o femminili era un tonico insuperabile. Si applicava sulle ferite, sulle piaghe; faceva maturare gli ascessi, rendeva innocuo il veleno dei serpenti e degli scorpioni. Facilitava persino l’estirpazione dei calli. Guariva il mal di gola, l’asma, l’idropisia, l’epilessia, l’itterizia, la pleurite. E anche i dolori d’ogni genere».
Per il mal di denti si consigliava, invece, la polpa di zucca, condita con sale e assenzio, o al succo di senape. I pazzi pare rinsavissero con l’elleboro, mentre per gli epilettici il miglior toccasana era un’amalgama di cocomero e senape.
La medicina e i medici non s’accontentavano di soccorrere i malati. Aiutavano anche i sani, cui l’estetica non stava meno a cuore della salute. Romani e romane all’aspetto esteriore tenevano molto. Le donne impallidivano l’incarnato col cumino, ammorbidivano la pelle col seme di lino, deodoravano le ascelle sorbendo, a digiuno, un beveraggio di radici di scòlimo. Una mistura, debitamente dosata, di sale, miele e orzo manteneva bianchi i denti e alleggeriva l’alito, mentre contro la calvizie ci si cospargeva il cuoio capelluto d’un laido impiastro a base di vino, zafferano, pepe, aceto, laserpizio e sterco di topo.
I quiriti consideravano la chioma il più bell’ornamento, per cui esserne privi, o non esserne sufficientemente forniti, costituiva una autentica iattura. Il vanitosissimo Cesare vi ovviò ricorrendo ad abili riporti e alla corona d’edera, guadagnata con le gloriose vittorie. Caligola, precocemente calvo anche lui, diffidò chiunque dall’affacciarsi alla finestra quando passava, ché dall’alto il suo cranio, devastato dall’alopecia, scapitava in regalità.
Ordine senatorio e ordine equestre, patriziato, cioè, e ricca borghesia professionale, rappresentavano, abbiamo visto, un’élite benestante e ristretta, invidiata da quella borghesia minore che, non disponendo di sufficienti rendite, né del placet imperiale, mai avrebbe potuto aspirare al titolo di cavaliere. A questo ceto, promiscuo e abbastanza intraprendente, assimilabile per certi aspetti alla plebe, appartenevano uomini d’affari, piccoli commercianti, artigiani, professionisti, insegnanti, artisti.
Al di sotto stava il popolo minuto, libero ma diseredato, che a stento sbarcava il lunario, o perché guadagnava poco, o perché non aveva un lavoro fisso (il che, spesso, l’obbligava a viver d’espedienti).
Era la massa più turbolenta dell’Urbe, e la più corriva alla demagogia. Il suo perenne scontento, l’instabilità dei suoi umori e malumori, la violenza delle sue passioni, la precarietà dei suoi entusiasmi, la cupidigia di novità e insieme il timore di cambiamenti la rendevano disponibile a qualsiasi avventura, capace di qualunque eversione. Stivata in squallidi caseggiati o luride baracche, odiava la borghesia più che il patriziato e amava gl’imperatori, soprattutto quelli, come Nerone, che meglio sapevano blandirla. Vivace, corrotta dalla miseria, sempre pronta a menar le mani, dava, più d’ogni altra classe, tono e colore alla città, di cui era l’elemento più pittoresco e riottoso. I principi se la tenevano buona per manovrarla all’occorrenza contro i loro avversari, specialmente il Senato.
In cambio essa non esigeva che pane e giochi, panem et circenses, bastandole sfamarsi e divertirsi, conscia com’era della propria condizione e rassegnata a non mutarla finché un impossibile rivolgimento non avesse scardinato il tradizionale assetto sociale, fondato sulla sopraffazione del più forte sul più debole, del più ricco sul più povero.
Ma c’era chi stava peggio anche della plebe, ed erano gli schiavi.
Quanti fossero è difficile appurarlo, com’è difficile stabilire il numero degli abitanti. Gli storici sono discordi e le loro cifre così lontane che neppure una media è possibile. Beloch parla d’ottocentomila anime, di cui metà schiavi (ma il dato si riferisce al 30 a.C.); Carcopino la porta a un milione; Gibbon l’aumenta a un milione e duecentomila; Marquardt a quasi due milioni e mezzo. Chi ha ragione? Non disponendo di computi ufficiali, non possiamo darla a nessuno. Se è vero, però, che alcuni signori avevano centinaia di schiavi, non è escluso che la popolazione fosse così densa. Quanto ai servi, non dobbiamo solo calcolare quelli nati tali, che già sarebbero molti, ma anche i liberi diventati schiavi: prigionieri di guerra, viaggiatori caduti nelle mani di pirati e briganti e poi venduti, debitori insolventi, trovatelli, cittadini rei di delitti particolarmente gravi.
Gli schiavi venivano esibiti nel Foro, all’aperto o in botteghe specializzate, come oggetti. Nessuno se ne scandalizzava, e nemmeno se ne meravigliava. Bisognerà attendere il cristianesimo perché l’infame tratta cessi o, almeno, si mitighi.
Portavano al collo una targhetta coi dati anagrafici e il curriculum e gremivano un palco girevole, che consentiva ai clienti d’esaminarli e stimarne il valore. Indossavano il proprio abito e non una divisa come, a suo tempo, era stato proposto, poiché il Senato temeva che l’uniforme, rendendoli consapevoli della loro forza numerica, li spingesse alla rivolta. Gli ultimi arrivati – e arrivati da lontano – erano riconoscibili per un piede imbiancato col gesso.
Ce n’erano per tutti i gusti, le borse, le esigenze: biondi e bruni; aitanti e scalcagnati; colti e analfabeti; italiani e stranieri. Alcuni si presentavano come cuochi, altri come scalchi, altri ancora come camerieri, maggiordomi, parrucchieri, coppieri. Numerosi i cantanti, i suonatori, i buffoni, i ballerini, i grammatici, ciascuno col suo prezzo, soggetto alla qualità e all’età. Un artista valeva più d’un valletto, un precettore più d’un parrucchiere. Per un grammatico venne sborsata la bellezza di settecentomila sesterzi. Il costo minimo era di trecento, quello medio di quattromila.
La maggior parte finiva nelle grandi famiglie, nelle dimore senatorie ed equestri, dove se ne contavano a decine, o a centinaia. Anche i meno abbienti possedevano almeno un paio di servi. Il non ricco Orazio, quando sedeva a tavola, aveva intorno tre lacchè. Esserne privi era socialmente squalificante.
Nelle case dei ricchi, dove maggiori erano i bisogni, gli schiavi, divisi in decurie, venivano affidati a sorveglianti, che...
Table of contents
- Nerone
- Colophon
- Indice
- Caput mundi
- Da Augusto a Claudio
- La porpora
- Il matricida
- Il buongoverno
- Ripudio e nozze
- L’incendio
- La congiura pisoniana
- Seneca
- La repressione continua
- L’Impero e le guerre
- La rivolta giudaica
- In tournée
- Qualis artifex pereo
- Solo un mostro?
- Cronologia
- Bibliografia
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn how to download books offline
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 990+ topics, we’ve got you covered! Learn about our mission
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more about Read Aloud
Yes! You can use the Perlego app on both iOS and Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app
Yes, you can access Nerone by Roberto Gervaso in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Storia & Biografie in ambito storico. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.