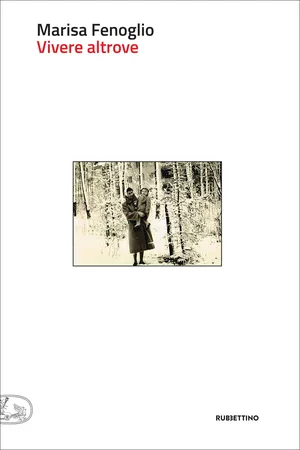![]()
Capitolo XXII
Per stranieri residenti nella Bundes Republik Deutschland, come noi siamo, non era poi così difficile andare «dall’altra parte», cioè nella Deutsche Demokratische Republik.
Al posto di confine – dopo il 1961 tutta la Zonengrenze era cintata da reticolati e fasce minate, e i passaggi, «die Übergänge» erano solo quattro – bastava dichiarare in quale città ci si volesse recare, compreso il giorno di arrivo e di partenza, sottoscrivere un modulo in cui veniva designato l’Interhotel dove pernottare, e anticipare il pagamento in marchi occidentali.
E se si era dichiarato di essere «in transit» per Berlino ovest, destinazione convalidata con un timbro speciale alla frontiera, badare bene a non abbandonare neppure di qualche metro il percorso dell’autostrada.
Era questo un trattamento di favore rispetto a quello riservato dai tedeschi dell’est ai loro compatrioti di un tempo: tutto il maniacale uso del «divieto», comune all’intera anima tedesca, si era concentrato nella sua metà socialista per rendere alla metà capitalista quel confine uno dei più temuti, vigilati e umilianti di tutti i paesi dell’oltre cortina. Due Weltanschauungen si scontravano su quella linea di demarcazione. Se si avevano ancora dei dubbi sul grado di parossismo che può raggiungere una ideologia in mano a un sistema dittatoriale tedesco, bastava un viaggio nella DDR per rendersene conto.
Al posto di blocco – preceduto da un corridoio minato di dieci chilometri, la cosiddetta «zona di nessuno» – i tedeschi occidentali, e noi con loro, dovevano procedere tra file di reticolati, torrette di controllo, polizia in assetto di guerra e cani sguinzagliati. Nell’aria saettavano ordini, le impennate dei monosillabi: Auf! Ab! Ran!, i toni perentori, schioccati, dei verbi all’infinito: Stehenbleiben! Aufmachen! Weiterfahren!, tutta la tragica perversione patita dalla bella lingua tedesca, appena si prostituisca in bocca di uomini in uniforme. A comando bisognava fermarsi, sostare sulla corsia assegnata, lasciarsi perquisire la macchina, a volte anche collaborare attivamente a smontamenti di sue parti – nel caso in cui la polizia della DDR sospettasse il trafugamento di merci o addirittura, nel viaggio di ritorno, di un fuggiasco. Dalle casematte arrivavano musichette e slogan di regime, inneggianti alla sovranità del popolo, alla vittoria finale socialista, incredibilmente simili a quelli di Hitler.
La restituzione del passaporto avveniva alla fine di una lunga trafila di controlli, dopo un percorso di più di un chilometro, (vi giungeva soffiato da una Rohrpost) ed equivaleva a una sentenza di assoluzione. A questo punto si poteva ripartire. Ma non prima di aver ringraziato ossequiosamente, proprio come fa uno che ha avuto tanta paura.
Per me, nuova in Germania, la «divisione» era una realtà incontrovertibile, un dato di fatto. Ogni volta mi chiedevo perché i cittadini dell’Ovest subissero a testa bassa quelle angherie e continuassero ad andarci all’Est, a tutte le feste comandate, e carichi di beni di consumo.
«Siamo gli ultimi tedeschi che soffrono della divisione», mi aveva risposto un conoscente un giorno, mentre caricava la macchina di cose da portare «nach drüben». Aveva appena scollato dalla carrozzeria la striscia «Unteilbares Deutschland!» (Germania indivisibile!), che all’Est gli sarebbe costata la galera.
«Io ci vado perché “di là” sono cresciuto, ho ancora amici e parenti... io sono disposto a tutto per rivederli. Le mie figlie già non ci vengono più, i miei nipoti non ne sapranno più niente, e la separazione sarà definitiva...».
Sul percorso dell’autostrada erano pochi i cartelli – al contrario della supercartellonata BRD – alcuni indecifrabili, ma guai a non vederli, che subito si incappava in una infrazione.
Al viaggiatore poteva capitare per esempio, sostando in un parcheggio, di venirsi a trovare in una toeletta al cui uso non era autorizzato. Si era appena rinchiuso in quel comune ma disinfettatissimo spazio, che la voce imperiosa della custode risuonava davanti alla porta:
«Sind Sie mit dem Bus gekommen?»
«Nein! Siamo arrivati in macchina!».
«Allora si allontani immediatamente! Es ist verboten! Questo servizio è riservato a passeggeri di bus, lei non ha il diritto di usufruirne!».
Il tutto in quella cantilena rude dei paesotti sassoturingici, che trasformava il grottesco in ridicolo.
Il tempo di finire, di uscire con una piccola mancia in mano – poteva prendere il numero di targa e far pagare una multa salata – e via di corsa, di ritorno sull’autostrada.
Io credo che tutte le disgrazie recenti e passate dei tedeschi siano da riportare alla loro capacità di pensare ed eseguire cose come queste. E a non ribellarsi a chi gliele impone. Tutto si può fare con un popolo che permette di separare i gabinetti secondo il mezzo motorizzato scelto da coloro che li vogliono usare.
Quella volta andavamo a Lipsia, alla fiera di primavera.
Ogni ditta dell’Ovest che avesse voluto vendere prodotti negli Intershop della DDR – negozi forniti di prodotti occidentali da pagare in valuta occidentale, e quindi inaccessibili agli autoctoni – doveva tenere uno stand alle due fiere di primavera e di autunno. Così pure la ditta italiana. Sergio aveva alcuni appuntamenti, ed io pensavo di dedicare il pomeriggio alla visita del famoso Georgi Dimitroff Museum, (eroe comunista), nella sede del vecchio Reichsgerichthof.
«Ci rivediamo questa sera in albergo!», ci salutammo.
«Lo sai cosa ti aspetta per cena!» disse Sergio avviandosi: «Cremsuppe di porri, Rostbraten mit Kartoffelklößen! Per dessert: Götterspeise, spumone di un qualche frutto, che invece sarà al solito pura chimica colorata!»
Non sapevo ancora che avrei avuto molto di che raccontargli, quella sera.
E a cena, seduti uno difronte all’altra, incominciai così il mio discorso:
«Poco dopo averti lasciato, – in macchina – con una Ford rossa, targata occidentale davo abbastanza nell’occhio anche in giorni di fiera – arrivai su quella piazza enorme, dominata dalla facciata neoclassica del museo. Prima ancora di aver chiuso la portiera mi sono vista circondata da tre donne che parevano volere qualcosa da me».
«Da te?».
«Sì, proprio da me. Qualche secondo di incertezza. Tuttavia non potevano esserci dubbi, erano in stato di acuta confusione mentale. Ma non così tanto da non potermi dire che cosa volevano: che le riportassi al loro Nervenanstalt nella Karl Marxstätter Strasse. Si erano perse durante la visita al museo, dove le aveva accompagnate la sorvegliante, e ora volevano tornare a casa dalla liebe Frau Doktor, che le aspettava, e certo a quell’ora era già in grande apprensione. “Bitte, ci porti a casa!”
“In un Nervenanstalt? Ma io non posso! Non sono di Leipzig! Rivolgetevi a qualcuno del posto!” dissi più irritata del voluto.
“Quella è una piazza da far venire l’agorafobia a chiunque. Figurati a loro! In preda al panico piangevano e invocavano la liebe Frau Doktor. Difficile proseguire per il museo, come nulla fosse stato. Lo sai, sono figlia di mia madre, patrona dei deboli e dei derelitti.
Allora guardai l’andirivieni di gente, e sperai in bene. Qualcuno di Lipsia ci sarà pur stato. E poi notai una folta presenza di Volkspolizisten.
Furono i primi a cui, nel mio chiaro conciso e personale tedesco spiegai ‘die Sachlage’, ossia la situazione.
‘Sono stata avvicinata da queste tre donne... Mi chiedono di riportarle al loro Nervenanstalt nella Karl Marxstätter Strasse, io non sono di Lipsia. La prego, se ne occupi lei, sono sicura che con lei sono in buone mani’.
Devi sapere che nelle ore successive le avrei ripetute tante volte quelle parole, a poliziotti, a semplici cittadini, ad alti funzionari, e sempre avrei ottenuto la stessa risposta:
‘Es ist nicht unsere Aufgabe! Non è nostro compito! E neanche il suo! Non si occupi di cose che non la riguardano’.
‘Ma da sole non se la cavano! Procuri almeno un taxi che le riporti in clinica’.
‘Nein! Non è previsto dal regolamento! Es könnte jeder kommen... Potrebbe provarci chiunque...’
‘Allora telefoni in clinica... o semplicemente al taxi... che poi ci penso io...’
‘Non sono autorizzato a fare telefonate private!’
Non mi rassegnavo, perché speravo ancora sempre di trovare l’eccezione, un’unica fulgida eroica eccezione, che si infischiasse del regolamento e riscattasse con un atto singolo di libertà tutto il corpo di polizia di Lipsia. Ma quell’eccezione, se c’era, non era su quella piazza.
Il cittadino comune che mi aveva sbirciata tutto il tempo mentre discutevo col poliziotto, appena io volevo abbordarlo, scantonava rapidamente. Perché non ha la libertà di scambiare parole con una forestiera, perché è ‘strengstens verboten’ avere contatti con persone dell’Ovest, a meno che non siano stati richiesti su carta bollata e regolarmente permessi. E che io venissi dall’Ovest era chiaro come il sole. Ma dal comune cittadino, nonostante il divieto, qualche indicazione su dove trovare una cabina telefonica e chiamare un taxi la ricavai.
E allora ci avviammo, tre donne disorientate e piangenti, capitanate da una quarta decisa a tutto. La cabina ci sembrò molto lontana, poi risultò introvabile.
Lo sai meglio ...