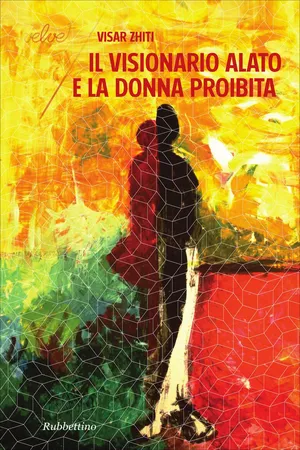![]()
Raccontare di Ema (quando si ruppe lo specchio del cuore)
Cosa raccontare di Ema che ho tanto amato e ora che non vive la amo di più? La uccisero barbaramente, quando speravamo nella vita, nell’amore, e nei grandi cambiamenti che incominciavano a farla stare bene con meno apprensioni. Credeva più che altro nelle trasformazioni interiori, di ognuno. Queste sì che sono importanti, sono difficili dicevano, credevamo nella possibilità dell’affermazione del bene, nel suo risveglio, e in verità gioivamo in questi inizi, ma non era naïf come me, un senso, natole in carcere, presagiva le disfatte, l’ingannevole gioco della dittatura per sopravvivere sotto altre forme, sebbene il comunismo fosse ormai caduto ovunque e tutto cambiava a una velocità incredibile. I dinosauri non potevano più riprodursi, ma non avremmo mai pensato che sarebbero velocemente diventati piccoli serpenti, spellati, disgustosi. Si turlupinavano a vicenda quei rettili di ogni specie, che, per ingrassare secondo il noto schema, stavano diventando più furbi, conservavano la cattiveria per dopo, e ingrassavano e ingrassavano. Stavano spuntando loro le corna, irrobustivano gli artigli mentre le ghiandole del veleno erano sature: lo vendevano di contrabbando. Si arricchirono più in fretta della loro caduta. Gli ideali non valevano quanto le maschere, sia pure ornamentali. Sembrò che tutto fosse iniziato bene, direi senza scontri. «Correte a cambiare pelle!», gridarono. L’aver voluto costruire la società nuova era sbagliato. In ogni caso, non si sapeva chi avesse sbagliato... Ora rinnoviamoci: non ci sono più colpevoli e i persecutori avevano voglia di presentarsi da perseguitati, sebbene, in verità, proprio tali erano stati: persecutori perseguitati...
In quei tempi mi ero legato molto a Ema, ogni giorno stavamo insieme, non ci separavamo, ci interessava solo il nostro amore. Folgorati dalla sua luce e dalla libertà: mai avevamo osato sognare tanto amore e libertà insieme. Anche per strada le mettevo la mano sulle spalle, lei metteva la sua ai miei fianchi, e ce ne andavamo senza meta, ovunque potevamo. Improvvisamente le saltava in testa di pitturarsi le labbra perché a me piaceva. Toglieva il rossetto dalla borsetta, non amava il trucco, solo un po’ sulle labbra; sì: diventavano petali germoglianti. Io, felice, facevo humour. Infatti in quel periodo, incoraggiato da Ema, leggevo molto. Perché oggi hai tralasciato la lettura?... Ma ecco, quasi avesse vergogna di mia madre e di mia sorella per via delle labbra turgide per i miei baci e qualche volta violacee, si passava il rossetto «lì per lì» – questa era un’espressione di mia madre – senza guardarsi allo specchio. «Ecco, mi specchio nei tuoi occhi», rideva con me. «Sai che impressione mi fecero i tuoi occhi la prima volta che ci incontrammo?... mi parvero un invito all’amore, e non riuscivo a capire dove li avessi già incontrati, dove, ma sapevo che mi avevano inseguito, dal giorno del mio processo». «Veramente il tuo processo... è terribile pensare che ti abbiano processato, le tue sofferenze e dopo... non voglio crederci...», e subito lasciavamo questo discorso, non volevamo riviverlo. La fotografia scattata durante il processo diventò di nuovo illegale. L’avevo nascosta, ci sconvolgeva. Meglio essere sconvolti dall’amore, bello come sa lei, dalle sue nuove foto, in altre pose... Perciò, appena passato alle labbra il rossetto, la baciavo di nuovo, senza rompermi la testa per le chiazze sulle mie labbra, agli angoli, ai denti, alla faccia. «Pulisciti!», mi diceva dandomi il suo fazzoletto, ma io non accettavo, e così continuavo a passeggiare, noncurante degli sguardi dei passanti. «Le persone non si vergognano di girare per strada armate», dicevo. «Chi se ne infischia se sono militari e caricano la folla». Ema veniva assalita dall’ansia, continuavo a dire, con un cattivo pensiero, di invidia nera. Mi stringeva il braccio, sentivo le sue lunghe unghie, una carezza. «E io», concludevo, «come non essere fiero delle impronte dell’amore!». «Il mio meraviglioso matto», mi sussurrava quando le avevo detto una volta a voce piena: «folle e meravigliosa!». Meravigliosa mi sembrava sempre e di più e anche folle, appena mi venivano in mente le pazzie di quei tempi, fatte senza pudore, diventate normali. Poche cose erano restate normali e lei, la mia Ema, era diversa in questo caos, del tutto diversa, e io la amavo ogni giorno e sempre di più. E lei diventava sempre più bella. Come se l’amore desse un riverbero splendente alla sua bellezza, a quello che le era mancato, una vitalità che aveva atteso riversarsi sulla sfioritura e sulle stanchezze, tanto da sembrarmi che nei suoi compleanni diventasse più giovane, non di un anno, ma di più, tre, cinque per volta. Il tempo stava tornando indietro, stava tornando a riproporsi meglio. Ah, avremmo dovuto festeggiare più compleanni! Perché tanto pochi, o Signore! Quanti in un bouquet di fiori. Si ripresentava l’infanzia di Ema, non con i lineamenti, ora più dolci, ma anche con il comportamento. Era diventata più fragile, più sensibile, si turbava più facilmente, allo stesso modo quando gioiva, era presa con facilità dalla nostalgia dei genitori e ora amava da matti le bambole. Qualche volta dormiva con queste, parlava con loro, ci giocava, si complimentava, rideva. «Che bello non avercele permesse in carcere!», mi disse una mattina. «Sarebbe stato terribile: le bambole in carcere». E tacque. «Ma tu sei una bambola», le dissi. «La mia bambola!». Avrebbe voluto sin da allora avere un figlio, una bambina. Che non replicasse il suo destino, e la amava anche se non esisteva, ma non si sentiva sicura. Né di se stessa, né della vita. «Bambola orfana», mormorò una volta con voce commossa. «Ma cosa dici?», le chiesi. «Niente, niente...». Ema diventava subito seria, e aspra, assumeva un atteggiamento risoluto, ma sempre sofferente.
Come dicevo, erano giunti tempi nei quali i nostri persecutori ci sorridevano, almeno a loro sembrava sorridere, ma era una smorfia disgustosa, un ringhio, perché nessuno avrebbe chiesto scusa. Non hanno né educazione e né coraggio, anzi una parte si vantava senza alcun ritegno di aver avuto un ruolo nella dittatura, ma quale ruolo, quello di assassinare? L’opposizione urlava. «Quando ci sono cambiamenti, i tempi sono più pericolosi, perciò state attenti, figlioli, attenzione», ci supplicava mia madre. «Cosa vi preparo a cena?». «No, non rientreremo, siamo con amici». Ema indossava il cappotto, oh, in che modo si copriva, quasi volesse proteggere il corpo da qualche futura batosta! Come se volesse diventare invisibile «Questi», dicevamo e lei ascoltava, «vorrebbero il caos. Saranno non solo gli istigatori, ma lo provocheranno», e si sedeva sulla poltrona in corridoio per tirare la chiusura lampo degli stivali, distendeva la gamba elegante: «Aiutala», mi sollecitava mia madre, ridevamo tutti. Ema voleva mirarsi senz’altro allo specchio d’oro a forma di cuore. «Mi fido», diceva, mentre io, alle sue spalle, osservavo la mia barba: era cresciuta. Mettevo i capelli in ordine con le mani. «È megliu», così dice tua nonna», ripetevo e aggiungevo: «Ma è sufficiente questo clima democratico, in formazione». Mentre nel primo bar dove entravamo, ordinavamo tè al limone e punch, io lo preferivo al cognac, ma assaggiavo anche il tè di Ema. Mi piaceva bere ciò che beveva lei e, di tanto in tanto, ci scambiavamo i bicchieri. Appoggiavo le labbra dove le aveva appoggiate lei, in quella piccola impronta del rossetto sul bicchiere, anche la sigaretta gustavo con le sue labbra, il filtro quasi avvolto da petali di rosa. Oh, che colore ha emanato! quello dell’amore, rossiccio. Parlavamo del nostro amore, di libri: li leggevo meglio dopo che li aveva letti Ema, e la scrittura, quasi indorata dal suo sguardo. Qualche volta non terminavo i romanzi, ci voleva del tempo e si assomigliavano, era Ema a raccontarmi la continuazione e allora mi piacevano molto di più. Diventavamo anche pessimisti, ma ce ne dimenticavamo subito. «La libertà, il pluralismo saranno insufficienti». «Cos’hai detto? Il pluralismo? non abbiamo cosa farci», ripetevamo. Come aveva detto lo scrittore argentino venuto a Tirana, «la peggiore democrazia è migliore della migliore dittatura», sebbene non siano mai esistite dittature buone. «Guarda Felix, brutte democrazie ci sono, noi la stiamo provando. Questo secondo lo scrittore argentino, con origini dagli Albanesi d’Italia. In una cerimonia in suo onore, gli consegnarono anche un pugno di terra del suolo degli avi, erano emigrati dalla Calabria. Chi gliela consegnò, era stato in prigione, lo conosci, sì, sì, se n’è andato in Italia per lavoro, scrive libri. Trovai in biblioteca una rivista e l’indirizzo di un’associazione «Besa», oh mi piacerebbe andare a Roma! tuttavia i tempi nuovi ci hanno permesso di conoscere meglio gli altri e cosa siamo e non siamo, di cosa ci occupiamo e di cosa non ci occupiamo. Sono cadute subito le maschere. Sai qual è la mia impressione? poiché eravamo un popolo di schiavi, istintivamente ci siamo messi in fila e ora ci avviamo verso una grande piazza, piazza Scanderbeg per esempio, sembrava che consegnassimo le armi, alla stessa maniera buttiamo le maschere, senza clamore, muti, affinché non facciano rumore. Intanto il loro cumulo è diventato montagna, non si riesce a passare dall’altra parte. Ma bisogna sgomberare la strada, bisogna togliere le maschere e la gente si avventa per riprenderle. Avanti, per trovarne una qualsiasi in questo bailamme. A uno serve la maschera dell’eroe, all’altro dell’indifferente, dell’oppositore, e del persecutore, del poeta, la maschera di chi non fa del male, del sorridente, del deputato ideale. Maschere differenti si aggrovigliano, ti resta in mano quella che non volevi, non serviva ora, maschere, loro pezzi, «lasciala, è la mia! soprattutto questa di perseguitato!», dell’intellettuale, le mettono sui volti, freddi senza maschere, non stanno loro bene, e cosa sta bene oggi? tutti questi volti pestati! Fotografavo le maschere, esposizione antologica, retrospettiva, maschere...
«Non resisto: di fronte sta bevendo il caffè l’ex–primo segretario. Firmò il mio arresto. Ha messo la maschera del vecchio partigiano». «Fermati! non andare a fare casino: ti prego. Proprio questo vogliono. Aspettano solo il momento di dire: ecco chi sono gli altri, vagabondi: non ti lasciano bere un caffè». «Ma quelli non ci lasciano vivere!». «Amore, calmati! sii più dignitoso, meglio così». «Anche l’indignazione è dignità», e sbotta: «Scegli l’arma: tu il tuo crimine, io la mia giustizia!». «Ti prego Felix, calmati! Oggi tutti urlano, dignitoso è anche stare calmo e dire cose di buonsenso. No, lascialo andare via». «Gli dirò educatamente: abbia l’onore di andare via da qui; lei è ripugnante, signore o compagno. Non c’è niente di male. Diversamente scatenerò un casino, un casino molto dignitoso». «Calmati, sta’ calmo». Gli spaccherò la sedia in testa e la pagherò in dollari... la sedia e non la testa. «No, no se n’è andato per libera scelta! Ti prego, siediti!». «Meritano il tribunale dell’Aja! Davvero: dovrebbero espellerli dal Paese. Buttiamoli via...». «Basta. Guarda un po’, il colmo: l’ex– primo segretario è il marito della proprietaria del locale! L’ha acquistato dalla privatizzazione, mi dice il cameriere, perché prima era della banconista, non di questa, ma di una loro conoscente, che è emigrata in America e questi, dopo, hanno messo a posto i documenti per l’acquisto del locale. Il tal dei tali sottoscrive, la stessa firma per arrestarti». Felix s’infuriò come un diavolo.
«Anche noi dobbiamo privatizzare le carceri, scherzava un nostro amico», stava raccontando Ema. «In un braccio facciamo entrare gli ex-prigionieri lasciati senza casa e senza lavoro, mentre dell’altro facciamo un museo, per dimenticare». «I musei sono stati fatti per dimenticare», aggiungeva lui. Naturalmente daremo in affitto anche altre sezioni delle carceri per girarvi i film, per ricostruire la verità, come auspicano quelli che scrivono la storia...
E di nuovo si ricordò che Ema, durante gli anni di carcere, non poté farsi fotografare, era severamente proibito, ti condannavano. Non volevano tracce, nemmeno un ricordo delle carceri e degli internamenti. Mi sentivo male per la mancanza di sue fotografie, immagini dell’attimo... inesistenti, di quel fissare gli sguardi, occhi e labbra dell’età, i sorrisi cercati, la speranza, panorami irripetibili del tempo passato, che mai potranno ripetersi.
Con Ema potevamo andarcene per sempre, dalla palude dell’internamento fuggimmo, però pantani c’erano dappertutto, soprattutto fango morale, dicevamo tra noi, ma ancora non ci sentivamo parte del nostro Paese, nello spirito, a quanto pare ci teneva uniti questo desiderio, appartenere a questa patria, fare il nostro dovere... e ci creavamo le occasioni di visitarla in lungo e in largo, per la prima volta. Non l’avevamo conosciuta, era veramente bella; viaggiammo al Sud, una costa meravigliosa, non riuscivamo a dormire per le onde del mare, in seguito senza di loro non ci addormentavamo, facevamo lo stesso sogno d’amore, spesso iniziava da uno e terminava nell’altro, visitammo i castelli, le montagne del Nord, i laghi, i monasteri riaperti al culto, era una patria vera, raccogliemmo in un album le fotografie delle nostre escursioni, un fotoromanzo, perché non inserire dei nudi, mi chiedevo, le proteste ci sono. Ema rideva, ti commuoveva la terra patria... un pugno di terra... sufficiente per noi... Rafforzavamo questa parola: «patria», come metafora sacrificale, non so perché, senza l’ironia che si meritava, e con tenerezza, a quanto pare era un invito a noi stessi, dovevamo pur mettere mano a qualcosa, era un nostro impegno, in politica no, in nessun partito per la sola emotività. Ema rifiutò la candidatura in Parlamento, anzi non ritirò nemmeno la certificazione della sua persecuzione politica, ma volevamo rispettare il nostro dovere di cittadini. «Racconterò la verità», diceva Ema. «Non solo la mia, so che è pericolosa», e partecipava alle conferenze con i perseguitati politici. Interveniva, incontrava giornalisti, anche quelli stranieri. Portava testimonianze, ne raccoglieva altre: la statistica delle piaghe. Lanciava idee per il futuro, non sopportava le lamentele e i vanti per le sofferenze, la patria non ci sembrava completamente nostra. In tutto il suo respiro, anche se ci avvicinavamo, retrocedeva... Come se, alla caduta del regime, fosse stata usurpata da coloro che non l’amavano, e ora facevano man bassa di tutto, creavano ricchezza solo per se stessi. Preziose – zanne, scherzavo, ma noi progettavamo il futuro, non tanto seriamente, assomigliavamo al vento, e se non fossimo partiti... Avremmo potuto abitare nella mia casa: saremmo stati stretti. Mia madre e mia sorella avrebbero accettato ogni privazione per noi: a loro stava bene, a loro bastava la nostra felicità, mentre nella sua città, Scutari, Ema non voleva più ritornare, non sopportava viverci per sempre. Lì una prima volta le avevano distrutto la vita; in seguito quella sciagura brutale e spietata, e ora i genitori, che dopo la carcerazione di Ema erano stati internati in un paese di montagna, non trovavano le condizioni favorevoli per rientrare in città. Li incontrammo di nuovo, ci commuovemmo, ma i montanari sono fieri, non ti svelano facilmente i loro sentimenti. Ci pregarono di restare con loro, prima in disparte a Ema e dopo a me. «Possiamo lavorare tutti insieme, ora abbiamo terreni, un negozio». «No, no…» ci hanno dato la licenza: «Siete stati abbastanza in prigione ora vi ci vuole il mondo», disse il padre di Ema, mentre la madre si mise a piangere, non aveva parole. Vennero anche a trovarci a casa, restarono alcuni giorni, la madre di Ema fece amicizia con mia madre. All’inizio sembrava che non si capissero a causa dei dialetti, ma no, parlavano che era una bellezza, l’una usava parole dell’altra e viceversa. Cosa farci se piaceva loro questo modo di parlare? La sorella piccola di Ema si era sposata ed era emigrata con il marito in Grecia, non aveva accorciato i capelli per sembrare moderna, o cambiato il loro colore e nemmeno il nome. Sarebbero venuti quanto prima, volevano invitarci in Grecia: «Fa parte dell’Unione Europea», diceva il marito. «L’hanno accettata per la sua storia. Le statue antiche, qualche volta, riescono a fare più dei politici, mentre la nonna di Ema – eh, non aveva motivo di stare dietro la nipote – era ritornata nella montagna sopra Scutari: «Vojo morì là, sutta l’alpi, sutta l’umbra de l’ali de l’aquile», aveva detto a Ema, quando si salutarono e la baciò in fronte. «Tu», rivolgendosi a me: «Nun te devi meraviglià. Iu parlu “cu folclore”, cume dite voi, invento le parole, appartengo alli leggende e lì aju tornare, divennare nebbia, biata me, ma tu, giovanotto, trattame bene a piccinina. È cume a lacrima nell’occhio del capriolo davanni u fucile du cacciaturu...». In disparte mi raccontò che Ema faceva sogni paurosi e a occhi aperti:«Le appaiono, non so cosa, una specie di draghi. Ohi, ohi a nonna sua, di quelli del carcere, mai sia, o Signore! Preghiamo per scacciarli: stai attento, tesoro della nonna...». Né i genitori di Ema, né i miei ci dicevano qualcosa per il matrimonio, solamente l’augurio: «che siate felici e contenti»! Mi sembrava che il tempo avesse aperto un fossato che poteva essere riempito... solamente con la gioia della presenza di entrambi. Scutari sconvolgeva completamente Ema. «Posso affrontare la mia città?», mi diceva. «Il mio sogno... la mia giovinezza, io… li ho abbandonati». S’innalza ancora sinistro l’edificio dove era stata condannata, con le celle sotterranee delle torture. Le dicevo, seriamente, di andare a metter lì la dinamite, di farlo saltare in aria. Lei rideva sonoramente e mi dava un bacio sulle labbra, ovunque ci trovassimo: per strada, al bar. Strano! prima il bacio era proibito, e ridevamo. Anche i bar diventavano più belli. I primi piani dei palazzi incominciavano ad essere rivestiti con legno o marmo. «Se ne vedono all’estero», sentivamo dire.
Volevamo andarcene. Una volta pensammo di trasferirci tutti nella capitale, c’era la possibilità, avremmo trovato anche lavoro. Ema sosteneva gli esami all’università con buoni risultati e voti alti, era iscritta in Lettere. Io andavo alla ricerca di suoli edificatori per le nuove imprese, venivo pagato bene, costruivamo palazzi... a iosa. «Lavoreremo entrambi», diceva Ema. «E frequenteremo l’università per corrispondenza». «A me piaceva l’accademia militare», dicevo, senza la convinzione che fosse vero. «Oppure potrei dedicarmi di nuovo alla veterinaria? Ecco, gli animali non mi avevano accettato, ad essere preciso i loro uomini, amo la fisica nucleare, l’ingegneria della fotografia, ma qui non ci sono questi indirizzi, né corsi. Amo il bel ritratto, trovarlo, scoprirlo, o...». Facevamo progetti, li cambiavamo, eravamo ovunque e in nessun luogo, facevamo i turisti appena raggranellavamo un po’ di quattrini. Ema leggeva, traduceva, teneva appunti, scriveva, qualche volta me li leggeva, rispondeva ai giornali, soprattutto stranieri. Ora la Banca di Stato acquistava oro, erano venute fuori le monete d’oro tenute nascoste, posate ...