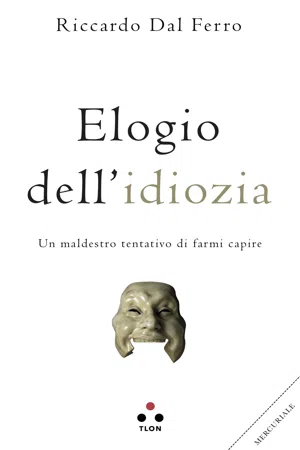![]()
Il terzo degli idioti
J. R. R. Tolkien
La musica che dà via all’idiozia
«L’invenzione di linguaggi è il fondamento. Le “storie” sono state create piuttosto per fornire un mondo ai linguaggi, che non il contrario. A me viene prima in mente un nome, e la storia in seguito. Per me è un esteso saggio di estetica linguistica, come dico talvolta alle persone che mi chiedono “di cosa parla?”»
Queste sono le parole che Tolkien scrive nella lettera 165 che troviamo nella raccolta di epistole La realtà in trasparenza, cercando di rispondere alla domanda: “Com’è nato Il Signore degli Anelli?”.
Certo, mentre i due autori di cui abbiamo trattato prima sono facilmente affiancabili all’epiteto “idiota”, ci si potrebbe chiedere cosa possa esserci mai di idiota in un autore così razionale, ordinato, pacato e adorabile come J. R. R. Tolkien. Ma non lasciatevi ingannare, l’idiozia è multiforme e camaleontica, e non è certo un’aria “british” da lord a ingannarci sulla vera natura dell’opera tolkieniana. Anzi, essa ci mostra la vera e più profonda natura dell’idiozia in ambito letterario, ci indica il perché l’essere idiota sia una caratteristica intrinseca al fare letteratura, in qualsiasi forma possiamo intendere ciò.
Dobbiamo però partire dal principio. La passione per la letteratura, nel piccolo Tolkien, non nasce affatto dalle storie, dalla narrazione, dal significato che sta dietro le parole. La passione che ne smosse l’animo fu la semplice lettura di un nome: “Éarendel”, trovato nell’antico poema sassone di Cynewulf Christ I, tratto dal Libro di Exeter. Il verso completo letto dal piccolo John recitava così: “éala éarendel engla beorhtast / ofer middangeard monnum sended” (“Salve Earendel, il più brillante degli angeli sopra la terra-di-mezzo inviato agli uomini”), al cui interno troviamo ovvi rimandi alla cultura cristiana di quei secoli (siamo intorno al ix secolo): la figura angelica, ma soprattutto l’invito agli uomini da parte della divinità. Nel poema, “Éarendel” è infatti figura cristologica, salvatore degli uomini perduti inviato direttamente da Dio.
Ma è palese che il piccolo Tolkien, che probabilmente all’epoca della prima lettura del Christ aveva circa otto anni, non potesse essere colpito da tutto ciò, quanto piuttosto da due parole particolari: “middangeard”, ovvero “terra-di-mezzo”, ma soprattutto “Éarendel”, che nell’opera tolkieniana successiva si trasformerà in “Earendil”.
Ora, parafrasando un po’ Lacan, potrei dire che non sono affatto sicuro che le parole abbiano un significato, ma sono assolutamente certo che abbiano un suono. È chiaro che, nel momento in cui dialoghiamo con qualcuno, o quando ascoltiamo un discorso pronunciato dal Presidente del Consiglio o da un sacerdote, il primo elemento che ci colpisce è il suono, la vibrazione che colpisce il nostro timpano e che risuona nel cervello, tradotta in impulsi elettrici e chimici. Se dal punto di vista della coscienza il tempo che intercorre tra quella vibrazione e l’acquisizione del significato che sta dietro quel suono è impercettibile e insignificante, dal punto di vista del tempo neurale si tratta di un tempo indescrivibilmente ampio. Un abisso di millisecondi separa l’esperienza del suono che la parola rappresenta e l’elaborazione del significato che le attribuiamo. E mentre il primo elemento è reale, concreto, fisico e riconoscibile da tutti, il secondo elemento è immaginario, etereo, soggettivo e sfuggente.
Questo è un fatto fondamentale per comprendere non solo la natura del linguaggio, il cui significato viene sempre trasmesso secondariamente al nostro cervello rispetto al suono che le parole portano con sé, ma soprattutto la natura dell’opera tolkeniana. Quando nella lettera citata inizialmente l’autore inglese dice: “Le ‘storie’ sono state create piuttosto per fornire un mondo ai linguaggi, che non il contrario” sta dicendo una cosa che per la nostra concezione della letteratura risulta davvero difficile da digerire. Come sarebbe a dire che le storie sono soltanto un bel vestito per delle parole? Davvero Tolkien scrive la sua gargantuesca opera esclusivamente come pretesto per poter usare delle parole che l’avevano colpito da piccolo? La cosa sembra incredibile, e incredibilmente… idiota. Ma le cose stanno esattamente così.
Nell’archivio di J. R. R. Tolkien sono state trovate pagine scritte per l’ammontare di quasi un milione. Tenendo conto che egli visse ottantuno anni e calcolando che la sua produzione letteraria si sia sviluppata in circa sessantacinque anni (le primissime bozze dei racconti della maturità risalgono a quando aveva circa sedici anni), possiamo immaginare che dedicasse più o meno trecentoquaranta giorni l’anno alla scrittura, dal momento che era la sua professione (che ben si sposava alla cattedra di Inglese antico e di Lingua e Letteratura Inglese). Il che ci porta a concludere che Tolkien scrisse circa sessanta pagine al giorno, una quantità da far venire i brividi. Certo, all’interno di queste sessanta pagine non ci sono soltanto righe scritte fitte fitte, troviamo anche mappe, disegni, schemi, riassunti, esperimenti di ogni tipo. Ma sono comunque sessanta pagine al giorno.
Perciò, se ci risulta facilissimo accorgerci di come la letteratura fosse una vera e propria ossessione per gli sregolati H. P. Lovecraft e Philip K. Dick, questo dato ci porta a concludere che persino dietro quel pacato, elegante e fragile professore britannico si celava un’ossessione forse ancora più irrequieta e abissale.
Come detto, ciò che Tolkien desiderava fare con la propria letteratura era dare un mondo a delle parole, a dei linguaggi. Non dovrebbe quindi stupirci la scoperta che la maggior parte di quel milione di pagine ritrovate nel suo archivio non siano inerenti il racconto e la narrazione del mondo che si sviluppa intorno alla saga de Il Signore degli Anelli, quanto piuttosto alla vera e propria creazione di linguaggi.
Per esempio, il Quenya, ovvero l’Elfico classico, si basa su un connubio tra latino, finnico e greco e possiede un alfabeto completo e una grammatica elaborata; il Sindarin, originato dal Quenya, è la lingua degli Elfi grigi e adottata poi dagli Elfi approdati nella Terra di Mezzo, la sua origine deriva da una trasformazione del gallese ed è forse la lingua meglio elaborata e più completa del corpus tolkeniano; il Linguaggio Nero, l’idioma di Mordor, inventato da Sauron stesso e completo di forme dialettali, deriva da una deformazione del Quenya; e poi ci sono l’Entese, l’Ovestron, il Nanesco (Khuzdul), l’Orchese, il Dunlandiano, il Valinoreano e molti altri linguaggi, sicuramente meno completi, ma comunque valevoli di analisi e studio.
La quantità di materiale rinvenuto in questo senso è mostruosa e disorientante. Cosa spinse un uomo con la fantasia di Tolkien a lanciarsi in una tale esplorazione linguistica apparentemente priva di significato e completamente autoreferenziale? Anche se a riguardo dell’arte la domanda “a che cosa serve?” è ridondante, odiosa e decisamente priva di utilità, non possiamo però esimerci dal porcela nel momento in cui ci troviamo di fronte a questa produzione gargantuesca di materiale, soprattutto quando pensiamo che gran parte della vita, delle energie fisiche e psichiche di un uomo è stata dedicata esattamente a questo. E se qualcuno potrebbe accontentarsi della desolata considerazione “che spreco!”, noi non possiamo fermarci lì e, nutrendo fiducia tanto nella capacità dell’arte di superare i confini di ciò che riteniamo normale quanto in un uomo come Tolkien che ci ha regalato un’opera di straordinaria importanza, proveremo a lanciarci in un’interpretazione ardita di que...