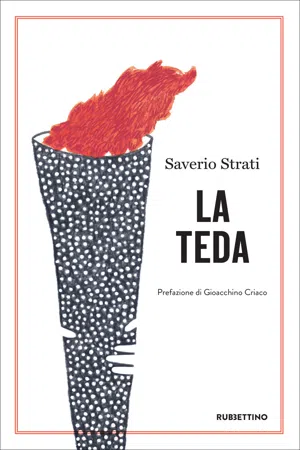![]()
VII
Ma credo che il podestà non chiuse occhio, pensando che noi dovevamo andare a fargli quel lavoruccio di cui aveva parlato a mastro Antonio: difatti si presentò di buon mattino a bussare alla nostra porta. Noi ci alzammo con le brache in mano, per aprirgli.
«Io son venuto per quel favore che avevo chiesto a mastro Antonio» ci disse.
«Sì, certo! Ora veniamo» gli disse Costanzo.
Io ero veramente scocciato, perché mi ero dovuto alzare più presto del solito, mentre sarei potuto stare coricato sino a tardi.
«Non c’è un gran che da fare» disse il podestà. «Voi due, in un paio d’ore, sarete liberi. Potete venire col vostro tempo, io intanto faccio impastare un po’ di calce» aggiunse, e se ne andò.
E noi andammo davvero col nostro comodo: la cazzuola, il martello ed il regolo in mano.
C’era Bruno ad impastare la calce, ed il podestà era davanti a guardarlo.
Noi salutammo, ed il podestà ci fece entrare nella stanza da pranzo.
«Ecco: dovete aggiustare questi quattro mattoni» e ci indicava il lavoro da fare. «E poi... venite, venite con me...» continuava a dire, e c’introdusse nella camera da letto. «Ecco, ecco: questa è la finestruola che dovete mettere a posto».
«Va bene, va bene!» diceva Costanzo.
I cosi mi si gonfiavano a vedere che c’era da fare tanto lavoro, e provavo l’impeto di tirare un calcio nel sedere a quel cazzone del podestà. Intanto però osservavo la casa. Era fredda, vecchia, triste. Nella camera da letto c’era uno specchio appannato, due vecchie casse, e un gran letto su trespoli di ferro.
«Non è un gran lavoro» continuava a dire il podestà. «Cosa da poco, figlioli, cosa da poco!»
Ritornammo nella stanza da pranzo. I mattoni di terracotta parevano la tastiera del vecchio organo della chiesa, sotto i nostri piedi. Ad ogni mattone che si muoveva, il mio cuore si oscurava, perché pensavo che ci volevano assai più di due ore di lavoro, per metterli a posto.
Il podestà ci lasciò. Andò in cucina, da dove venivano voci di donne.
Certo erano la moglie e la figlia di lui.
«Dov’è la figlia?» dissi a Costanzo, a fil di voce.
«Mah!...» fece lui, stringendosi nelle spalle. «Qui ci vogliono due giorni di lavoro, altro che due ore!» aggiunse. «Tutto l’ammattonato è smosso».
«Allunghiamo la mano ed in quattro e quattrotto lo stampiamo. Non è che dobbiamo fare il Duomo di Milano, noi».
Attaccammo a lavorare, con sveltezza.
Ritornò il podestà, seguito dalla moglie.
Lei ci salutò e si mise a parlare con noi, come se ci conoscesse da anni. Aveva uno scilinguagnolo che non vi so dire. Ci diceva che al nostro paese conosceva il signor tizio ed il signor caio. Tutti gente perbene, nobili e civili, e che suo fratello era medico in un altro paese e che aveva sposato una riccona che era parente di un marchese. E che in tutta la provincia lei aveva parenti e amici, perfino a Reggio; e a Roma delle grandi conoscenze. Non perché la vedevamo a Terrarossa, noi! Ché tanto fortunata non era stata a finire in quel brutto paese di animali. E tutti i suoi parenti erano avvocati o medici o gente molto ricca: dei signori che avevano anche la macchina. E ci parlò di sua madre e di suo padre e di tutta la sua razza morta e viva. E ci diceva che, se non per lei, suo marito non avrebbe voluto fare il podestà; e che suo fratello e tanti altri parenti avevano rimproverato suo marito di questo, e poi l’avevano fatto nominare podestà dal prefetto in persona. Proprio il marchese, parente di suo fratello, che col prefetto erano stretti così, aveva fatto mandare la nomina di podestà dalla sera alla mattina. Perciò mastro Carmelo, il segretario, ce l’aveva con loro: perché sperava di diventare lui podestà del paese, con l’aiuto di suo cugino prete. Ma questo non poteva essere giusto, perché il podestà lo deve fare la persona più ricca del paese, quella che ha più amicizie. E i suoi parenti avevano tante amicizie a Roma, e in tutta l’Italia, che tremava la terra.
Noi, col rumore che facevamo lavorando, perdevamo metà delle sue parole. Ma lei parlava assai più di una cicala. Il podestà era timido e muto davanti a quella moglie tanto potente. Lui la pregò di andare di là, perché noi dovevamo lavorare. Ma glielo disse in tono dimesso, come se fosse un servo. Ma lei, la signora podestà, non gli badò. Aveva sete di parlare e noi la lasciavamo abbaiare, senza dire né sì, né no. Ché con i muratori non la vince neppure il diavolo. Ma lei continuava a parlare di sé, della sua razza e di tutti i nobili della provincia. Poi vennero delle donne e la podestà, che era quella che dirigeva la baracca, se ne andò là dentro, e ci lasciò finalmente in santa pace.
Con Costanzo lavoravamo sveltamente. Mettevamo i mattoni a posto, senza usare il regolo, per finire presto. E questo perché la podestà era tanto potente! Io ci scherzavo sopra. Dicevo a Costanzo di stare attento, perché lui i mattoni li metteva col naso all’aria; e che pareva la scala del paradiso dove lavorava lui. Costanzo rideva e mi diceva che lavorava comunque meglio di me, anche se chiudeva gli occhi. E tiravamo avanti alla meglio.
Di tratto in tratto la signora podestà entrava da noi e ripigliava il discorso. Parlava e riparlava di quella benedetta razza sua: di suo fratello che, oltre tutto, era un medico valentissimo; di suo nonno che era stato una celebrità. Anche il medico di Terrarossa era suo cugino, ed aveva avuto la condotta lì, per le conoscenze dei suoi parenti. Ma lui, povero figlio, soffriva le pene dell’inferno a stare in questo paese; e per sta ragione di tanto in tanto, si faceva un viaggetto a Reggio. Ma intanto i disgraziati di Terrarossa sparlavano contro di lui. Ma non c’era da meravigliarsi, giacché la loro mentalità era quella! Ieri sera era arrivato da Reggio, ed aveva portate buone nuove della farina. Lo potevamo dire noi stessi ai maicontenti rozzi maleducati e selvaggi di Terrarossa... Ah!... Ma anche noi avev...