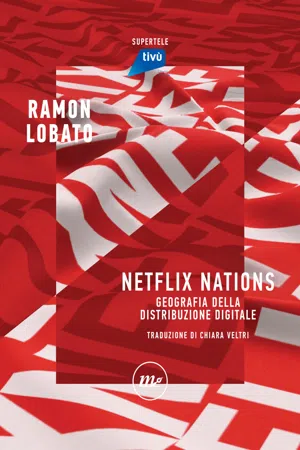![]()
1
COS’È NETFLIX?
Nell’introduzione al loro libro YouTube: Online Video and Participatory Culture,1 Jean Burgess e Joshua Green fanno un’affermazione importante sulle sfide che lo studio dei media digitali emergenti comporta. Per Burgess e Green, uno degli aspetti più interessanti e difficili nello scrivere un libro su YouTube è stato il fatto che questo si stesse ancora evolvendo. Alla fine dell’ultimo decennio, YouTube aveva una qualità camaleontica: era una «piattaforma di distribuzione che può rendere estremamente popolari i prodotti dei media mainstream», pur essendo allo stesso tempo «una piattaforma per contenuti creati dagli utenti, da cui potrebbero emergere delle sfide alla popular culture commerciale».2 I suoi creatori, investitori e utenti – per non parlare degli accademici – dovevano ancora mettersi d’accordo su cosa fosse davvero YouTube, cioè aleggiava ancora una grande incertezza sugli scopi per cui si poteva usare la piattaforma e sul modo in cui poteva essere regolamentata e interpretata in rapporto agli altri media. Burgess e Green sostengono che
poiché non c’è ancora un’interpretazione condivisa della cultura comune di YouTube, ciascun approccio accademico che si propone di comprendere il funzionamento di YouTube deve scegliere tra queste interpretazioni e quindi ricrearlo ogni volta come un oggetto diverso; in questa fase embrionale della ricerca, ogni studio su YouTube ci dà un’interpretazione diversa di quello che YouTube è in realtà.3
Questo problema ontologico essenziale (cos’è un servizio di media digitali, e come lo interpretiamo e teorizziamo?) si applica a una gamma ampia di fenomeni che esistono ai confini tra televisione, cinema e media digitali. Gli studiosi di Netflix pertanto devono compiere determinate scelte e decidere che tipo di servizio è e quali dovrebbero essere i frame analitici appropriati, in questo modo ricreando ogni volta daccapo l’oggetto, attraverso l’apertura o la chiusura di filoni di confronto.
Anche se Netflix è un affermato brand globale con vent’anni di storia, non c’è un consenso su cosa sia o su come debba essere interpretato dal pubblico, dagli accademici o dagli organismi di controllo dei media. Netflix – al pari di molti fenomeni mediali disruptive che l’hanno preceduto, tra cui la radio e la televisione broadcast – è un oggetto liminale, che esiste tra le categorie concettuali che adoperiamo per pensare ai media, e le rende inevitabilmente problematiche. Questa tensione relativa alla definizione si può osservare negli slogan di marketing che Netflix usa per descriversi, i quali rispecchiano un’evoluzione sia nel modello distributivo dell’azienda sia nel suo posizionamento discorsivo in rapporto agli altri media. Attualmente, Netflix si autodefinisce un «network televisivo globale via internet», ma in passato ha preferito espressioni come «il servizio di noleggio online di dvd più grande al mondo» (2002), «il servizio di noleggio online di film più grande al mondo» (2009), e il «servizio di abbonamento su internet più importante al mondo per i programmi tv e i film» (2011).4 Altri hanno fatto riferimento a Netflix definendolo «un giocatore eretico della partita televisiva»,5 «un pioniere a cavallo dell’intersezione tra big data e media di intrattenimento»,6 un «mostro che sta divorando Hollywood»,7 e persino «un’azienda che sta tentando di conquistare il mondo».8 Altre possibili risposte alla domanda «cos’è Netflix?» sono:
- una piattaforma video
- un distributore
- un network televisivo
- una global media corporation
- un’azienda di tecnologia
- un sistema di software
- una società di big data
- una sentinella della cultura
- un brand di lifestyle
- una modalità di visione
- un rituale
Chiaramente Netflix significa cose diverse a seconda delle persone. In parte il punto è che ci troviamo davanti a una serie di frame interpretativi tra loro incompatibili. Ciascun frame porta con sé una serie di assunti ed evoca una particolare storia di evoluzione industriale e tecnologica. Man mano che passiamo in rassegna queste varie descrizioni, anche la posizione di Netflix all’interno dei settori industriali sembra spostarsi, tra industrie televisive, video, tecnologiche, di internet, di media digitali, entertainment e informazione. Le strutture concettuali che usiamo per comprendere Netflix sono importanti perché determinano la tipologia di pensiero che apportiamo all’analisi. Di conseguenza, queste strutture richiedono un po’ di riflessione critica.
Questo capitolo delinea due differenti prospettive analitiche che si possono applicare a Netflix e, così facendo, sintetizza criticamente due ambiti correlati della letteratura accademica. La prima si può rintracciare all’interno dei television studies, sotto forma di ricerca sulle trasformazioni digitali e post broadcast della tv. La seconda è esterna ai television studies e proviene dalla teoria dei media digitali, dagli internet studies e dai platform studies. Come argomenterò, è utile spostarsi tra queste due modalità in modo da evitare l’impasse intellettuale che si verifica quando si segue troppo pedissequamente un’unica linea di pensiero. Per esempio, se studiamo Netflix sotto l’aspetto delle analogie e differenze rispetto alla televisione, possiamo perdere i suoi punti di contatto con gli altri media digitali. Analogamente, concentrarsi esclusivamente sulla sua dimensione di software oscura i rapporti strutturali di Netflix con le industrie audiovisive tradizionali. Dobbiamo stare attenti a riconoscere l’attrattiva naturale di determinate modalità di pensiero e a quello che esse rivelano e nascondono quando le applichiamo a diversi tipi di oggetti mediali.
I television studies e il dibattito sul futuro della tv
Oggi l’ambito accademico dei television studies è in uno stato di evoluzione e attraversa un’altra fase di autoanalisi. In anni recenti, è emerso un ricco corpus di ricerca e teorizzazione postconvergenza che esplora i modi in cui tecnologie digitali di vario tipo hanno di volta in volta trasformato, esteso e sostenuto le industrie televisive esistenti. Questa letteratura si pone domande quali: cos’è ora la televisione? Cosa potrebbe diventare? Quello stupido apparecchio è morto, dormiente o più predominante che mai? Nell’era dell’«espansione e dell’eccesso» televisivi,9 quali sono i confini che delimitano un medium, un sistema di distribuzione o un singolo testo?
Simili interrogativi sono stati esaminati attentamente dagli studiosi, tra cui William Uricchio, Milly Buonanno, Chuck Tryon, Amanda D. Lotz, Lynn Spigel e Graeme Turner. Sono state pubblicate alcune influenti antologie, tra cui Television After Tv: Essays on a Medium in Transition,10 Television Studies After Tv,11 Television as Digital Media12 e After the Break,13 oltre a numerose monografie e pubblicazioni di settore. Le riviste di television studies, tra cui Television & New Media, Flow e VIEW, hanno ospitato vivaci dibattiti su questi temi. Esiste anche un corpus più vasto di letteratura tecnica e normativa, in gran parte realizzata da esperti di telecomunicazioni; per esempio, l’economista mediale della Columbia University Eli Noam scrive di televisione via internet dagli anni Novanta del Novecento, prima che il tema diventasse un interesse mainstream degli studiosi di media.
A grandi linee, questa letteratura rileva nella storia della televisione una serie continua ma irregolare di transizioni, che nel complesso agiscono trasformandola da un medium di massa a uno di nicchia, attraverso sviluppi tecnologici e istituzionali che «frammentano il pubblico televisivo, prima di massa, in una serie di scelte personalizzate».14 Kelsey scrive che «non ci limitiamo a guardare la tv, la inviamo e la riceviamo, la raccogliamo e organizziamo sui nostri touch screen personali, e nel frattempo interagiamo con i siti per produrre, deliberatamente o meno, il feedback dei consumatori che aiuta le emittenti a determinare la programmazione di una stagione (se la tv pensa ancora in termini di stagioni)».15 Tryon afferma che «le piattaforme mediali contemporanee si rivolgono attivamente a un consumatore di media individualizzato, frammentato e autonomo, con un maggiore controllo di quando, dove e come guarda film e programmi televisivi», con l’avvertimento che «questa offerta di liberazione dall’orario di programmazione è spesso accompagnata da un’accresciuta sorveglianza».16 In reazione a questi cambiamenti, stanno emergendo anche periodizzazioni alternative della tecnologia televisiva. Alcuni esperti ora si riferiscono a TVI (il solo broadcast), TVII (l’era via cavo) e TVIII (la distribuzione digitale), espressioni che attirano la nostra attenzione sulle ondate successive di trasformazione che hanno spazzato la tecnologia e l’industria televisiva.17
I lavori della studiosa statunitense di televisione Amanda D. Lotz offrono un resoconto profondamente stratificato di queste trasformazioni. In una serie di libri – soprattutto nella seconda edizione di Post Network,18 in Portals: A Treatise on Internet-Distributed Television19 e in We Now Disrupt This Broadcast20 – l’autrice offre una disamina accurata e ricca di indizi dei cambiamenti avvenuti nei modelli economici di fondo della televisione nel passaggio online e di come questi modelli determinano la programmazione, la produzione e la diffusione. La Lotz parte spiegando in che modo la logica fondamentale della televisione si fonda sulla linearità: «Pressoché tutte le convenzioni della televisione – un flusso di contenuti, la durata di un programma, le aspettative legate agli episodi settimanali – derivano da pratiche sviluppate per affrontare la necessità del palinsesto lineare». Al contrario, il carattere on demand della televisione via internet e dei suoi precursori nei primi servizi on demand (come i film in pay-per-view via cavo) presenta una modalità di distribuzione differente, che ha più elementi in comune con il negozio di dischi o la libreria e la biblioteca. In tal modo, la televisione via internet «permette a comportamenti che nell’era dei media analogici e fisici erano periferici, come il timeshifting, la self-curation e l’accesso à la carte, di diventare pratiche centrali e industrializzate».21
La Lotz considera Netflix una parte cruciale di questa storia, non soltanto perché l’azienda «intaccò la nozione inveterata che i contenuti televisivi andassero visti sul televisore»22 ma anche perché ha introdotto nuove tipologie di sistemi di filtro, aggregazione e raccomandazione che poi si sono diffusi. Ravvisa nella coda di Netflix (che ora si chiama lista) un punto nevralgico attraverso cui gli utenti hanno affrontato il passaggio alla televisione non lineare, osservando che essa «ha fornito agli abbonati un nuovo paradigma per pensare il comportamento di visione e organizzarlo, e questo è sfociato in una sfida radicale alla vecchia proposta di tipo lineare (atteggiamento “cosa c’è in tv”)».23 In altri termini, la Lotz considera estremamente importante la distribuzione online di contenuti perché segnala una trasformazione nella struttura di base e nei modelli di business della televisione, liberando i contenuti dal palinsesto lineare e introducendo nuovi modelli di prezzo (tra cui pacchetti di abbonamento all-you-can-stream) e aspettative del pubblico nei confronti di contenuti, novità e valore dei servizi tv. Come scrive, «l’affordance delle tecnologie dei protocolli internet di offrire contenuti selezionati personalmente da una library curata a livello industriale è la differenza cruciale introdotta da questo nuovo meccanismo di distribuzione».24
All’interno dei vari contributi al dibattito sul futuro della tv, possiamo vedere livelli diversi di enfasi sul cambiamento in contrapposizione alla continuità. Nei suoi testi la Lotz mette in primo piano le dimensioni trasformative della distribuzione su internet, mentre altri studiosi si concentrano sugli elementi di continuità. In questa seconda categoria, troviamo spesso le opere degli storici dei media, che sono per formazione e per temperamento ambivalenti nei confronti delle diagnosi di cambiamento radicale. William Uricchio, per esempio, sottolinea il fatto che le idee di tv personale e tv interattiva risalgono a un periodo di gran lunga precedente rispetto all’era di internet e si possono rintracciare lungo tutta la storia del medium, tanto che nel corso del ventesimo secolo si trovano concetti che le anticipano:
La televisione rappresenta un caso straordinario in cui sia la piattaforma tecnologica sia i suoi protocolli d’utilizzo si sono trasformati radicalmente e in modo più o meno continuo a partire dalla fine dell’Ottocento. Abbiamo visto il progetto televisivo allearsi con piattaforme quali il telefono, la radio, il cinema e il computer messo in rete; e abbiamo visto che tra i suoi protocolli ci sono la comunicazione da persona a persona, l’intrattenimento e le notizie, la sorveglianza, la t...