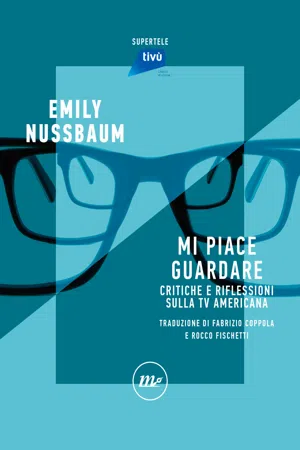![]()
CONFESSIONI DI UNO SCUDO UMANO
Inizialmente, per questa antologia, avevo programmato di scrivere alcuni articoli monografici sulla televisione – uno sul lavoro collaborativo, uno sulla teoria del fan cattivo, uno sul rapporto tra la moralità e la tv – ma non avevo ancora deciso. Poi è esploso il caso Harvey Weinstein, è nato il movimento #MeToo e questo è ciò che alla fine ho scritto.
Tra i venti e i trent’anni, Woody Allen è stato la mia stella polare. Il primo film in assoluto che ho visto è Il dittatore dello stato libero di Bananas, a soli cinque anni, raggomitolata nel mio pigiama in un drive-in insieme ai miei genitori. Alle medie ho letto le tre antologie umoristiche di Allen, Rivincite, Senza piume ed Effetti collaterali, sghignazzando sui miei racconti preferiti, in particolare «Le squillo del club Mensa», una satira su clienti solitari che pagano una prostituta intellettuale per discutere di Ezra Pound. Ho consumato i miei vinili delle esibizioni di stand up comedy di Allen della metà degli anni Sessanta. Potevo recitare a memoria il monologo «L’alce», imitando le sue inflessioni («l’alce e i Berkowitz incrociano le corna nel soggiorno»).
La sensibilità di Allen diventò la base per quasi tutto ciò che riguardava la mia identità di adolescente: la mia idea di cosa era divertente e cosa sofisticato, o in cosa potesse consistere la vita intellettuale e relazionale degli adulti – e la mia visione più generale di cosa volesse dire essere uno scrittore a New York, avere il cuore a pezzi, avere gusto, avere un crollo nervoso, organizzare un cocktail party. Anche se un giorno il mio capo al New Yorker mi disse che Manhattan era diventato inguardabile, io l’ho rivisto almeno una ventina di volte. Decenni prima, avevo preso i biglietti con un amico per andare a vedere il regista che suonava il clarinetto al Café Carlyle, il che era molto eccitante sebbene odiassi il jazz. Avrei avuto la possibilità di vedere il mio eroe in carne e ossa.
Intorno ai sedici anni ho fatto un sogno che ricordo ancora oggi, a distanza di anni. Andavo a fare visita a Woody Allen e Mia Farrow negli Hamptons. All’epoca erano una coppia famosa e io ero rimasta affascinata dalle cronache dei quotidiani in cui si diceva che i due si salutavano sventolando un asciugamano dalla finestra dei loro appartamenti sui lati opposti di Central Park (una storia che non ha più molto senso, ora che sono stata a Central Park). Nel sogno avevo preparato per Woody Allen dei biscotti al cioccolato, ma li avevo sistemati all’interno di uno di quei barattoli metallici tondi, quelli che vengono usati per i dolci nei negozi costosi – il genere di regalo che si porta per fare bella figura con un amico ricco. La mia paura era che, per via della confezione, non avrebbe capito che li avevo fatti io.
Si poteva ricavare un’interpretazione freudiana di quel sogno – sarebbe stato sicuramente in tema con Woody Allen – ma per me non era altro che il sogno di una fan. Riguardava il desiderio che l’artista che amavo riconoscesse l’autenticità, la genuinità, la purezza dell’ammirazione che provavo per lui.
Quando nel 2014 la lettera aperta di Dylan Farrow – una vera e propria pugnalata al petto – fu pubblicata sul New York Times, era rivolta in maniera particolare alle persone come me. «Qual è il vostro film preferito di Woody Allen?», esordiva. «Prima che rispondiate, dovreste sapere che quando avevo sette anni, Woody Allen mi prese per mano e mi portò in una piccola soffitta semibuia al secondo piano della nostra casa». A quel tempo, ero pronta a leggere il seguito. Allen non era più il mio eroe da diversi anni – un lento declino, lungo decenni, fatto di film sempre peggiori e una reputazione sempre più a pezzi. Con abilità da detective e una fissazione ansiosa e infelice che era l’esatta immagine speculare dell’attaccamento di una fan, avevo divorato ogni libro scritto su Allen, incluse alcune biografie autorizzate e non autorizzate, oltre all’articolo di Maureen Orth su Vanity Fair riguardo le accuse di molestie su minori, e a tutti gli altri scritti dagli amici di Allen per difendere la sua reputazione (e, a questo scopo, attaccare Mia Farrow), ma che per la gran parte peggioravano l’immagine del regista, facendolo sembrare un manipolatore circondato da leccapiedi. Non ero più agnostica sulla questione se Woody Allen avesse o meno molestato sua figlia piccola, e neppure se fosse «non colpevole», due condizioni esistenziali separate ma collegate. Io credevo a quella lettera.
Tre anni prima della sua pubblicazione, avevo assistito a una pièce di Allen, in cartellone con altri due atti unici rispettivamente di Ethan Coen ed Elaine May, per una serata intitolata Relatively Speaking. (All’epoca stavo scrivendo un profilo di Marlo Thomas, che appariva nella rappresentazione di May.) Il lavoro di Allen, Honeymoon Motel, era una farsa sul sesso un po’ forzata incentrata su un uomo di mezza età che sposava un’oca giuliva con grande disapprovazione della famiglia. Infilata nel testo c’era una battuta nauseante, come un topo morto nella dispensa. La battuta faceva parte di una scena, verso la fine della pièce, in cui una donna anziana di nome Fay annunciava, con tono di sfida, che la sua era stata l’infanzia peggiore di tutto il gruppo: in fin dei conti, diceva, suo zio Shlomo l’aveva molestata da bambina. Invece di mostrarsi empatici, gli altri si univano per canzonarla e alzavano gli occhi al cielo perché stava di nuovo raccontando quella storia e dando la colpa a un trauma vecchio come il cucco per la sua vita incasinata.
Nel mezzo della discussione, Fay insisteva in tono querulo sul dettaglio che la molestia era avvenuta con tre dita, invece di cinque. Sprofondata nella poltrona omaggio di quel teatro di Broadway, rimasi scioccata nel rendermi conto che la battuta riguardava l’esatto crimine di cui la figlia aveva accusato Allen – che, per essere espliciti, era di molestie con le dita: secondo la testimonianza fornita agli investigatori, le aveva toccato i genitali. (In una successiva intervista televisiva, Dylan avrebbe chiarito che Allen aveva usato un dito per toccarle la vulva e le labbra.) La pièce in sé era stucchevole, oscena e infarcita di riferimenti antiquati; non era chiaro quando Allen avesse scritto quella battuta, se decenni prima o più di recente. Eppure sembrava il segno indelebile di un disprezzo antico, un odio che era stato sintetizzato in qualcosa di più accettabile dal punto di vista culturale: una battuta.
Anche senza contare la storia di Dylan, la reputazione di Allen era ormai compromessa. Pure la mia opinione era cambiata, perché non ero più una ragazzina. Più invecchiavo, più ovvio mi sembrava che la relazione di Allen con la figlia della sua fidanzata di allora, Soon-Yi Previn, avesse un’origine predatoria. Il fatto che i due si fossero sposati e che avessero cresciuto dei figli non cancellava la sostanza dei fatti. Ciò che peggiorava le cose era il modo in cui Allen rispondeva, anche molti anni dopo, a qualsiasi domanda su quella storia dolorosa: sembrava giudicare l’intera faccenda come priva di fascino, molto poco francese, notizie vecchie; nelle interviste scacciava ogni riferimento alle ripercussioni subite dalle persone intorno a lui, inclusa l’idea di aver fatto del male ai fratelli e alle sorelle di Soon-Yi costringendoli a scegliere tra lei e la madre. Se provava qualche rimpianto, non lo dava a vedere. Il mio artista preferito mi era sembrato molte cose, ma principalmente un perfido narcisista.
Ciononostante, il mio film preferito di Allen era La rosa purpurea del Cairo.
Cosa dovremmo fare delle opere d’arte di uomini schifosi?
All’indomani delle rivelazioni su Harvey Weinstein, nell’era del #MeToo, anche rivolgere quella domanda è parso, in molte occasioni, come un tradimento della giustizia. Quando si sono finalmente aperte le cateratte nell’ottobre del 2017, a otto mesi dall’inizio della presidenza Trump, e quelle storie schifose hanno iniziato a venire a galla, sembrava che non si sarebbero più fermate: prima un uomo, poi un altro, poi un altro ancora. Sembrava lava fuoriuscita da un vulcano sotto forma di tutta la misoginia e gli abusi che la gente aveva ignorato, dappertutto, in ogni settore, ma soprattutto a Hollywood. Miracolosamente, quando le vittime facevano i nomi, i molestatori iniziavano a perdere il lavoro – un risultato che solo l’anno prima sarebbe parso inconcepibile. Per tutto l’autunno, mentre ero alle prese con la scrittura di questo articolo – nel quale avevo sperato di infilare la mia storia personale con le azioni di uomini schifosi – ogni giorno veniva fuori una nuova storia orrenda: Dustin Hoffman, Kevin Spacey, James Toback. Registi, comici, autori teatrali, coreografi, produttori di hip-hop, direttori d’orchestra, cadevano l’uno dopo l’altro (o venivano spinti, oppure, di quando in quando, si gettavano da soli) dal loro piedistallo. Le donne che li denunciavano erano figure eroiche, disposte a esporre in pubblico gli abusi subiti, spesso correndo enormi rischi personali. Non diversi erano i giornalisti che avevano aiutato a svelare il sistema marcio intorno a quegli uomini. Ce n’era abbastanza per distorcere le mie vecchie idee e riportare in superficie dai fondali oceanici alcune emozioni represse. Era difficile pensare. Era difficile sentire qualcosa. Era difficile fare il lavoro di critica senza che sembrasse una cosa veniale da intellettuale col monocolo, quando invece si sarebbe dovuto parlare di giustizia.
Ogni volta che ne cadeva uno nuovo, si alzava un pianto, ma anche un’alzata di spalle di presa di coscienza: quella gente doveva andarsene insieme alla propria opera. C’erano un sacco di motivazioni forti e pragmatiche a sostegno di quell’idea – appelli a «cancellare», «eliminare» il lavoro di quegli uomini schifosi, per usare la retorica estrema di Twitter. Alcune di queste ragioni erano economiche: bisognava affamare gli abusatori affamando il sistema che li produceva. Dare del denaro a Bill Cosby significava supportare Bill Cosby. Ma anche l’attenzione che gli si dedicava era un tipo di valuta. Pubblicare articoli su Cosby nelle riviste, o libri sul suo lavoro, o ancora guardare le sue serie per poi analizzarle, portava allo stesso risultato – era un modo per tirare a nuovo la sua leggenda, spostandola sotto i riflettori e in questo modo facendone schizzare il valore commerciale.
Per sanare un sistema marcio, secondo questa teoria, si rendevano necessarie scelte più radicali: bisognava abituare i propri occhi a cercare ciò che non era visibile, non ciò che era già sotto gli occhi. Quel momento aveva un’energia liberatoria vertiginosa, un’urgenza senza freni non solo di correggere, ma di riscrivere, ripartire da zero. Sarebbe stato meglio non concentrarsi sull’arte degli uomini schifosi, ma sull’altra arte, quella mai realizzata, e anche quella prodotta ai margini. Sarebbe stato meglio mettersi sulle tracce di chi era stato rifiutato da quei criminali che controllavano la macchina. Nell’autunno del 2017, quando queste idee iniziavano a dominare il discorso pubblico, mi facevano barcollare, mi facevano vergognare. Altre volte erano farina del mio sacco.
In quanto critica televisiva, comunque, sapevo che ogni volta che mi muovevo pubblicamente verso quella direzione, una parte recondita di me faceva privatamente, cocciutamente, sgarbatamente un passo indietro. Bramavo qualcos’altro, ed era ciò che i giornalisti bramano, e i detective e forse gli strizzacervelli, e i taccheggiatori e anche moltissimi artisti: accesso infinito, riconoscimento radicale, l’abilità vorace di infilarmi fino ai gomiti in qualsiasi ammasso di luridume, bere l’amaro calice fino in fondo. Non volevo cancellare l’arte prodotta da quegli uomini: volevo scarabocchiarci sopra in preda alla rabbia, alla confusione, e anche al piacere – renderla mia invece che loro. Questo valeva anche, e forse soprattutto, quando l’arte era una proiezione del comportamento dell’autore, come nel caso di Woody Allen. Per certi versi, questo impulso mi sembrava (e mi sembra ancora) semplicemente onesto: sarebbe da pazzi per me far finta di non aver mai visto Il dittatore dello stato libero di Bananas, Manhattan, La rosa purpurea del Cairo, Broadway Danny Rose o Io e Annie, non fare mai riferimento a questi film, non guardare il mondo o me stessa dalla loro prospettiva. (Era più facile farlo con i film più recenti di Allen, che avevo per la gran parte evitato.) Se non fossi stata una critica, forse sarebbe stato diverso. Ma un critico non può essere pulito: con lui i colpi di spugna non funzionano.
Per sopportare queste contraddizioni, o per meglio dire questi desideri, decenni fa avevo adottato un modo di ragionare personale, rigoroso e leggermente sociopatico, una specie di filosofia critica improntata a un mutuo egualitarismo. A volte persone perbene creano opere pessime. Figure amorali possono creare e hanno creato opere trascendentali. Un essere crudele ed egoista – persino un criminale – potrebbe realizzare qualcosa di generoso, seminale e umano. O magari qualcosa di talmente grottesco da non riuscire a distogliere lo guardo, pieno di contraddizioni che sono esse stesse magnetiche. La storia è piena di simili perversioni. Se gli artisti potevano compartimentizzarsi, be’, allora potevo farlo anch’io. In ogni caso, cancellare l’arte non mi sembrava una grande idea. Mi sembrava di tradire la mia stessa natura. Ma, ovviamente, come ogni altra forte convinzione, guardandosi indietro ci si accorge che era frutto delle contingenze. Ripensandoci, mi sembrava evidente che avessi passato la prima parte dei miei vent’anni a giungere alla conclusione che la cosa peggiore che si potesse essere era un censore. Da dove avevo tirato fuori quell’idea? Da convinzioni politiche che io stessa trovavo censorie, il che non era una sorpresa.
Ho fatto l’università alla metà degli anni Ottanta, dal 1984 al 1988, nella piccola facoltà di Studi umanistici alla Oberlin. (Cortesemente, mettete «Voices Carry» dei ’Til Tuesday mentre leggete questo paragrafo.) Eravamo all’apogeo dell’era reaganiana, nel mezzo di un incredibile scontro culturale. La campagna «Just Say No»1 di Nancy Reagan correva parallelamente alla decadenza trumpiana strafatta di coca. ACT UP2 furoreggiava nelle strade; il punk e l’hip-hop ribollivano ai margini; e tuttavia la maggioranza della cultura pop, inclusa gran parte della tv, era dominata da una viscida e compiacente celebrazione della ricchezza, tutta Lifestyles of the Rich and Famous e Material Girl, Dynasty e Vanity Fair. Era un’epoca asfissiante e graffiante allo stesso tempo. E ogni rivista patinata diffondeva il messaggio che il femminismo non era più necessario: adesso le donne erano avvocate in scarpe da ginnastica, problema risolto. L’attivismo era qualcosa di cui vostra madre aveva avuto bisogno, molto tempo prima, negli anni Settanta.
Ma d’altro canto c’era un tipo di femminismo che era ancora fiorente: il movimento contro la pornografia, rappresentato da un’organizzazione nominata Women Against Pornography, fondata sul finire degli anni Settanta. Per un breve lampo nel decennio seguente, che coincise con la mia prima maturità, questa avanguardia ideologica sembrava rappresentare l’ordine costituito del femminismo – anche se spesso è difficile da descrivere alle donne più giovani, poiché non trova posto facilmente nella teoria fondata sulle differenti «ondate» che viene impartita come storia del movimento. Le due leader della lotta contro la pornografia erano la ricercatrice di legge Catharine MacKinnon e l’attivista femminista radicale Andrea Dworkin, che aleggiavano sulla scena come due lune gemelle. La prima era quella glaciale, una super giurista laureata ad Harvard che aveva introdotto il concetto legale di molestia sessuale. Figlia di un giudice di destra e originaria del Midwest, si presentava in tv con dolcevita pastello e filo di perle, oltre a uno chignon che ricordava una riformista vittoriana. La Dworkin era invece quella selvaggia, una polemista del New Jersey che con il suo corpo obeso, le tute cascanti e i crespi ricci ebraici sembrava un dito medio rivolto ai mezzi di comunicazione degli anni Ottanta; il suo stesso corpo era un enorme vaffanculo al patriarcato, e inoltre sembrava incazzata e divertente in modo molto attraente, invece che cerebrale. Non riuscivo a smettere di guardare le foto che la ritraevano. Era una figura che incuteva timore e con un enorme potere emotivo, un feticcio per il disgusto culturale.
Le due si scagliavano, da lati opposti, contro l’oppressione del patriarcato. La violenza contro le donne, inclusa quella sessuale, era dappertutto, dicevano – normalizzata, banalizzata e ignorata dalla legge. Era l’aria invisibile che respiravamo. Io da quel punto di vista ero d’accordo: durante una manifestazione di Take Back the Night,3 ricordo la mia fiducia ingenua nel nuovo concetto di «stupro al primo appuntamento» che avrebbe rimodellato il sistema della giustizia in modo permanente. Ma nel 1984, nel mio anno da matricola, la Dworkin e la MacKinnon fecero fronte comune con la destra religiosa capeggiata da figure come Jerry Falwell e dall’attivista antifemminista Phyllis Schlafly. O perlomeno la loro retorica iniziò a sovrapporsi: la stessa proposta di legge scritta dalla Dworkin e dalla MacKinnon, che definiva la pornografia una violazione dei diritti civili delle donne, divenne la base per alcune proposte legislative al City Council di Indianapolis formulate da un attivista anti-ERA,4 che furono trasformate in legge dal sindaco repubblicano. Il fatto che fossero state successivamente revocate non importava. Nelle giovani femministe quello sviluppo inatteso aveva prodotto uno shock ideologico non differente da quello provocato nei miei nonni, che erano ebrei immigrati, dal patto Molotov-Ribbentrop tra la Russia di Stalin e il Terzo Reich: era grottesco e squalificante.
Bisogna tenere presente che tutto questo aveva luogo prima di internet, quando la stampa era ancora tutto ciò di cui si disponeva. I contenuti sessuali, su ogni mezzo di informazione, erano una relativa rarità, non facilmente accessibili al di fuori delle grandi città. E, storicamente, gran parte del materiale censurato riguardava il sesso omosessuale, considerato pornografico di default e che in diversi Stati era illegale. Per citare un esempio famoso, negli anni Ottanta e Novanta la dogana canadese bloccava i libri sulla sessualità omosessuale e lesbica provenienti dagli Stati Uniti definendoli «oscenità». Tutto ciò nella mia testa si sovrapponeva ai tentativi quasi simultanei di Tipper Gore di censurare i testi de...