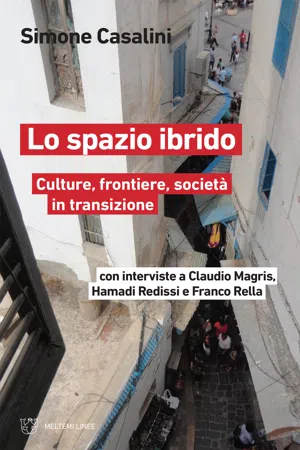![]()
Capitolo terzo
Tunisia, un laboratorio del mondo arabo
3.1 Sidi Bouzid, il ritorno della periferia
Il Café Samarkand è un porto premuroso che si trova a pochi isolati da avenue Bourguiba. Gli avventori si passano il testimone tra i tavolini, nei dialoghi echeggiano la politica e la vita comune. Qualche albero s’inchina ossequioso all’ingresso, mentre un sottile cortiletto laterale, un budello chiuso e scrostato preannunciato da un arco bianco, ordina pochi tavoli verde mare. Nelle tumultuose giornate che spinsero alla sollevazione Sidi Bouzid e poi, in un crescendo, la Tunisia, esiliando il dittatore Ben Ali, il Samarkand è stata la coordinata di confluenza dei manifestanti e degli intellettuali locali. Tutti i quartieri popolari della cittadina si sollevarono. Cité El Nour, Cité Khadra, Cité El Felaha e Tuille, dove la strada è uno sterrato rosso punteggiato da rifiuti e qualche pecora. Sussistenza quando c’è un granello di fortuna. A notte fonda si radunavano le espressioni della protesta e preparavano i cortei dell’indomani.
Slimane Rouissi siede nel budello, inclina la testa, spiega con l’ausilio delle mani. È un ingegnere, apprezzato docente di tecnica e presiede una commissione che si occupa di proteggere i giovani dalle prevaricazioni del potere. A lui la famiglia di Tarek “Mohamed” Bouazizi, il giovane ambulante di 26 anni che s’immolò per contestare gli abusi della polizia innescando la rivoluzione tunisina e i tumulti mediorientali, ha affidato la sua memoria. Lo zio di Tarek, Salah Bouazizi, gestisce una farmacia su avenue Bourguiba e, rimandando a Rouissi, consegna poche parole: “Mio nipote era stato marginalizzato come la maggior parte del popolo. Amava la vita e lottava per la vita, ma è finita così”. Salah è stato l’ultimo a sentirlo. Tarek lo aveva chiamato al cellulare in stato collerico, pregando di correre subito davanti alla sede del governatorato di Sidi Bouzid. Era il 17 dicembre 2010. Sei poliziotti – quattro uomini e due donne – gli avevano sequestrato la bilancia e la frutta perché privo della licenza di vendita. Una storia che si rincorreva da tempo e che accomunava tutti gli ambulanti. Gli comminarono anche 20 dinari (6 euro) di multa. Una poliziotta è stata incarcerata, accusata di averlo colpito con uno schiaffo, umiliandolo. Ma venne poi scagionata e rilasciata. Ma cosa accadde realmente? Per Lydia Chabert-Dalix, che ha ricostruito in modo minuzioso la sua vita e le ultime ore, si è trattato formalmente di un suicidio con un mandante morale: lo Stato. “È stato assassinato da un sistema corrotto fino al midollo”. Rouissi, invece, avanza un’altra ipotesi. “Quando gli sequestrarono la bilancia e la frutta, Mohamed cercò di contattare il sindaco e il governatorato senza ricevere risposta. Allora si recò in un negozio vicino e si procurò del solvente per vernici. Si cosparse i vestiti, ma l’accendino non funzionava. Probabilmente non intendeva uccidersi, ma compiere un atto dimostrativo. Una scintilla e le esalazioni che provenivano dagli indumenti lo trasformarono invece in una torcia umana” racconta Rouissi, fornendo dunque una versione differente da quella ormai accettata. Bouazizi venne ricoverato nel reparto grandi ustionati dell’ospedale di Ben Arous, dove ricevette anche la visita di Ben Ali, e morì il 4 gennaio 2011. Nel suo quartiere, Cité El Nour, all’indomani qualcuno scrisse su un muro una parola inequivocabile: “Martire”. E martiri sono diventati nel dibattito pubblico, aggirando l’interdizione dell’Islam, tanti giovani suicidi schiacciati dall’assenza di prospettive, dalla negazione della dignità. Dieci giorni dopo la morte di Bouazizi, Ben Ali decollò per l’Arabia Saudita avendo perso il consenso delle forze dell’ordine e della piazza. L’avvio della transizione alla democrazia si era compiuto.
Sidi Bouzid occupa il centro della Tunisia, ma dal 17 dicembre 2010 è diventata il centro del mondo arabo e di nuove variabili internazionali. Sidi Bouzid è essenzialmente una periferia, un meridione, un’area agricola depressa orlata di mandorli e olivi che esalta il ciclico contrasto tra le zone urbane e costiere e quelle rurali e dell’entroterra. La tragica fine di Bouazizi ha determinato il punto di collasso del sistema di potere. Prima di Mohamed altri due ragazzi si erano tolti la vita, a Monastir (in marzo) e Metlaoui (in novembre). Immolati con le medesime modalità, ma senza suscitare clamore. A Sidi Bouzid la propagazione dei tumulti è istantanea. Regueb, Menzel Bouzayane, Maknassy, Kasserine. E poi ancora Thala e Sfax. Secondo Yadh Ben Achour, “questo gesto sacrificale diviene il simbolo di riconoscimento di tutte le categorie sociali diseredate, in particolare le masse dei giovani disoccupati”.
A Sidi Bouzid si è riscritta la storia della Tunisia in un evento di pochi secondi, forse nemmeno intenzionale. E si è aperto il varco di una transizione che conferma la specificità tunisina nel contesto arabo. Ponte tra Oriente e Occidente, alchimista di sperimentazioni sociali e giuridiche ardite che non la collocano in uno scacchiere predefinito. Che il rovesciamento del destino politico autoritario si sia compiuto a Sidi Bouzid appare, solo a prima vista, un’iperbole. Quello di Sidi Bouzid è il governatorato che, in rapporto alla popolazione, presentava infatti “il più alto numero di aderenti al Raggruppamento costituzionale democratico (il partito di Ben Ali, N.d.A.)”, i quali “parteciparono alle manifestazioni che seguirono il suicidio”. Per Achour, “ciò offre un’idea contemporaneamente della fragilità del sistema e della portata dell’avvenimento rivoluzionario sulla vita politica in Tunisia”. La periferia ha capovolto il centro in un contrasto che esprime una retrospettiva profonda e che aveva avuto un segno premonitore nella mobilitazione dei bacini minerari di Gafsa nel 2008 dove “emersero alcune debolezze del regime benaliano”.
Hamadi Redissi ha osservato che “la rivoluzione si fonda su un duplice divario tra il litorale prospero e le aree interne deprivate e tra islamisti e secolarizzati”, ripercorrendo l’antica faglia “tra nomadi e stanziali e tra islam tribale e islam urbano”. Stefano Torelli parla di “una Tunisia a doppia velocità, o meglio di due Tunisie” e osserva che “secondo alcune interpretazioni l’attuale condizione di profonda disparità tra le regioni orientali e quelle occidentali è stata acuita dalle politiche governative e delle organizzazioni internazionali nel corso degli anni che hanno privilegiato le aree costiere a discapito delle altre zone” con lo scopo di garantire una “maggiore competitività a livello internazionale”.
A distanza di otto anni dai tumulti che hanno impresso una svolta anti-autoritaria alla parabola tunisina, c’è una sostanziale discordanza sulla natura di quell’evento e sulla transizione democratica. Achour non ha dubbi che si sia trattato di una rivoluzione in termini politici e sociali. “I tentativi abortiti del potere di riformarsi da un lato, e la permanente agitazione insurrezionale dall’altro lato, avevano posto il paese in una ‘situazione rivoluzionaria’ che rendeva fortemente possibile lo scoppio di una rivoluzione”. Insomma, nonostante “le tendenze ideologiche contraddittorie che si rivelarono in seguito”, quella che ha investito la Tunisia è stata una rivoluzione. Una c...