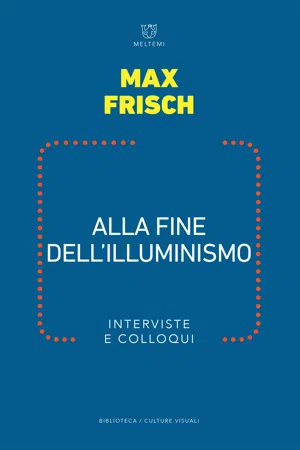![]()
La letteratura dovrebbe mettere
in evidenza le possibilità
(1984)
Fondata nel 1953 a Parigi e pubblicata con cadenza trimestrale a New York, la rivista letteraria “The Paris Review” propone ancora oggi, in ogni edizione, interviste con i più importanti scrittori contemporanei. L’elenco degli intervistati costituisce un vero e proprio “Who is Who” della letteratura anglosassone degli ultimi decenni, ma comprende anche i nomi di spicco delle altre letterature. La peculiarità della serie, che nel frattempo è diventata leggendaria, consiste tra l’altro nel fatto che i colloqui sono straordinariamente lunghi e permettono all’intervistato di esprimersi in maniera dettagliata sui motivi di fondo della propria scrittura.
Nel settembre 1984 la giornalista e scrittrice Jodi Daynard (1957) si recò a Zurigo per intervistare Max Frisch per conto della rivista. Nell’introduzione dell’articolo-intervista, la Daynard racconta che Frisch le aveva telefonato la sera del suo arrivo a Zurigo, dicendole che si sentiva poco bene e pregandola di rinviare l’incontro di alcuni giorni. L’intervistatrice ebbe così tempo di girare per Zurigo, il luogo dove viveva il suo intervistato e insieme lo sfondo delle sue opere letterarie. Il terzo giorno, Frisch andò a prenderla in albergo. Lo stesso Frisch avrebbe preferito fare l’intervista passeggiando in campagna, ma le cattive condizioni meteorologiche lo fecero optare per il suo appartamento. Lo scrittore non mancò di esprimere le proprie riserve nei confronti delle interviste: “Stone Age, Iron Age, Interview Age – it’s so vulgar. It’s not interesting to have these questions and answers. You must have a dialogue”. E in effetti fu un dialogo che durò tre giorni. La Daynard riferisce che il testo stampato (pubblicato solo nel 1989) ne contiene una piccola parte.
L’intervista venne realizzata e pubblicata in inglese. La traduzione tedesca è di Alexandra Steffes, il titolo è del curatore dell’edizione tedesca.
*
Jodi Daynard Vorrei cominciare con qualche domanda sul suo ultimo libro, Barbablu. Quando le è venuta l’idea di questo progetto?
Max Frisch Quando sono tornato dagli Stati Uniti e ho assistito a un procedimento giudiziario condotto da un mio amico. Il procedimento era iniziato proprio il giorno prima: si trattava di un caso di omicidio, un caso molto strano. Ho cominciato a seguirlo senza una particolare intenzione, ma poi la vicenda mi ha molto interessato, non solo per il caso in quanto tale – che è diverso da quello che racconto in Barbablu – ma per il linguaggio utilizzato nel corso del procedimento. Il fascino, ai miei occhi, consisteva nella ritualizzazione della parola. Nei tribunali domina sempre la medesima frase: “La verità e nient’altro che la verità”. Si chiede questo e quest’altro. Questa standardizzazione del linguaggio contiene elementi musicali o architettonici. Si pongono in continuazione sempre le stesse domande, in diverse situazioni. Più che la vicenda, è stato proprio il linguaggio ad avvincermi.
Jodi Daynard Leggendo Barbablu, si ha l’impressione che sia stato scritto rapidamente e con facilità. È davvero così?
Max Frisch Assolutamente no. In realtà, era lungo il doppio rispetto alla versione definitiva. Avevo la possibilità di scrivere un romanzo realistico, alla vecchia maniera, per conservare un quadro dettagliato dei personaggi, le loro varie caratteristiche, il loro ambiente e così via. Una cosa del genere avrebbe comportato l’inserimento di una quantità di testimoni e interrogatori, di modo che si sarebbe venuti a conoscenza della vita dei testimoni, dei loro pensieri, dei loro pregiudizi e delle loro malattie dell’anima. Ma non ero in grado di tenere insieme tutti gli elementi necessari. Melville lo ha fatto in Moby Dick, io non ci sono riuscito.
Jodi Daynard Si ha l’impressione che per lei i dialoghi siano importanti.
Max Frisch I miei primi tentativi di scrittura, quando frequentavo il ginnasio, furono testi teatrali, non racconti. La forma del racconto mi intimoriva. I miei primi interessi si sono rivolti al teatro, non alla narrativa. Tutto questo ha a che vedere con quanto ho accennato poc’anzi, vale a dire la fascinazione per il linguaggio dei procedimenti giudiziari, che consistono unicamente di dialoghi. Se racconto una storia, oppure descrivo un paesaggio, non ho la possibilità di utilizzare questo linguaggio ritualizzato.
Jodi Daynard Molti suoi personaggi, dopo Stiller, sono tecnocrati oppure uomini che non si mettono in discussione e forniscono una testimonianza molto arida della propria vita.
Max Frisch Sì, è vero, soprattutto nel caso di Homo Faber. L’intenzione era quella di descrivere un uomo che fornisce un’interpretazione piatta, più piatta di quanto sia in realtà la sua vita. Walter Faber nega le proprie esperienze, perché è del tutto incapace di esprimere i propri sentimenti, e quindi descrive se stesso nella maniera più superficiale possibile. La sua arroganza consiste nel non dire nulla, e si accorge troppo tardi che ci sono moltissime faccende che investono i suoi sentimenti. Penso che Stiller riveli molto di più relativamente ai propri sentimenti.
Jodi Daynard Anche in Barbablu il Signor Schaad dice: “Ciò che aiuta è il biliardo”. Non dice mai: “Sto soffrendo”.
Max Frisch Sì, è molto vero, ed è un aspetto che ha probabilmente a che vedere col mio personale modo di essere. Io ho sentimenti molti forti, ma non mi piace descriverli. Ci sono altri modi per rivelarli – il linguaggio del corpo, oppure il silenzio – e possono essere modi fortemente espressivi. E forse c’è anche una dif...