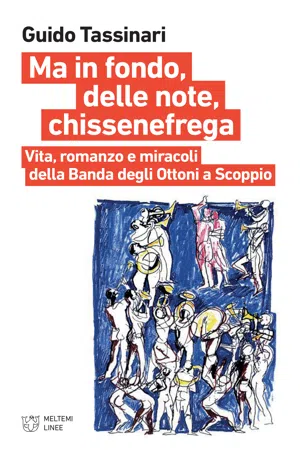![]()
Il Giro d’Italia
o: dove sarei mai andato senza banda? capitolo 1
La notte tutte dormeno,/ma io, che vuo’ durmìre!/Penzanno a Nenna mia/mme’ sent’ ascevulì./Li quarte d’ora sonano/a uno, a ddoje, a tre. I’ te voglio bene assaje/e tu nun pienze a me./I’ te voglio bene assaje/e tu nun pienze a me.
Ponte Lambro, si suonava per il centro civico, allora, forse ancora oggi, osteggiato da molti e frequentato da nessuno. Ho sognato tutto il tempo che fosse uno scherzo, che dietro l’angolo ci fossero i bambini venuti per sentire la banda, mangiare le torte, giocare. Proprio un brutto sogno.
Stavo ancora in giù, la banda venne a trovarmi, s’andò insieme a Sesto Fiorentino, anche molti amici coi figli. Centenario dei Moti del pane, si suonò all’Istituto de Martino, in una villa rinascimentale che il Comune di Sesto aveva dato per salvare l’archivio di etnomusicologia che Milano aveva sfrattato dopo la morte di Ivan della Mea, suo custode.
La fabbrica di Ivrea mi colpì. Tutti i macchinari spenti, solo guardarli faceva capire il rumore che ne sarebbe potuto uscire. Gli operai dentro con le mogli, forse qualche bambino. Sapevano che sarebbe andata la banda a suonare per loro, avevano preparato una manna, la prima volta che ho mangiato la pastiera napoletana. Credo ci fosse anche il coro, perché in quest’uscita ho conosciuto anche lamaria, ai tempi ancora non suonava. Lamaria mi raccontò cose, sulla banda, il coro, che altrimenti avrei scoperto molto dopo. Come prima uscita impressionante. Vedere tutti questi operai determinati, avrebbero passato la notte in fabbrica, la gioia nel sentire suonare mi fecero capire che difficilmente mi sarei allontanato. Era la mia dimensione ideale, un modo meraviglioso di portare solidarietà, comunicarla. Ne approfittai per parlare con gli operai, farmi raccontare del lavoro, orari, preoccupazioni. Essere lì con lo strumento un grande vantaggio, gli occupanti erano molto ben disposti verso la banda, parlavano volentieri. Dubito avrei potuto avere una possibilità simile in altre maniere. Ah, viaggiare!
Anche se sono fonti utili di cui non possiamo fare a meno, le mappe ufficiali serbano poche sorprese: le loro linee di contorno ci indicano dove sono i Balcani e sono ragionevolmente chiare sulla posizione di Cuba e della Palestina. Più preziose, però, sono le mappe inedite che tracciamo noi stessi. Della nostra città, della nostra casa, del nostro mondo quotidiano, la nostra vita; quelle mappe del mondo privato che usiamo ogni giorno: qui ero felice, in quel luogo ho perso la tromba, là ho incontrato il mio amore, lì una volta ho pianto, da lì ho visto il manicomio attraverso la nebbia. Cose del genere, i nostri ricordi personali che tessono l’arazzo della nostra vita. Le vecchie mappe hanno venti antropizzati che soffiano da guance sporgenti; ora sappiamo che il vento è semplicemente questione di isobare, la scienza rende le cose banali, ma l’amore, almeno, rimane un mistero. Perché esiste, come cura il respiro trasformativo quell’amore, quel vento gentile, che soffia la sua via di guarigione attraverso le nostre vite.
![]()
Quattro funerali e un matrimonio
che anche avere un canale radio di pettegolezzi,
micacazzi
Nkosi Sikeleli Africa/Malup hakanyiswu phondolwayo/Yiswa imithanda zo yethu/Nkosi Sikelela Thina lusapolwayo/Morena boloka setjaba sa heso/O fedise dintwa le matshwe ne ho/Morena boloka setjaba sa heso/O fedise dintwa le matshwe ne ho/O seboloke O seboloke morena/O seboloke/Se tjaba sa heso/Se tjaba sa Africa.
Avevo dodici anni, andai ai funerali del papà di un’amica. Operaio, aveva fatto la guerra, frequentava la sezione del quartiere Calvairate del Pci, ma non si poteva dire un personaggio. Al corteo funebre c’erano centinaia, bandiere rosse, una banda suonava canti comunisti, libertari, resistenziali, internazionalisti. Mi ero dimenticato di quell’episodio, ma se dovessi spiegare perché sono diventato anch’io un rosso, direi per quel giorno: i colori, la musica, i pochi musi lunghi; la condivisione della vita e della morte. Vent’anni dopo, abitavo a New York, andai ad ascoltare una banda di una chiesa battista; per statuto, suonavano ai funerali del quartiere, per rispettare un versetto del vecchio testamento: te ne andrai accompagnato da un gioioso fragore. Suonavano brani gospel, tutti alla stessa maniera: partivano due, tre, poi gli altri, crescendo di volume fino ad arrivare a un unisono sul fortissimo. Quindici tromboni, una tromba, tre percussioni, e basta; mai sentito un suono tanto voluminoso prodotto senza amplificazione, dei concerti più belli.
Più di quanto vorremmo, veniamo chiamati a funerali. Ho sempre pensato che sia una delle cose belle che facciamo, anche se a volte ci portiamo gli strumenti ma non suoniamo nemmeno, una volta lì decidiamo che non sia il caso, che disturberemmo; altre volte siamo così bravi che riusciamo a ricreare quello che vidi a Calvairate da bimbo. Come al funerale di una nostra bambina, in assoluto la cosa più triste alla quale abbia mai partecipato e il pezzo che preparammo per l’occasione, E l’era tardi, non lo voglio più suonare perché mi fa piangere. O a quello del sindaco di Torchiera.
Qualche giorno prima della morte di Luigi Zedda un gruppo era in ospedale a salutarlo. Alla Baggina è vietato suonare ma nel reparto di malati terminali è concesso un po’ tutto, ce lo confermò il primo vecchio incontrato nel corridoio in sedia a rotelle con due nazionali senza filtro accese contemporaneamente. Suonammo piano come mai la banda riesce. Entrati nella stanza, raggiungemmo il letto di Luigi. Era ridotto a pelle ossa metastasi, irriconoscibile, riducemmo ulteriormente il volume, paura che risentisse delle vibrazioni. Era contento di vederci e sentirci ma nel letto affianco c’era un vecchietto che si mise a piangere. Interrompemmo, pensavamo si fosse emozionato, non volevamo che ci schiattasse lì, diciamo. Chiacchierando con una parente scoprimmo che aveva subito un intervento al cervello, gli avevano dovuto asportare un osso cranico tra la tempia e l’orecchio, non aveva protezione ai suoni e alle vibrazioni; piangeva dal dolore che la nostra musica gli provocava, una mitragliatrice nel cervello, altro che emozioni. Nessuno ci aveva avvertito, giuro, neanche la caposala con la quale avevamo preso accordi. In quel periodo la stanza di Luigi era l’unica a essere piena di visite. Tanti del Torchiera, noi, il signore Alfredo; mancavano solo gli zingari e il pirata con vascello. Un via vai che per un personaggio come Zedda non so che idea si fossero fatte le infermiere. Fino al giorno della sua morte ha ricevuto attenzioni; oraziotuttofare con un po’ del Torchiera fece una cosa commovente: la casa di Luigi gliel’aveva rimessa proprio come Luigi voleva che fosse, spostato la stufa di fianco al letto, rimesso a posto la cucina, il lampadario, il quadro appeso, i gerani sul davanzale, come se Luigi fosse pronto a tornare da un momento all’altro. Quella sera con la banda i lavori erano appena stati terminati, gli si aveva portato le foto per sapere se era soddisfatto. Non so bene cosa riuscisse a vedere, provava a mettere e togliere gli occhiali, in ogni caso il cervello non lo aveva perso e si rendeva conto di tutto. Borbocchiava, burbero sardo, ecco! Oh! Ohmmamammia! se non me ne vado m’ammazzano! Tra le visite era attesa una speciale: la figlia dalla Germania, non si vedevano da venti anni. Quando siamo usciti in processione, una quindicina, erano stretti in un abbraccio cosmico di lacrime urla da pelle d’oca; La Carrà avrebbe pagato oro per riprenderlo. La sera i parenti di Luigi in Torchiera a vedere la sua casa, catapultati in una realtà di affetti e di gente intorno a lui che non si sarebbero mai aspettati. Seguivo in disparte la figlia di Luigi tra le stanze della cascina, le foto di Argo, la Ford parcheggiata nell’orto, questa seconda vita. Ricordo una frase be’ mi rendo conto che qui mio padre è stato amato e rispettato, non avrei creduto. Pochi giorni dopo il vecchio Zedda morì e nella corte del Torchiera intorno alla sua bara c’era gente, tanta tanta, una processione enorme. Al Musocco le vedove con in mano i fiori si avvicinavano sorprese, una banda, bandiere della Sardegna chiedevano ma di chi è il funerale? di Luigi Zedda; ah pensavo fosse qualcuno di rinomanza cittadina certo signora, Luigi era il sindaco del Torchiera! ah.
Milano pullula di sindaci. Persone le cui vite non raggiungono molto in termini di risultati. Non vengono celebrate o festeggiate in alcun modo. Ma esistono, cercano di farlo al meglio, mostrando gentilezza, non truffando nessun’anima, partecipando al bene comune con la loro nuda vita. Le loro morti ci lasciano vuoti, un vago senso di colpa; al pensiero di averle scansate, non averne contraccambiato la simpatia, non averle mai invitate a una cena fuori della loro buca, non averle mai riconosciute amiche, non averle mai detto di godere della loro compagnia, non avere mai detto che erano buone persone; non avere dato un segno chiaro di apprezzare la loro vita. Viviamo di errori, in continuazione. Le parole che avremmo dovuto dire restano non dette e non dette resteranno per sempre. Saggezza, chissà, è riconoscerlo prima che sia tardi. Ma spesso lo è, l’era tardi; ci rimangono solo cicatrici nel cuore.
Poi, accompagniamo gli anniversari dei martiri del movimento operaio e anarchico. Per Claudio Varalli ci trovammo a suonare sax contralto, tenore, e io, clarino, che sapevo solo le voci di accompagnamento. Tutto assurdo, in piazza Cavour, di giorno, suonare senza melodia. Ancora di più la sensazione di essere soli, la piazza piena di passanti era come vuota, oltre a noi nessuno ricordava.
Poi, a volte cantiamo; pure cose che, strettamente, non avrebbero nessun senso, tipo Nkosi Sikeleli, l’inno dell’ANC, ora inno nazionale sudafricano.
Sui giornali si parla di milioni di persone attese nelle strade e nelle piazze di tutto il mondo a festeggiare il famoso capodanno del Duemila. La banda, per un abbaglio collettivo tutt’oggi incomprensibile, decide di affrontare il nuovo millennio in un paesino sperduto nella alta montagna della Basilicata. Arriviamo così a San Fele, ottanta abitanti in tutto, un freddo pazzesco, sei gradi sottozero. La spedizione è composta per l’occasione da musicisti e amici per un totale di ottanta, io con la fisa. Arrivati facciamo un giro suonando per saggiare il terreno. Ottanta pari, se la giochiamo? Invece il paese è semideserto, non ci caga nessuno, i pochi guardano attoniti. Dormiamo per tre giorni ospitati in una scuola, rullantedue per tre giorni di fila spara petardi dentro. Ancora oggi mi domando perché; rullanteuno senza farsi domande, risponde al fuoco rilanciandogli addosso i petardi accesi. Dopo il cenone arriviamo alla festa. Suoniamo davanti a due ragazzine, cinque ventenni, tre adulti e due dei sette vecchietti del paese. Molto prima di mezzanotte venne a trovarci una qualche autorità con tanto di bandana tricolore, portando dei panettoni stagnanti, contributo dell’amministrazione comunale alla festa. Io penso a Barcellona. La festa finisce nel solito delirio anarcomusicalepunk con amici. Il primo ricordo del nuovo millennio è la faccia di grancassa a fianco di piatti che dorme sotto la protezione della statua della madonna. La mattina del primo dell’anno due signori vengono in ...