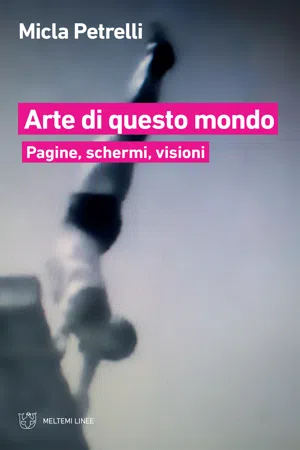![]()
Capitolo quinto
Oltre la pagina.
Il display e la luce segreta del libro
“Non si può leggere in due luci al contempo” (Marguerite Duras)
Credo sia potuto accadere ad ognuno di noi, almeno una volta, di essersi disposto alla lettura di qualche pagina di un libro pieno di promesse, all’aria aperta, in piena luce, e di non essere riuscito a leggere. Insomma, dinanzi ai ripetuti tentativi, alle riprese della frase, la pagina è sembrata ogni volta sfuggire alla presa, sottrarsi con ostinazione, e le parole dileguarsi. Quello che doveva essere, almeno nelle intenzioni, un momento di riconciliazione della dimensione individuale e privata della lettura con la sua controparte naturale e sociale si è rivelata una irritante esperienza di disagio e di inadeguatezza. O meglio, di rifiuto: il libro pare ci respinga. A tal punto da chiederci chi sia responsabile di tale impossibilità di una lettura alla luce diffusa del sole. È la semplice deconcentrazione del lettore, la cui attenzione è stata momentaneamente distolta da questioni più imminenti, che non consente di ragguagliare i caratteri tipografici della pagina intorno ad un percorso di senso, oppure è quell’autore, quella particolare scrittura – per un suo interno mal funzionamento o per la debolezza della sua presa – a far saltare i meccanismi che agguantano e in genere tengono magneticamente chi legge dentro le maglie di una storia, di un’atmosfera visiva o di un pensiero espresso?
Marguerite Duras intuisce le ragioni di tale fenomeno volgendo lo sguardo al proprio vissuto, e annota:
Raramente ho letto sulle spiagge o ai giardini. Non si può leggere in due luci al contempo, quella del giorno e quella del libro. Si legge alla luce elettrica, la camera in ombra, solo la pagina illuminata.
Due luci, dunque, secondo Duras, paiono contendersi lo stesso piano di riflessione che è la pagina di un libro. La luce del giorno illumina la pagina, ma indistintamente anche ciò che le sta dietro e intorno, è una luce indiscriminata, che si abbatte su tutto con la stessa indiscreta omogeneità, una luce solare che inghiotte ogni cosa, anche le zone d’ombra che i corpi pure proiettano. È una luce i cui raggi rimbalzano sulla superficie della pagina e la inceneriscono. C’è però una luce del libro, pare suggerire la scrittrice, più delicata e intima, che in tutto questo dispendio solare soccombe. È la luce che la pagina scritta promana, che si genera all’interno della relazione esclusiva tra lettore (lo sguardo del lettore) e caratteri tipografici, parole che paiono ora avere la concretezza di figure a rilievo, emergenze scultoree, su uno sfondo, piano, a contrasto. Seppure abbia poco a che vedere con una luce descrivibile secondo parametri fisici, questa luce è pur sempre luce percepita, se è vero che riusciamo a leggere anche in condizioni di illuminazione esterna assai sfavorevoli.
L’espressione “luce del libro” è qui, certo, adoperata per suggerire anche una dimensione interna alla parola, più legata alla sua capacità di emettere immagini, di sprigionare un significato visivo, immaginifico. Nel gioco di vuoti e pieni della pagina scritta si installerebbe un sistema di illuminazione dall’interno che consentirebbe a tutte le immagini in quanto tali di organizzarsi nello spazio psicologico del lettore. Ma la luce del libro è anche la luce elettrica che proietta un fascio proprio su quella pagina, lasciando la camera in ombra, un faro puntato sull’attore e che lo astrae dal resto, orientato a far esistere sulla scena esclusivamente ciò deve essere visto.
Ecco, questa è la luce alla quale si deve leggere: una luce particolare, che agisce mossa da una sorta di principium individuationis, che crea le condizioni per cui la pagina si accenda dall’interno, senza correre il rischio di venire polverizzata o rimanere schiacciata sullo sfondo di una spiaggia o di un giardino. In questo scenario, proprio come nel teatro o nel museo, la realtà è la pagina (la scena, la tela), mentre la spiaggia o il giardino (l’edificio che ospita la rappresentazione, il muro su cui poggia la tela) sono l’irrealtà. E tra le due dimensioni non può che esserci una radicale discontinuità: “Dalla terra che calpestiamo alla terra dipinta non è possibile passare gradualmente”, ci dice José Ortega y Gasset, cosicché “le tele dipinte sono buchi di idealità perforati nella muta realtà delle pareti, anguste imboccature di inverosimiglianza alle quali ci affacciamo attraverso la benefica finestra della cornice”.
Un altro scrittore, il nordamericano Paul Auster, descrive con straordinaria efficacia l’effetto nullificante sulle cose di una certa insistente luce solare:
[…] ne ha abbastanza del sole della Florida – che adesso, dopo lungo studio, ritiene più dannoso che utile per l’anima. Secondo lui è un sole machiavellico, un sole ipocrita, e la luce che irradia non illumina le cose, ma le oscura – accecandoti con il suo fulgore continuo, troppo intenso, che ti batte addosso con vampate di vaporosa umidità, destabilizzandoti con i suoi riflessi simili a miraggi e con le onde barbaglianti di nulla. È tutto brillii e luccichii, ma non reca sostanza, né tranquillità, né tregua.
Ma oltre a certe condizioni, potremmo dire, ambientali, vi sono una serie di fattori che possono interdire la lettura “profonda e bianca”, come la definisce Marguerite Duras; tra di essi, la rapidità del gesto mentale, ad esempio, volto esclusivamente ad introdursi nel racconto e a raggiungere i suoi snodi decisivi, che porta a consumare il testo,...