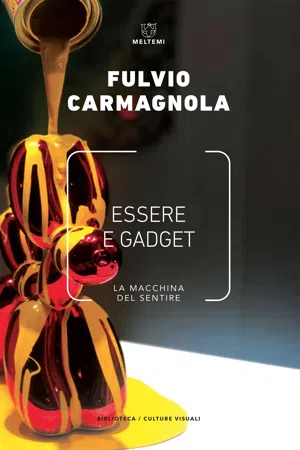![]()
Capitolo sesto
La macchina
Una macchina dei nostri giorni
non ha nulla a che vedere con un utensile
Jacques Lacan
In quest’ultimo capitolo vorrei presentare le seguenti ipotesi:
1 – La macchina del sentire è il dispositivo operativo dell’economia dell’immaginario;
2 – L’economia dell’immaginario è uno specifico campo dove agiscono forze di duplice natura;
3 – Tutti i prodotti o le merci prodotte dall’economia dell’immaginario rispondono in qualche misura alla nozione di “beni simbolici”, eredi contemporanei del feticismo marxiano;
4 – L’economia dell’immaginario risponde però a un regime differente da quello del Moderno, che coniuga la finzione e l’economia;
5 – I beni cosiddetti simbolici incorporano una forma di libido sociale che genera plus-valore e insieme plus-godere;
6 – Lo fanno attraverso forme di fiction/fantasy descrivibili come miti;
7 – L’economia dell’immaginario distribuisce diversamente il potere.
Infine, vorrei suggerire che in conseguenza di questa situazione sarebbe necessario mettere in discussione la nozione stessa di valore d’uso come cardine intorno a cui far ruotare tutta la dimensione critica.
Partiamo da una constatazione che è già presente nel testo marxiano: la determinazione del valore in base all’astrazione del tempo di lavoro non riesce a spiegare l’economia capitalistica. Non era sufficiente già all’epoca dei Grundrisse, ma questo fatto era pensato da Marx entro la dinamica di una contraddizione fondamentale interna all’evoluzione stessa del sistema di fabbrica, con lo sviluppo dell’automa-sistema di macchine. C’è un immateriale che il pensatore tedesco interpreta come general intellect, e il general intellect è la base necessaria per la liberazione delle forze produttive da un potere del capitale diventato obsoleto. Lo sviluppo delle forze fa saltare la misura, la commisurabilità generale o symmetria.
Qualche anno fa, André Gorz rifletteva appunto sul carattere dell’immateriale, ma aggiungeva un’altra considerazione: c’è un immateriale-cognitivo, “il cui valore è impossibile da determinare” (Gorz 2003). Lo studioso francese individuava qui un’altra, anzi “la principale fonte di valore”. A una condizione: quella di estendere la knowledge oltre il modello marxiano, per includervi “conoscenze” in senso lato, non strettamente legate alla produzione. Si tratta appunto di investire la merce nelle nuove considerazioni sul valore, di farne il punto di valorizzazione principale. Quale valore?
un valore simbolico non misurabile che prevale sul suo valore utilitario e di scambio. […] un valore artistico o estetico, sociale ed espressivo. La marca deve funzionare allo stesso modo della firma di un artista famoso (Gorz 2003, p. 45).
Vorrei enfatizzare il rapporto tra “la marca” – il Brand – e la presunta “non misurabilità” del valore. Se seguiamo questa significativa traccia, bisogna estendere la nozione di “immateriale” al di là del rapporto lavoro/conoscenza/tempo, e investire l’altro estremo: merce/consumo/immagine, cioè il campo del Brand. Pare che Gorz associ alla “marca” una sorta di sovrappiù, un valore simbolico, esterno all’economico, anzi addirittura precedente – alla stessa stregua dell’uso, nel paradigma marxiano. E questo valore distinto dall’economico, sarebbe “artistico o estetico”. Ma è davvero un altro valore? Gorz parla infatti di un “valore simbolico non misurabile”, e che tuttavia può essere preso in considerazione dall’economia.
In realtà questa seconda sfera del valore non è semplicemente artistico-simbolica. È vero che non è misurabile, se la misura è il tempo. Ma comunque implica processi di valorizzazione che non sono ricavabili dalla teoria del valore marxiana perché non hanno la loro sede nel processo lavorativo ma precisamente al polo opposto, la merce appunto.
Per raccogliere il punto di vista di Gorz è necessario estendere e nello stesso tempo modificare le sue affermazioni, evitando la contrapposizione tradizionale tra l’economico = misurabile, e il “simbolico” = non misurabile. Si tratta di assemblare in modo differente le due affermazioni che ho ricavato dal testo dei Grundrisse e dal primo capitolo de Il Capitale.
C’è, effettivamente, una macchina-automa collettiva che comprende “pezzi” fisici e immateriali. Questa macchina non produce solo conoscenza. Se consideriamo insieme il modello della macchina dei Grundrisse e la teoria della merce-feticcio de Il Capitale abbiamo i contorni dello scenario produttivo del presente e della sua effettiva discontinuità rispetto al Moderno.
Nello scenario del presente c’è una imponente produzione di (plus)valore, nel senso marxiano, e dunque effettivamente economico (e non “simbolico”), che sfugge alla determinazione del plus-valore attraverso il tempo di lavoro. È una dimensione immateriale, ovvero non deriva dalla manipolazione diretta della materia-natura. Questa produzione di valore è complementare a quella dell’economia della conoscenza prospettata da Marx. In analogia con la nozione di general intellect, si può ipotizzare che questa economia sia all’insegna di una macchina produttrice di general feeling. “Generale” nel senso di non personale, non individuale, anonimo, diffuso. Bisogna pensare a un secondo “automa”, a una seconda macchina che produce valore proprio attraverso la parvenza, lo Schein. Proprio nell’erede di ciò che Marx chiamava feticismo risiede il potere di questa seconda macchina.
Si può pensare l’economia politica attuale – processo di produzione di valore – come l’accoppiamento strutturale delle due macchine, attive ai due poli della produzione e del consumo. L’economia della conoscenza o capitalismo cognitivo non è l’intero scenario: c’è un’economia che investe la libido, i flussi sociali di desiderio che attraversa...