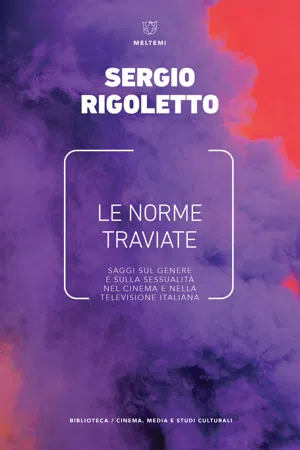![]()
Capitolo sesto
Il fascino discreto di Chiamami col tuo nome
e gli spettri della storia universale
C’è un motivo ricorrente nelle recensioni e nei dibattiti che sono emersi attorno a Chiamami col tuo nome. Si tratta di un ritornello che è stato ripetuto in maniera estenuante e che, proprio per questo, merita la nostra attenzione. Il ritornello recita grosso modo così: si informa il lettore che Chiamami col tuo nome è una storia d’amore omosessuale tra due uomini ma che tale dettaglio è poco importante perché questa è, in fondo, “una storia universale”. Nella sua recensione sul film, Alissa Wilkinson afferma che “chiunque può identificarsi con i suoi protagonisti e con quello che sentono”, mentre sulle pagine de “il Giornale” Serena Nannelli scrive che “la storia al centro della scena è tra due uomini ma, nella sostanza, universale e raccontata con delicatezza tale che chiunque possa immedesimarvisi”. Non è difficile intuire nelle parole di Wilkinson e Nannelli l’impressione che una storia d’amore omosessuale sia, per definizione, di poco interesse per il grande pubblico, un pubblico che viene di fatto immaginato come generalmente eterosessuale. Secondo Wilkinson e Nannelli, Chiamami col tuo nome trascenderebbe la propria specificità – una specificità che sarebbe normalmente rilevante solo per un pubblico omosessuale – sulla base di un registro di identificazione affettiva universalmente inclusivo (“chiunque [può] immedesimarsi”).
Che ne resta di questa specificità, ridotta a un grado di irrilevanza universale, e che valore darvi? Si tratta di domande che sembrano pertinenti per un periodo, quale quello attuale, in cui un numero sempre maggiore di storie a tematica omosessuale sembra destinato a trasmigrare dalla periferia al centro, ottenendo accesso a canali di produzione e distribuzione mainstream, e raggiungendo un considerevole successo critico e commerciale: si pensi, per esempio, a film come Moonlight (Barry Jenkins, 2016), vincitore di un Oscar come miglior film, La vita di Adele (La Vie d’Adèle, Abdellatif Kechiche, 2013) o I ragazzi stanno bene (The Kids Are All Right, Lisa Cholodenko, 2010). L’accesso al mainstream, come è stato spesso notato, sembrerebbe richiedere dei compromessi, dietro i quali si nasconderebbe il tradimento di una verità – di una “storia autentica” – sulle esperienze delle minoranze che il mainstream tenderebbe inevitabilmente a riappropriare. Nell’affrontare la questione in questi termini si corre il rischio di partire dalla supposizione (potenzialmente sbagliata) che le storie minoritarie appartengano di diritto alla “periferia”: alla produzione culturale politicamente radicale, d’avanguardia o di nicchia. L’importante studio di Alexander Doty sui sotto-testi e sui possibili posizionamenti spettatoriali queer del cinema hollywoodiano sembrerebbe mettere in dubbio una tale supposizione. Il nostro punto di partenza è però quello spazio periferico di resistenza agli assunti eteronormativi del cinema mainstream che una certa tradizione di cinema radicale – da Rainer Fassbinder a Pier Paolo Pasolini, a Barbara Hammer, a Todd Haynes e al New Queer Cinema – ha rivendicato sin dagli anni Settanta. Si tratta di una tradizione che ha re-immaginato le forme del desiderio e la corporeità, spesso in maniera provocatoria e apertamente polemica nei confronti del mainstream. Questa tradizione ha influenzato fortemente la critica queer e rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per ogni riflessione sul cinema a tematica omosessuale.
Il riconoscimento diffuso di un’esperienza universale in un film che tratta di amore omosessuale sembrerebbe la prova evidente di una nuova epoca di liberale benevolenza e accettazione nei confronti delle esperienze LGBT sul grande schermo. I proclami universali, però, hanno spesso delle ambizioni “universalizzanti”. Animati dal desiderio di andare oltre il particolarismo, questi proclami non hanno un valore puramente descrittivo, ma producono essi stessi le condizioni che dichiarano di descrivere. In questo caso, l’idea che certe differenze siano irrilevanti e che quello che veramente conta è ciò che gli esseri umani hanno in comune. Sarebbe troppo semplice limitarsi a criticare tali proclami, mostrando le esclusioni e i silenzi che si celano dietro a ciò che ci viene presentato come universale. Vale la pena però chiedersi se Chiamami col mio nome possa essere considerata una storia dal valore universale in un altro senso: non per l’irrilevanza della condizione omosessuale, ma per la funzione centrale che questa condizione sembra avere nel film. È l’ipotesi che si cercherà di sviluppare in questo capitolo, ripensando il concetto di universalità e proponendo una particolare versione di tale concetto che, invece di essere svuotato dell’esperienza della differenza, viene definito proprio da e attraverso questa.
Implicito in tale ipotesi è il sostenimento della validità teorica e politica dell’equivalenza omosessualità-differenza. Si tratta di un’equivalenza potenzialmente problematica, che si trascina dietro gli spettri di quei discorsi scientifici e giuridici che hanno, per lungo tempo, patologizzato il desiderio omosessuale proprio per il suo differenziarsi da una presunta norma di comportamento psico-sessuale. Se, in questa prospettiva, “differenza” equivale ad “anormalità”, non sorprende la tendenza, evidente in molte recenti campagne anti-omofobia, a voler normalizzare il desiderio omosessuale “equiparandolo” a quello eterosessuale. L’equivalenza è strategica in quanto sottintende un’aspirazione a un piano etico di sostanziale uguaglianza (con chiare implicazioni politiche, legali etc.) che di fatto mette in secondo piano le specifiche pratiche sessuali – incluso il loro valore simbolico – e dinamiche di identificazione/desiderio che distinguono l’omosessualità dall’eterosessualità. È proprio questo valore simbolico che interessa recuperare e, nello specifico, un discorso pubblico sulla figura dell’omosessuale (maschio) e un certo tipo di comp...