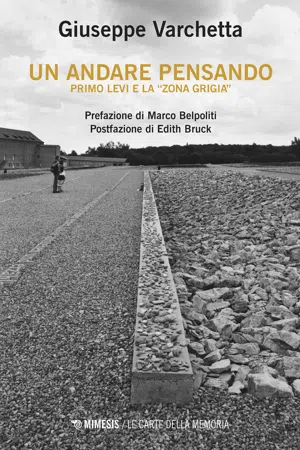![]()
Un andare pensando
Primo Levi e la “zona grigia”
![]()
Testimoniare,
comprendere
Primo Levi pubblica Se questo è un uomo nel 1947.
I sommersi e i salvati è pubblicato da Primo Levi nel 1986; trentanove anni dopo la pubblicazione di Se questo è un uomo.
Primo Levi è uscito da questa vita la mattina dell’11 aprile 1987; la morte di una donna e di un uomo è un mistero non spiegabile, che occorre apprendere e rispettare: chi resta in questa vita può solo continuare ad ascoltare.
Si ritorna a Primo Levi, reiteratamente, per il suo essere autorevolmente al centro delle tensioni più peculiari che hanno caratterizzato l’esperienza umana del ’900.
Se questo è un uomo è il libro che narra e testimonia una esperienza limite: una vita rubata, strappata a un giovane uomo privato di ogni relazionalità, costretto a una mera spazialità intrapsichica, ridotta ad un autismo meramente biologico.
In un libro testimoniale – l’autrice è stata internata ad Auschwitz pressoché bambina – si può leggere ed essere rimandati creaturalmente a Auschwitz, anus mundi:
Io la tiravo per le braccia per strapparla al suo dolore. Mi supplicava di non perdere di vista mio padre che si allontanava sempre di più e che lei non poteva più vedere perché era senza occhiali. Poi mi urlò in faccia: – L’hanno portato via, e anche Laci e Peter non li vedremo mai più. – Rimanemmo mia madre, Eliz e io. E sempre ci spingevano avanti. Vidi strappare dalle braccia di mia cugina la sua piccola bambina e mi chiesi se questa era la fine. Non credevo che in questo o in quell’altro mondo potesse esistere un inferno simile.
Quel giovane uomo ebreo, “sepolto” per un anno nel baratro di Auschwitz, per circostanze uniche, particolari – il suo essere un chimico e il conoscere un po’ di tedesco – accanto a terribili sofferenze psicofisiche, vive anche “una condizione di spirito eccezionalmente viva”, con la possibilità di osservare, registrare in memoria quanto di straordinario, impensabile nell’orrore gli accade intorno e lo obbliga, al suo ritorno, “salvato”, a raccontare, a testimoniare. Per Primo Levi ostacolare l’oblio, mantenere viva la memoria, testimoniare in tutte le occasioni possibili, è una ragione di vita. Primo Levi è “un tipo perfetto di testimone, …, non si sente scrittore, diventa scrittore unicamente per testimoniare”.
Se Auschwitz, e in generale il lager nazista, resta non narrabile, non pensabile in sé, la testimonianza di Levi – veramente umano è solo colui che testimonia del non umano (Agamben 1988) – diventa peraltro la missione della sua vita, capace di donargli insieme maturità e ragione d’essere. Levi sottolinea come, nella misura nella quale il Lager e la sua esperienza siano impossibili da comprendere, urga e non sia rinviabile, non evitabile, la necessità di conoscere e, di conseguenza, il dovere di testimoniare: “se penso alla mia vita e agli scopi che mi sono prefissi, uno solo ne riconosco ben preciso e cosciente, ed è proprio questo, di rendere testimonianza”. Quello che è accaduto laggiù, nel lager, può riemergere, riaccadere e, lungo questa laica profezia, non è lecito dimenticare, non è lecito tacere. Vi è il rischio che, trascorsa una generazione, nulla resti al di fuori della parola della testimonianza: “ultimo, fragile argine di fronte alla sopraffazione del nulla”. Se si considera, anche ex post, l’esigenza nei primissimi anni del secondo dopoguerra di ricostruire una cultura civica in un Paese come il nostro, con le ferite ancora aperte, generate dalla grande epopea della Resistenza, e appena uscito e dalle miserie del regime fascista e da una sconfitta tanto umiliante quanto distruttiva, il “riprendere in mano – ‘anche attraverso la testimonianza della realtà concentrazionaria’ – il tema dell’accoglienza e dell’assistenza ai reduci e osservare più da vicino quello che accadde agli ebrei italiani dopo la liberazione dai Lager aiuta a mettere a fuoco le contraddizioni di un paese sconvolto dal conflitto e dalla guerra civile che tentò di andare avanti senza guardarsi indietro”
Testimoniare transita dal ricordare, in altre parole da un significato di eventi, accadimenti del passato, rivissuto anche a lunga distanza di tempo, lungo la traccia di una peculiare visione del mondo e, nel caso dei sopravvissuti, all’orrore della Shoah, di una specifica, personale concezione di cosa sia un essere umano. Gli esiti del testimoniare possono essere così diversi, anche lontani se non antinomici e, in ogni caso, peculiari alle voce narrante.
Primo Levi e Elie Wiesel sono due icone della memoria ebraica e della testimonianza dell’orrore della Shoah. Hanno vissuto la stessa segregazione ad Aushwitz, attraverso purtuttavia esperienze diverse, elaborando una memoria e una testimonianza profondamente lontane, se non opposte fino generare un vissuto straniante, il disorientamento di una “memoria divisa” (Contini 1997).
Elic Wiesel colloca l’esperienza della Shoah in una dimensione religiosa, trascendentale, rinviante all’abbraccio di un Dio lontano/vicino l’ultimo respiro delle vittime innocenti e collocando il testimone in una prospettiva sacrale.
Primo Levi colloca la Shoah in una interpretazione laica e dentro un incessante lavorio della memoria, fino alla lacerazione di fronte al tabù, alla impossibilità, alla indicibilità: in fondo al tunnel mnemonico si incontra la “zona grigia”, l’aspetto più oscuro della realtà del lager. Primo, Levi non sorretto da alcuna istanza religiosa, testimonia la non innocuità del circolo della memoria, capace di lacerare “non rinviando ad alcun ordine ideale o religioso, o a spiegazioni sovrumane, ma alla debolezza stessa, alla fragilità e infine alla distruzione della condizione umana”.
Due esiti che pur nel comune, sodale tentativo di costruire un significato universalistico della Shoah, giungono ad approdi diversi: “l’uno attraverso il messaggio religioso, l’altro per mezzo del filtro o per lo meno dell’interrogazione della ragione”. La “durezza laica” di Levi, diversa dalla religiosità caratterizzante la memoria di Wiesel, è stata testimoniata dallo stesso Wiesel in una sua conferenza tenuta nell’ottobre del 1999 presso l’Università di Friburgo. In questa occasione Wiesel ricorda come Primo Levi “mio amico e compagno” descriva i banalizzatori della memoria come “dei ladri del Tempo [che] si infiltrano attraverso i buchi delle serrature e gli interstizi, e prendono i nostri ricordi senza lasciar traccia”. Fin qui la testimonianza di Primo Levi, sottolineata da Wiesel come “un giudizio molto duro, ma Primo è stato duro in tutti i suoi giudizi. E c’è del vero in tutto questo”.
Per Edith Bruck la “Signora Auschwitz”, la testimonianza attraverso il “dono della parola” è stato, e continua ad essere un compito, un dovere irrinunciabile e insieme una odissea tanto appassionata quanto dolorosa; un infinito ri-iniziare ogni volta quando il riconoscimento da parte dell’Altro si accompagna a incredulità, indifferenza. La testimonianza per Edith Bruck – lungo una affermazione registrata moltissimi anni dopo la conclusione dell’esperienza concentrazionaria da lei patita – è l’espressione di un bisogno costante e incancellabile nel tempo verso se stessa, verso i “sommersi”, coloro che sono rimasti là sepolti nel buio del Lager e verso tutti gli altri, disposti o meno ad ascoltare e a contenere la narrazione (Andreoli, Ciuffi, 2012).
La militanza testimoniale di Edith Bruck è esperienza totalizzante, segnata da una sincerità egoica straordinaria, che la conduce a chiedere aiuto...