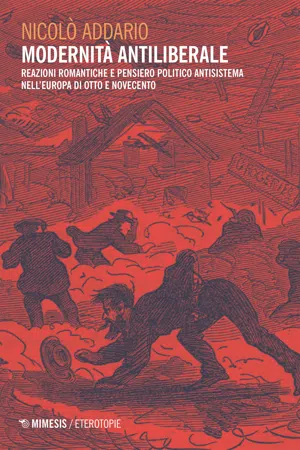![]()
1.
La ribellione romantica
alla ragione illuminista
1.1. Le ambivalenze dell’Illuminismo: J. J. Rousseau e E. Kant
Come capiterà al suo avversario, il romanticismo, pure l’Illuminismo è stato un movimento complesso e sfaccettato, anche se probabilmente si può dire che ogni sua versione sia stata in qualche modo una qualche variante che ruotava intorno a uno stesso pilastro: la “religione della ragione”. Va peraltro rammentato che questo è stato vero soprattutto per l’Illuminismo continentale, quello inglese, infatti, poneva l’accento sulla libertà (intesa per lo più alla Berlin, come “libertà da” forze oppressive esterne alla “società civile”). Tra queste varianti continentali (soprattutto francesi), una, quella di Rousseau, era portatrice di una visione della natura e della moralità dell’uomo che ha avuto una grande influenza e che però, al tempo stesso, conteneva una così profonda ambiguità che può essere considerata a fondamento di successive dottrine così lontane e persino opposte come quella, da un lato, di Kant e Fichte e, dall’altro lato, dei totalitarismi moderni di destra e di sinistra.
L’idea di ragione di questo Illuminismo, ha sostenuto Berlin (1994; 2001; 2009), esercitò una sorta di potere “dispotico” sulla correlata idea di libertà (principalmente sul continente, assai meno in Inghilterra). Essa era una sorta di versione secolare della concezione cristiana secondo cui “servire dio è la libertà perfetta” (una tesi che sembra possa farsi risalire già ad Agostino). Secondo questa concezione, la mia libertà consiste nell’obbedire a qualcuno che riconosco essere ben più razionale di me o che mi indica un ideale o un fine supremo, una Verità che, pur corrispondendo alla mia “vera” natura, ai miei “veri” bisogni, non sono in grado di riconoscere da me stesso. Il presupposto di ciò è che vi sia qualcuno che, per sua propria sapienza o scienza o genio, sappia scoprire la verità del mondo e della storia sul modello delle scienze fisiche e matematiche. L’Illuminismo ha questa certezza: la società, la politica, l’etica sono indagabili alla stessa stregua delle scienze esatte e di esse sono quindi scopribili le “leggi” che le muovono. Chi è in queste condizioni conosce dunque il “bene oggettivo” e di questo si fa forte la politica. Le grandi masse, il popolo, ne è ignaro, anzi è per lo più traviato da superstizioni e da idee sbagliate. Di conseguenza, imporre un tale “bene oggettivo” sugli “altri non vuol dire solo attivare la ragione dormiente all’interno di essi; liberare gli individui è fare per loro proprio ciò che, se fossero razionali, farebbero per proprio conto […]; dunque alcune forme della più violenta coercizione sono equivalenti alla più assoluta libertà” (Berlin 2009, p. 221).
Sono due, dunque, gli assunti metafisici di questa concezione: a) che vi sia un sapere in grado di “scoprire” i veri fini dell’uomo (o della storia, così come possiamo scoprire i “fini” della natura rivelandone l’ordine nascosto); b) che l’uomo abbia un “vero io” il quale, il più delle volte, è subordinato a un “falso io” (questo è, per esempio, quanto sostiene il concetto marxiano di ideologia, per quanto la falsità sia collegata alla posizione di classe). Ed è in questo secondo assunto che prenderanno corpo alcune concezioni dell’uomo che avranno importantissimi sviluppi politici verso direzioni opposte e apparentemente inconciliabili. Secondo Berlin, una tale concezione si può trovare in Hegel e in Marx, così come in Dostoevskij e molti altri. Ma il padre originario è Rousseau, oltre che nel Contratto sociale, specie là dove discute dell’educazione (l’Émile e la Nouvelle Eloïse) e soprattutto nel saggio sull’origine della disuguaglianza.
Questo Rousseau è, innanzitutto, all’origine del sentimentalismo antintellettuale, della buona volontà e della purezza di cuore, del sentimento sincero che mette tutte le cose al loro giusto posto, tanto in politica quanto in questioni morali. Passando per il romanticismo questa concezione arriverà a influenza gran parte del pensiero politico, ma anche e soprattutto artistico e letterario, dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. Egli sembra svalutare la razionalità delle sofistecherie intellettuali, ma la sua tesi, che si presenta come elementare e quasi autoevidente, resta pur sempre un prodotto intellettuale. Un prodotto in verità assai discutibile e che lui pone come una sorta di verità rivelata, un dogma. Il punto sembra essere che o si possiedono, per natura, una certa conoscenza e una certa personalità morale o c’è ben poco da fare. La ragione può assai poco nel tempo breve della politica, mentre si può provare con l’educazione, oppure con le cattive maniere.
Come ben sappiamo, questo in Rousseau è accompagnato, oltre che dall’antintellettualismo (per scoprire la verità non sono necessarie le sofisticate argomentazioni cui tipicamente si abbandonano gli sfaccendati e gaudenti intellettuali parigini), dalla rampogna contro i vizi della civilizzazione che hanno sviato l’originaria saggezza naturale degli uomini. In queste pagine rousseauiane percepiamo come una struggente nostalgia per un tempo in cui gli esseri umani avevano un “cuore incorrotto”, un sentimento che il romanticismo del diciannovesimo secolo eleverà a suo peculiare stile espressivo, volendo con ciò segnalare, in via principalmente simbolica, che per un progresso che forse è inevitabile si sta quasi certamente perdendo qualcosa di prezioso e di desiderabile. In fondo è un’eredità della cultura antiquaria settecentesca. A sinistra questa idea della società matrigna assumerà la veste, apparentemente più sofisticata (nella forma che le darà il marxismo), che tutti i mali vengono dalla società capitalistica, la quale può e deve essere cambiata. In questo cambiamento, Rousseau affidava al Legislatore la funzione, nella fase intermedia, di educare le masse alla futura volontà generale della democrazia diretta; socialisti e comunisti affideranno questa funzione al partito, posto come “avanguardia” (di classe) del futuro che verrà, un futuro che comunque è inscritto nel cammino che la storia ha già intrapreso per conto proprio. L’avanguardia accelera i tempi e anticipa la storia nei suoi programmi: l’utopia sociale non è una “società che non c’è”, è al contrario una società che ci sarà perché è già movimento reale di masse in cammino.
Ma dove porta in realtà quest’idea, antirazionalista e antiutilitarista, della libertà di Rousseau? A una forma di vita come quella adombrata dagli stoici o perseguita dai primi cristiani e da anacoreti, eremiti e monaci medioevali? C’è un’influenza puritana e pietista? Per Berlin, sì. È un’idea che “infetta l’intero diciannovesimo secolo – romanzieri e poeti, storici e uomini pratici – [esaltando] le opposte virtù, la purezza, la sincerità, la bontà naturale, la divina fiamma che brucia più splendente nei cuori dei pubblicani e dei peccatori, nei reietti sociali di Hugo e Dostoevskij, nei ribelli e umanisti di Schiller, negli eroi solitari di Büchner e Ibsen, nei contadini e nei convertiti alla vita semplice creati da Tolstoj, negli innocenti di Henry James; e connota le caratteristiche di quello che nel romanzo umanistico del diciannovesimo secolo sarà appunto il grande nemico: il ricco, il potente, il funzionario – la gente importante” (ivi, pp. 227-28). Da qui la condanna delle diseguaglianze, dei gruppi d’interesse e inoltre, in Rousseau, la proposta per una possibile volontà generale per il bene comune, una proposta che deve essere praticata e diffusa come una “religione civile”. Da qui anche la condanna (morale), nel marxismo, dell’“individualismo” borghese.
Vedremo come qui Berlin probabilmente faccia per certi aspetti un torto a Rousseau, sottovalutando che nel Contratto sociale lui vuole soltanto indagare a quali condizioni questa volontà generale sia possibile e che semmai, pur riconoscendo che su questo non sia affatto chiaro, il vero problema si pone quando ammette di ben sapere che vi sarà una fase in cui gli uomini non saranno pronti a pervenire a tale volontà generale e che, allora, per questa fase servirà un Legislatore che sia capace di educare le masse. Sarà questo il Rousseau dei Giacobini, che si sentiranno autorizzati, proprio in virtù della loro probità morale verso il fine supremo della Rivoluzione, ad abusare forse dello stesso Rousseau. E sarà questo Rousseau giacobino che sarà preso ad esempio dai comunisti (ora marxisti-leninisti).
Ad ogni modo, Berlin insiste: è da qui che discende la dottrina che dobbiamo avere “sia la libertà sia le catene del dovere”, anche queste liberamente scelte da noi stessi. Perciò la volontà generale è la nostra stessa volontà e perciò “modelliamo la nostra natura secondo fini che intuiamo essere gli unici giusti fini per gli uomini” (ivi, p. 232). Questa è, in estrema sintesi, la dottrina di Rousseau secondo Berlin, una dottrina che lo fece diventare un “monomaniaco cronico”, un “fanatico ispirato”, per il quale la ragione è veramente ispirata soltanto quando è animata dal cuore puro del giusto sentimento morale. Una dottrina che discende interamente da una tesi sulla natura umana, che viene posta come una “verità oggettiva” (come se l’etica e la politica fossero scienze descrittive). In tal senso una vera ontologia, una metafisica dell’uomo!
Si tratta di un mito, ovviamente, ma che ha presa: nella realtà empirica non esiste una “volontà pura” in armonia con la natura (e neppure con la dialettica storica della lotta di classe) e dunque capace di sottomettere tutte le passioni e i sentimenti insani che la civiltà e le sue istituzioni avrebbero inculcato negli uomini. Né esiste una natura armonica in cui un buono scopo non si scontri mai con altri scopi ugualmente buoni, così che il conflitto tra i fini umani non sarebbe mai “reale” ma artificiale, o persino un’illusione derivante dall’ignoranza soggettiva procurata dalla società. Così come gli uomini non hanno un loro “vero io” a cui ricorrere per sopprimere la parte inferiore della loro natura, e così liberarne la parte superiore e morale. Naturalmente, se tutto questo fosse vero, allora potremmo creare la società perfetta. Ma è proprio questo a cui si orientano tutte le utopie sociali e politiche del diciottesimo e del diciannovesimo secolo, quelle reazionarie e rivoluzionarie di destra e quelle progressiste e rivoluzionarie di sinistra.
Approfondendo l’analisi, Berlin affonda il coltello nella piaga. Infatti, una volta che – a differenza delle credenze della teologia – si sia deciso che “non un’entità occulta come l’anima, che non fa parte del mondo naturale”, bensì proprio l’uomo naturale sia colui che può e deve realizzare il suo bene qui su questa terra, l’antica giustificazione che “permetteva ad alcuni uomini di torturare e uccidere altri […] perché agli stessi torturati e uccisi veniva attribuita tale richiesta, perché, per quanto ignota ad essi, la loro natura lo richiedeva”, ora, nelle nuove circostanze in cui l’anima è sostituita da uomini in carne e ossa, tutto ciò “pareva aggiungere una forma di beffa particolarmente disgustosa agli ultimi tormenti delle vittime di questo processo ‘liberatorio’”. Ma è stata proprio questa ideologia, conclude Berlin, che “ha giocato una parte importante nelle grandi rivoluzioni del nostro tempo” (ivi, pp. 242-43), da Robespierre a Babeuf, da Marx a Sorel e Lenin, da Mussolini e Hitler ai loro successori. Tutte le versioni della “vera natura del buon uomo comune” – incluse quelle di un De Maistre, di un Nietzsche o di un Dostoevskij – sono solo “torve variazioni sul tema” della concezione di Rousseau, la quale, a sua volta, è in fondo una forma secolarizzata della dottrina medioevale dell’estirpazione delle eresie: la Chiesa, l’unica vera custode dell’anima umana in terra, obbliga l’eretico a espiare gli errori compiuti contro la sua anima immortale, che, appunto, è il “vero io”. E c’è sempre un “bene supremo” di cui qualcuno, la Chiesa o il partito avanguardia, è l’unico detentore e sicuro custode (un punto che approfondirò).
C’è però stato anche un influsso benefico di Rousseau, particolarmente in Kant (che lo dichiara esplicitamente). “In Kant, il dualismo delle due nature è del tutto esplicito: ogni uomo è, per così dire, due persone – da un lato c’è l’io empirico, soggetto ai normali influssi del mondo fisico […]; dall’altro, un io non empirico, trascendente, autonomo, che non ha un comportamento passivo, ma che agisce, ed è capace di elaborare precetti cui liberamente obbedire o non obbedire, e che esso persegue perché vuole seguirli, perché sono quel che sono – dei fini in se stessi, qualcosa da adempiere per il suo bene, e per nessun’altra ragione, perché sono dei fini assoluti. Questo è il preciso contributo di Kant e il fondamento della dottrina romantica dell’uomo il quale si pone così, secondo la definizione di Herder, a mezza strada tra la natura e Dio, tra le bestie e gli angeli, a contatto da un’estremità con il mondo meccanico delle scienze, e dall’altra con il regno spirituale, che gli si rivela solo nei momenti di speciale illuminazione, propria degli esseri spirituali” (ivi, p. 248).
Con questo, peraltro, Kant ebbe il merito di chiarire una cosa del tutto vera e che sino ad allora era invece incompresa, e cioè che un “dovere” non è affatto necessariamente qualcosa che il soggetto desideri, né tanto meno che agire in tal senso debba coincidere col pervenire al piacere o persino alla felicità. Da qui derivano due idee che ebbero grande influenza in seguito. La prima fu quella per cui nel giudicare il vero orientamento morale degli uomini bisognasse guardare al loro disinteresse, che insomma la morale poteva essere veramente tale sono quando ci si spogliava di ogni interesse particolare. La seconda grande idea, che tramite la versione moderata del romanticismo sarà poi tipica del liberismo moderno, è che gli individui sono fini a se stessi, sono sacri proprio in quanto solo i singoli uomini possono essere artefici di valori morali.
Qualcosa di simile si trova probabilmente già in Rousseau, ma soltanto in Kant è detta in modo esplicito e chiaro. E già in questo è presente la condanna per ogni forma di sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. Anche qui, ovviamente ci si può rifare a qualche stoico o epicureo o anche al cristianesimo primitivo (a cui ricorre, per esempio, il curato Meslier nel proporre il suo comunitarismo materialista e ateo, cfr. Onfray 2010). Ma in Kant l’idea è posta in modo del tutto universalista. Nella proposta di Kant, c’è pure dell’estremismo, che farà impazzire i suoi seguaci di filosofia etica della seconda metà del Novecento. L’imperativo morale, infatti, non ha soltanto il problema (praticamente a tutt’oggi insoluto) di come poter individuare, da parte di ogni singolo individuo, un criterio per la sua determinazione e applicazione universale, ma ha anche il problema, che Kant rimarca, che il dovere morale non c’entra per niente con la felicità, mentre c’entra con l’essere degno della felicità, cioè con l’agire spinto da una Volontà Buona, dove è la ragione che ci dice dove stia il bene (non la fede che rifugge dalla ragione, come invece voleva Lutero). In questo c’è un rigorismo assoluto che ricorda certe sette puritane forse più del pietismo...