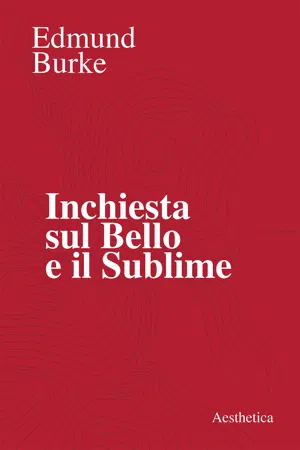![]()
Parte prima
I – La novità
La prima e la più semplice emozione che scopriamo nell’anima nostra è la curiosità. Per curiosità intendo qualunque desiderio abbiamo per ciò che è nuovo16, o qualunque piacere troviamo in esso. Vediamo che i bambini corrono continuamente da un posto all’altro per scoprire qualcosa di nuovo; afferrano con grande slancio e senza esitare nella scelta tutto ciò che cade dinnanzi ai loro occhi; la loro attenzione è attratta da qualunque cosa, poiché ogni cosa ha, in questo periodo della vita, il fascino della novità. Ma poiché quelle cose che ci attirano soltanto per la loro novità non possono dominarci per molto tempo, la curiosità è la più superficiale di tutte le affezioni, e muta continuamente oggetto; la sua avidità è molto viva, ma assai facilmente soddisfatta, e presenta sempre un aspetto di vertigine, di irrequietezza e di ansietà. La curiosità è per sua natura una fonte attivissima: scorre con rapidità su gran parte dei suoi oggetti e subito esaurisce la varietà che generalmente si riscontra nella natura; le stesse cose ritornano frequentemente, e ritornano con un effetto sempre meno gradevole. In breve, i casi della vita, dal tempo in cui ha inizio la nostra conoscenza, non sarebbero in grado di colpire la nostra mente con altre sensazioni che quelle di disgusto e di noia, se molte cose non fossero atte a colpire l’animo mediante altri poteri che non il potere della novità, e risvegliando altre passioni oltre quella della curiosità. Questi poteri e queste passioni saranno considerati al momento opportuno. Ma di qualunque natura siano questi elementi o in base a qualunque principio colpiscano la mente, è assolutamente necessario che essi non vengano applicati a quelle cose che l’uso quotidiano ha invilito e reso familiari e banali. Un certo grado di novità è uno degli elementi indispensabili di ciò che agisce, e la curiosità si unisce più o meno a tutte le nostre passioni.
II – Dolore e piacere
Sembra quindi necessario che, per eccitare le passioni delle persone già adulte, gli oggetti destinati a tale scopo, oltre ad essere in certo grado nuovi, debbano essere capaci di suscitare dolore o piacere per altre cause. Il dolore e il piacere sono idee semplici, non suscettibili di definizione17. La gente non è soggetta a sbagliarsi nei suoi sentimenti, ma sbaglia molto spesso nei nomi che dà loro e nel ragionare intorno ad essi. Molti sono dell’opinione che il dolore nasca di necessità dall’allontanamento di un piacere, poiché ritengono che il piacere sorga dalla cessazione o diminuzione di un dolore. Da parte mia, sono piuttosto propenso a ritenere che il dolore e il piacere, nel loro più semplice e naturale modo di impressionare, abbiano ciascuno una natura positiva, e non debbano affatto dipendere l’uno dall’altro. La mente umana è spesso, e credo che lo sia per la maggior parte del tempo, in uno stato non di dolore e non di piacere, che chiamo stato di indifferenza18. Quando passo da questo stato di indifferenza a uno stato di piacere effettivo, non sembra necessario che debba passare attraverso uno stato intermedio di dolore. Se in tale stato di indifferenza, di quiete, di tranquillità, chiamatela come volete, voi doveste essere improvvisamente rallegrati da un concerto di musica, o supponiamo che un oggetto di belle forme o di colori vivamente brillanti dovesse apparirvi dinnanzi, o immaginate che il vostro odorato fosse deliziato dalla fragranza di una rosa, o che, senza aver sete, voi doveste assaggiare un buon vino o gustare dei dolci senza essere affamati, in tutti i diversi sensi dell’udito, dell’odorato e del gusto senza dubbio trovereste un piacere. Pure se indagassi in che stato fosse la vostra mente prima di questi piaceri, ben difficilmente mi direste che si trovava in uno stato di dolore; o, dopo aver soddisfatto questi diversi sensi con diversi piaceri, direste che sia poi subentrato un dolore, sebbene il piacere sia del tutto finito? Supponete d’altro canto che qualcuno, trovandosi in questo stato di indifferenza, riceva un colpo violento o beva una bevanda amara o che il suo orecchio venga colpito da un suono aspro e stridente; in tutti questi casi non v’è una scomparsa di piacere, eppure si avverte, in ogni senso colpito, un dolore molto ben riconoscibile. Si potrebbe forse dire che il dolore in tal caso traeva la sua origine dalla scomparsa del piacere, di cui prima si godeva, sebbene questo piacere fosse così poco vivo da essere percepito solo nel momento in cui è scomparso. Ma tale sottigliezza non mi sembra riscontrabile in natura. Poiché, se prima del dolore io non sento alcun piacere effettivo, non ho ragione di ritenere che tale piacere esista, dal momento che il piacere è tale solo quando viene percepito. Analogamente, e con ragione, si può dire avvenga del dolore. Non posso convincermi che piacere e dolore siano semplici relazioni che possono esistere solo come contrari, ma ritengo di poter chiaramente distinguere l’esistenza di dolori e piaceri positivi, del tutto indipendenti l’uno dall’altro. Nessuna percezione è per me più certa di questa. Non v’è nulla che appaia al mio pensiero più chiaro dei tre stati di indifferenza, di piacere e di dolore. Posso percepirne ciascuno senza avere alcuna idea della sua relazione con gli altri due. Se uno, dolorante per una colica, per cui prova un dolore reale, viene steso sulla ruota di tortura, sentirà un dolore molto maggiore; ma questo dolore determinato dalla ruota deriva forse dalla scomparsa di un piacere? L’attacco di colica può essere un piacere o un dolore, a seconda di come ci piace considerarlo?
III – Differenza fra la scomparsa del dolore e piacere positivo
Porteremo il problema ancora un passo più in là e cercheremo di stabilire che il dolore e il piacere non soltanto non sono dipendenti necessariamente dalla loro reciproca diminuzione o scomparsa, ma che in realtà la diminuzione o la cessazione del piacere non agisce come un dolore positivo, e che la scomparsa o la diminuzione del dolore, nei suoi effetti, ha pochissima rassomiglianza col piacere positivo19.
La prima di queste affermazioni sarà, credo, molto più facilmente accettata perché è ben evidente che il piacere, quando ha compiuto il suo corso, ci lascia nello stato in cui ci ha trovato. Il piacere d’ogni genere soddisfa prontamente, e quando è finito, ricadiamo nell’indifferenza, o piuttosto in una dolce tranquillità, che ha in sé il gradevole colore della sensazione precedente. Ammetto che a prima vista non sia così evidente che la cessazione di un grande dolore non assomigli a un piacere positivo; ma ricordiamoci della condizione in cui si trovava la nostra mente nello sfuggire a un pericolo imminente o nel momento in cui ci liberavamo dalla crudezza di un dolore atroce. In tali occasioni abbiamo trovato, se non sbaglio, l’animo nostro ben lontano dal piacere effettivo; ossia in uno stato di grande sobrietà, improntata a un s...