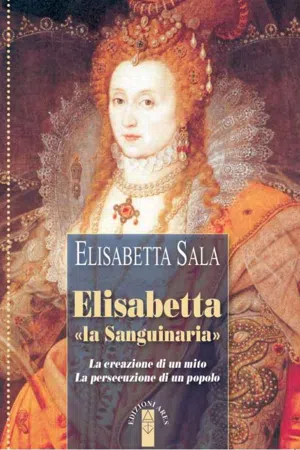![]()
1. Il Re bambino
La politica inglese del tempo era essenzialmente giocata da fazioni di Corte e coalizioni di Palazzo. La maggioranza al governo era di fatto il gruppo che, con mezzi più o meno discutibili, riusciva a riscuotere e a conservare il favore del sovrano. L’opposizione si trovava nell’ombra e rischiava di rimetterci la testa da un momento all’altro; per un ministro in carica che cadeva in disgrazia, poi, il patibolo non era che la sorte più probabile. Entrare in politica era dunque un gioco estremamente pericoloso; d’altro canto, come in tutti i tempi, poteva rendere immensamente ricchi e potenti.
Ora, quando fu chiaro a tutti che Enrico VIII era agli ultimi, le fazioni di Corte si scatenarono in una lotta all’ultimo sangue per stabilire a chi dovesse spettare la reggenza al trono: il partito vincitore avrebbe di fatto governato il Paese in tutto e per tutto, almeno fino alla maggiore età del giovanissimo Edoardo e magari anche dopo. Si trattò, naturalmente, di una lotta senza esclusione di colpi in cui nessuna delle parti, per giunta, aveva princìpi morali da difendere.
Come sempre, due erano gli schieramenti: uno conservatore, uno progressista. I progressisti erano riformisti in politica e in religione e sostenitori di una linea filoprotestante; i conservatori erano coloro a cui più era spiaciuto abbandonare la Chiesa di Roma, ma che erano ormai divenuti accaniti sostenitori della supremazia regia e dell’esproprio statale dei beni ecclesiastici. Non si può, dunque, parlare di un partito filocattolico, ma, piuttosto, di un partito antipapale che non voleva procedere oltre con le riforme politiche e religiose e che osteggiava il protestantesimo. Re Enrico, dalla poltrona nella quale ormai giaceva immobile, giocò a concedere e ritirare il suo appoggio all’una o all’altra fazione quasi fino all’ultimo, spesso flirtando con i protestanti di oltremare, spesso frenando ulteriori riforme religiose in casa propria.
Nel momento in cui morì, il 28 gennaio 1547, l’ago della bilancia si trovava decisamente a favore del partito protestante, capeggiato da Edward Seymour, conte di Hertford, fratello della defunta regina Jane e zio del piccolo Edoardo. Grazie all’ultima delle sei mogli, Katherine Parr, e forse a parziale insaputa del padre, il principino era intanto stato educato da precettori rigorosamente calvinisti. Seymour e i suoi alleati avevano per il momento sconfitto i loro principali avversari politici conservatori, in testa a tutti il vescovo Stephen Gardiner e la potente e aristocratica famiglia Howard, ora caduta in disgrazia.
Grazie alla prodigalità di Enrico VIII, e al suo amore per le guerre europee, suo figlio ereditava un Regno sull’orlo del fallimento. Ciò non sembrò costituire un problema per la cricca che si ritrovò al governo, poiché il loro programma politico prevedeva soltanto due punti: uno, conquistare il potere distruggendo gli avversari; due, cercare di arricchirsi a più non posso. Gli storici sembrano concordi sul fatto che, nell’insieme, il regno di Edoardo sia stato un «disastro sociale: nuovi saccheggi di proprietà private da parte dello Stato; miseria in rapido aumento; malgoverno generale; guerre fallimentari [...]; crisi finanziaria nazionale che condusse quasi alla bancarotta; ulteriore svalutazione di una moneta già svalutata; scontento e tumulti dappertutto»1.
Fu dunque anche per opportunismo che il nuovo governo optò per una politica di protestantizzazione forzata: in sostanza, ciò significava procedere ancora oltre con la politica degli espropri dei beni ecclesiastici e corporativi. Alle esplicite promesse di Enrico VIII riguardo un futuro roseo, anzi, aureo, per tutti i suoi amati sudditi era seguita una profonda delusione, un senso di tradimento che non fu facile smorzare2.
Ma Thomas Cranmer, arcivescovo di Canterbury fin dal 1533, il luterano e ora anche un po’ zwingliano-calvinista, pieghevole come un fuscello, non stava più in sé dalla gioia: finalmente era libero di portare la Chiesa anglicana verso la vera religione. Nonostante, infatti, essa fosse stata ai suoi occhi ripulita da molte superstizioni, come il monachesimo, le reliquie, quasi tutte le feste religiose e i pellegrinaggi più famosi; nonostante il diritto canonico e la supremazia papale fossero stati ripudiati; nonostante Enrico VIII avesse accettato di pubblicare la Bibbia protestante in inglese nella traduzione di Tyndale e Coverdale: nonostante tutto ciò, erano ancora molti, troppi secondo l’arcivescovo rinnegato e i suoi, i residui papisti a cui Enrico VIII era rimasto affezionato. La Messa cattolica in latino e i paramenti sacri erano rimasti, infatti, praticamente intoccati e le cerimonie erano state «purificate» solo in parte; Cristo continuava a restare realmente presente nel pane e nel vino consacrati; il celibato ecclesiastico e la gerarchia episcopale erano stati mantenuti e così, più o meno, i sette sacramenti; in più c’era tutto un alone di mistero intorno al purgatorio e alla venerazione dei santi, che non si capiva bene se fossero parte del credo anglicano oppure no, mentre re Enrico stesso era decisamente contrario alla giustificazione attraverso la sola fede. Anzi: nel preambolo al suo testamento il sovrano scismatico aveva voluto includere le tradizionali preghiere di intercessione alla Vergine e ai santi, aveva lasciato seicentosessantasei sterline (un istitutore non ne guadagnava neppure venti l’anno) ai poveri, perché pregassero per la sua anima, e altre seicento a due sacerdoti, che celebrassero per lui solenni Messe di suffragio nella cappella reale di Windsor.
Il regime enriciano aveva salvato un’immagine di facciata anche davanti al popolo: aveva continuato ad affermare di essersi distaccato solo dal papismo, non dal cattolicesimo, e molti gli avevano creduto. Nonostante il gravissimo scisma, infatti, la Chiesa anglicana continuò (e continua) a proclamarsi addirittura parte di quella cattolica: semplicemente, il Re era diventato una specie di collega del Papa, anzi, del vescovo di Roma, e aveva proceduto a una serie di riforme autonome. Che poteva fare, se non adeguarsi, un popolo che da una dozzina d’anni si sentiva ripetere ogni domenica, e dagli uomini più colti del Regno, che il Papa era l’Anticristo e i monaci i suoi superstiziosi e lussuriosi seguaci? Per il resto, a parte la scomparsa totale degli ordini religiosi, la vita di parrocchia somigliava ancora a quella dei secoli precedenti e anche la liturgia era pressoché la stessa. Il popolo era stato raggirato, ma ancora riteneva che le cose non fossero poi cambiate di molto: sui dogmi per nulla chiari, ma proclamati a gran voce dai più autorevoli vescovi, non pretendeva certo di avere voce in capitolo.
Ora la questione si fece ben differente. La rapacità di Seymour e dei suoi, unita allo zelo religioso di Cranmer, non preludeva a nulla di buono.
Re Harry fu solennemente sepolto il 15 febbraio 1547; il piccolo Edoardo fu solennemente incoronato cinque giorni dopo. Durante la cerimonia di incoronazione, consuetudine voleva che il sovrano prestasse il tradizionale giuramento di difendere le libertà della Chiesa: «Anglicana ecclesia libera sit» (la Chiesa di Inghilterra sia autonoma»), recitava la Magna Charta del 1215 per bocca di re Giovanni e in nome di tutti i suoi successori. Orbene, tale giuramento fu semplicemente omesso, il che non poteva non suonare come una vaga minaccia per i pochissimi che ancora ritenevano che la Chiesa potesse godere di qualche libertà3.
Tanto per cominciare, zio Seymour, che alla morte di Enrico era semplicemente uno dei suoi sedici esecutori testamentari, si autonominò ora duca di Somerset e unico protettore del piccolo Re, concentrando così nelle proprie mani tutto il potere politico. Poi fissò per il mese di novembre la convocazione del primo Parlamento del Regno, che avrebbe introdotto riforme in campo statale ed ecclesiastico. La direzione in cui si sarebbe andati era ovvia: tutti sapevano che in casa del Protettore, quali che ne fossero le motivazioni, il culto praticato era quello calvinista; poco dopo, anzi, Somerset iniziò a corrispondere regolarmente con Calvino in persona.
Ma Cranmer non poteva certo attendere fino a novembre: il suo zelo riformatore, che davanti a Enrico VIII era stato faticosamente represso, non vedeva l’ora di uscire allo scoperto. Come arcivescovo di Canterbury, e forte dell’ascendente che esercitava sul giovane sovrano, egli cominciò a muoversi autonomamente, senza l’autorizzazione del Parlamento. La sua prima mossa fu la pubblicazione, in luglio, di un libro di dodici omelie ufficiali, alcune delle quali erano di stampo chiaramente protestante e, puntualmente, non mancavano di attaccare la religiosità tradizionale come gravemente peccaminosa.
Di fatto, però, finché il Parlamento non avesse avuto il tempo di modificare le leggi enriciane sull’eresia, il contenuto delle omelie rimaneva ufficialmente eretico, benché ufficiosamente approvato dal governo; ci fu dunque chi giocò questa carta per opporsi strenuamente alla loro pubblicazione.
Ricordate Stephen Gardiner? Vescovo di Winchester dal 1531, era stato uno degli strumenti più utili a disposizione di Enrico VIII per la questione del divorzio: per questo si era più volte scontrato con san John Fisher. Scomunicato insieme a Cranmer nel 1533 per aver preso parte all’ignominoso processo di Dunstable che aveva invalidato il matrimonio aragonese, nel 1534 aveva sottoposto personalmente ai fedeli della sua diocesi il giuramento all’atto di successione, mentre l’anno seguente, subito dopo le esecuzioni di Fisher, More e dei primi monaci, si era messo al lavoro per forgiare un fondamento teologico per la supremazia regia e il ripudio della sede papale, producendo l’opera apologetica di più ampio respiro di tutto il regime enriciano, il De vera obedientia. Ebbene: poiché Gardiner si opponeva al protestantesimo almeno quanto al primato di Roma, la causa dei conservatori era ora in mano a quest’uomo. «Ai veri cattolici [...], nel 1547, avrebbe giustamente potuto venire la tentazione di disperare»4. E comunque, anche se legalmente aveva ragione, non fu un problema per nessuno far accomodare Gardiner, ora del tutto isolato politicamente, nella prigione di Fleet.
Quell’estate, sempre senza la necessaria autorizzazione da parte del Parlamento, Cranmer organizzò una visita episcopale di tutte le diocesi del Regno per accertarsi dello stato delle parrocchie; in quell’occasione i parroci ricevettero le nuove ingiunzioni dell’arcivescovo che abolivano la recita del rosario, proibivano formalmente tutte le processioni e i pellegrinaggi e imponevano di distruggerne tutte le mete, insieme a tutte le immagini sacre, scultoree o pittoriche, e a tutte le vetrate. La gente ne fu esterrefatta. «Le immagini rimosse facevano letteralmente parte della struttura della vita ecclesiastica da centinaia di anni. Erano familiari ai parrocchiani ed erano fonte di orgoglio locale, oltre che di lavoro»5. «Persino nella Zurigo di Zwingli le vetrate erano state risparmiate: nessuno aveva mai seriamente ritenuto che ci si potesse inginocchiare davanti alle immagini che esse riportavano per venerarle»6. Le ingiunzioni di Cranmer imponevano altresì a ogni parrocchia di acquistare le nuove Omelie e a ogni parroco di proclamarle tutte le domeniche.
Poi, finalmente, in novembre, si aprì il Parlamento. Attraverso le sue leggi il governo, per prima cosa, si lanciò all’attacco dei pochi beni ecclesiastici rimasti.
Perché, era rimasto qualcosa? – direte voi. Erano rimasti i cosiddetti chantries, ossia i lasciti testamentari che molti fedeli in punto di morte destinavano alla Chiesa affinché celebrasse per loro messe di suffragio e aiutasse i poveri, proprio come aveva fatto Enrico VIII.
Qui si apre il discorso complesso del purgatorio e della prospettiva cattolica della vita e della morte. Pur non essendo certo questa la sede per una trattazione dell’argomento, è però necessario sottolineare alcuni brevi punti. Come Hilaire Belloc non mancò di far notare, è impossibile parlare di protestantesimo senza conoscere il cattolicesimo, cioè la religione da cui i cosiddetti riformatori si staccarono in modo tanto violento7.
Afferma il Catechismo che «Coloro che muoiono nella grazia e nell’amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la loro morte, a una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del Cielo»8. Già che ci siamo, precisiamo che il purgatorio non è affatto, come diversi pensatori pensano, e parecchi insegnanti insegnano, un’invenzione della Chiesa medievale. Il Concilio di Lione, nel 1274, non fece che darne la formalizzazione ufficiale, ma esso è da sempre parte della dottrina cristiana.
In che cosa consista esattamente tale purificazione non è dato di sapere. Nelle Scritture diversi sono i cenni a un «fuoco purificatore»9 e appare piuttosto sensato pensare che si tratti di un luogo di sofferenza, anche se non paragonabile a quella dell’inferno.
Tra Medioevo e Rinascimento i predicatori facevano a gara per cercare di rappresentare vividamente ai fedeli il purgatorio come luogo fisico. In quello immaginato da Dante, come sappiamo, le anime sopportano la pena – simile a quella infernale – con entusiasmo, ansiosi di espiare i peccati e di essere ammessi alla gloria del paradiso; poiché la grande differenza rispetto all’inferno, ovviamente, è che in purgatorio la sofferenza avrà un termine e darà luogo alla beatitudine eterna nel momento in cui tutti i peccati commessi saranno espiati e come consumati insieme con la pena a essi corrispondente.
Più si riteneva intensa la temporanea sofferenza, dunque, più era importante che il passaggio attraverso il purgatorio fosse il più veloce possibile: i moribondi contavano moltissimo sull’aiuto che, una volta defunti, avrebbero ancora potuto ricevere dai vivi. Ma che senso aveva, e che senso ha a tutt’oggi, che le anime del purgatorio possano essere aiutate da questo mondo? Quali opere di bene si possono compiere per aiutarle?
L’opera buona per eccellenza è, naturalmente, la preghiera, la settima opera di misericordia spirituale, più potente di ogni azione umana; il sacrificio di espiazione per antonomasia, poi, è il sacrificio di Cristo, il solo che dona la salvezza, rinnovato in ogni Messa di suffragio.
Ebbene, i lasciti avevano esattamente questo significato: erano opere buone che il morente compiva in extremis, appena prima di lasciare la vita terrena. Attraverso il suo lascito i vivi avrebbero potuto pregare per lui e offrire Messe per la sua anima. Ma il fatto stesso di poter partecipare a quelle preghiere e a quelle Messe avrebbe portato abbondanti frutti spirituali anche a loro. In questo sistema organico, dunque, il morente era al tempo stesso fruitore e operatore di bene. I congiunti del defunto, d’altro canto, non si ritrovavano completamente impotenti e disarmati di fronte alla morte del loro caro: per lui potevano fare ancora molto e potevano anche chiedergli di pregare a sua volta per la salvezza delle loro anime. Sul baratro della morte si stendeva così il ponte della preghiera vicendevole.
Ma i chantries, di fatto, avevano anche altre funzioni, fondamentali nella vita comunitaria del tempo. Essi permettevano a ogni parrocchia di gestire meglio anche tutte le altre opere caritative, nonché di portare avanti meglio la vita quotidiana della parrocchia stessa: spesso i lasciti erano sottoforma di piccoli appezzamenti di terreno la cui rendita permetteva di mantenere cappellani che, oltre a dir Messa per i defunti, aiutavano il parroco nelle numerose funzioni sacramentali e assistenziali e facevano anche da maestri ai figli dei poveri. I parrocchiani benestanti facevano costruire cappelle di famiglia ai lati della chiesa parrocchiale e alle Messe in loro suffragio poteva partecipare chiunque. Quasi sempre, inoltre, i chantries permettevano di assistere i poveri e anche di aprire piccole scuole di alfabetizzazione; in alcuni casi, addirittura, di fondare grammar schools parrocchiali, l’equivalente (ma notevolmente più pesante) dei nostri licei classici. Erano opere buone, queste, che il testatario aveva forse trascurato di compiere in vita ma che compiva mentre la sua anima si trovava in purgatorio, il che gli avrebbe certo abbreviato la pena.
Per tutto il Medioevo, e in tutta Europa, anche l’elemosina ai poveri data da vivi era in realtà legata alla medesima funzione. Un patto sottointeso prevedeva che il povero, non potendo esprimere la propria gratitudine in altro modo, pregasse per chi era generoso con lui; ed era ben noto come Dio ascoltasse volentieri le preghiere dei poveri. Per questo, ai funerali, una parte dei soldi investiti per la cerimonia andava sempre ai più derelitti: perché pregassero per l’anima del defunto10. In quest’ottica i poveri erano una «forza di preghiera perpetua» e tutti sentivano l’elemosin...